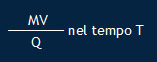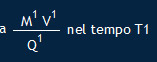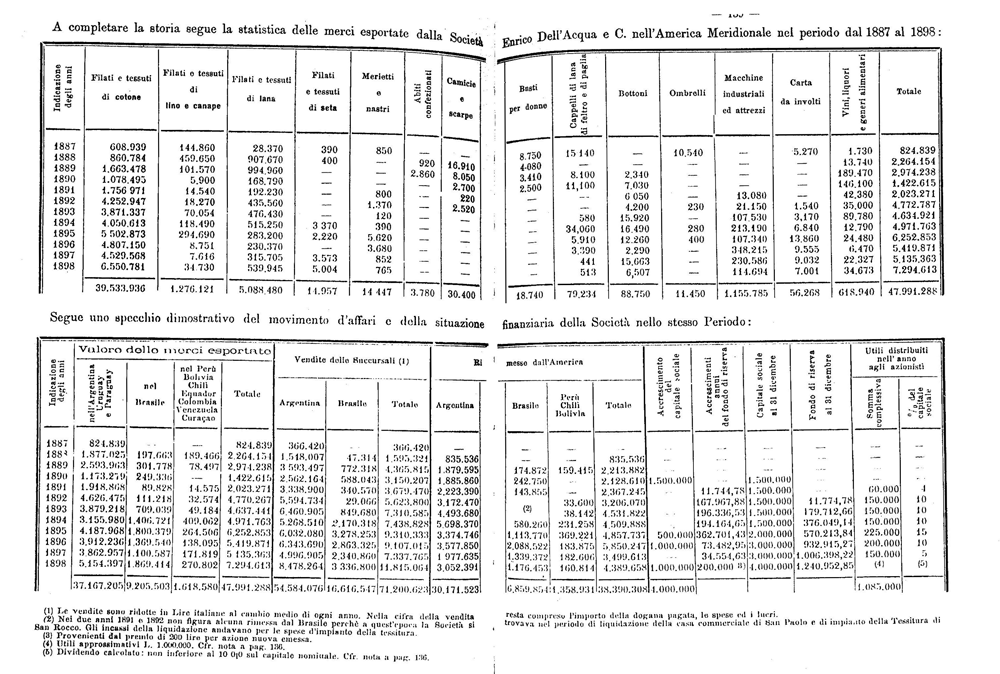Intorno al concetto di reddito imponibile e di un sistema di imposte sul reddito consumato. Saggio di una teoria dedotta esclusivamente dal postulato dell’uguaglianza
«Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino», 1911-1912, pp. 209-213
Saggi sul risparmio e l’imposta, Einaudi, Torino, 1941, pp. 1-165
I
Reddito guadagnato e reddito realizzato (consumato).
I due concetti in rapporto alle cose ed alle persone
Suppongo noto il concetto del reddito elaborato dal Fisher nella sua opera The nature of capital and income. Reddito per l’uomo è il flusso dei godimenti che egli ha durante un certo periodo di tempo. Noi possiamo distinguere cioè il fondo di ricchezze che esistono ad un dato momento a disposizione dell’uomo; e il flusso dei servizi che l’uomo riceve durante un certo periodo di tempo dal sovradetto fondo. In altri termini il capitale è una massa (quantità) di ricchezze esistente in un dato momento del tempo; il reddito è il flusso dei servizi che l’uomo trae dal capitale durante un certo periodo di tempo. Dal capitale o fondo terra l’uomo ricava il reddito di 1.000 lire all’anno di frutti in perpetuo; dal capitale casa si ricavano 1.000 lire di reddito all’anno per 50 anni, se la vita della casa è di 50 anni; dal capitale cavallo 100 lire all’anno di redditi di cavalcature e trasporti durante 6 anni; – dal capitale vestito un servizio di abbigliamento del valore di 40 lire pel primo anno e 20 lire pel secondo anno; dal capitale pane il reddito di 10 centesimi di cibo durante un giorno. Questo reddito dicesi «realizzato» in quanto l’uomo gode i servizi che si «distaccano» dal capitale durante un certo periodo di tempo, senza preoccuparsi se alla fine del periodo il capitale abbia il medesimo valore che aveva all’origine. Gode l’uso della casa per un anno, uso che vale 1.000 lire, senza preoccuparsi che la casa abbia alla fine dell’anno lo stesso valore che al principio, anzi ben sapendo che non è così, essendosi la casa durante l’anno logorata ed essendo alla fine più vicina d’un anno alla sua distruzione (che avverrà dopo 50 anni dalla costruzione) di quanto non fosse al principio. Gode i servizi di cavalcatura e trasporto del capitale cavallo per un anno, ben sapendo che alla fine dell’anno al cavallo rimarranno non più 6 ma 5 anni di vita, e, il suo pregio sarà quindi diminuito; gode per un giorno il servizio «nutrimento» del capitale pane ben sapendo che alla fine del giorno il capitale pane più non esisterà.
Il reddito «realizzato» si contrappone al reddito «guadagnato» in quanto questo è il reddito che un capitale può dare senza alterazione nel suo valore. Il reddito guadagnato è uguale al reddito realizzato meno il deprezzamento e più l’apprezzamento od aumento di valore intervenuto nel frattempo nel capitale. Così per la casa della durata di 50 anni, è reddito realizzato il fitto netto di 1.000 lire che la casa dà ogni anno al suo proprietario; è reddito guadagnato invece il fitto netto di 1.000 meno il deprezzamento di 85 lire verificatosi nell’anno. Supponendo che la casa valesse 18.300 lire al principio dell’anno (valore attuale al 5 di una annualità di 1.000 lire nette all’anno per 50 anni futuri), se il proprietario consuma nel primo anno tutte le 1.000 lire di fitto, alla fine dell’anno si troverà ad avere un capitale del valore di sole 18.115 lire, che è il valore attuale al 5 di una annualità di 1.000 lire nette all’anno per 49 anni futuri. Se egli quindi vuole conservare intatto il suo capitale di 18.300 lire, deve prelevare dal reddito realizzato di 1.000 lire la somma di L. 85 e metterla a frutto, accrescendola, all’interesse composto del 5%, con successive quote di prelievo in ognuno degli anni futuri, in guisa che alla fine del 50mo anno, quando la casa per vetustà varrà zero, egli abbia ricostrutto il capitale originario di 18.300 lire.
Se 1.000 lire sono il reddito «realizzato», 1.000 lire meno il deprezzamento di 8, ossia 915 lire; sono il reddito «guadagnato». Ove però alla fine dell’anno si preveda che nell’anno seguente il fitto crescerà di un decimo passando a 1.100 lire, allora essendo preveduta una successione futura di 49 annualità di reddito non più di 1.000 ma di 1.100 lire, il valore attuale alla fine del primo anno diventerà di 18.215 + 1.821,50 ossia di 20.036,50 lire. Il reddito «realizzato» di questo primo anno sarà sempre di 1.000 lire (salvo a diventare di 1.100 nei successivi anni); ma il reddito «guadagnato» sarà di 1.000 reddito realizzato –85 deprezzamento intervenuto nell’anno +1.821,50 apprezzamento od aumento di valore capitale pure intervenuto nell’anno, ossia un totale di lire 2.736,50. Per chiarezza potremo chiamare le 915 lire di «frutti» netti, dedotto il deprezzamento, reddito «guadagnato in senso stretto». Questo, insieme con le 1.821,50 lire di apprezzamento, ossia L. 2.736,50 sarà il reddito «guadagnato in senso proprio» o »guadagnato» senz’altro.
Il reddito «realizzato» è un dato primo, perché non dipende da calcoli e da ipotesi di saggi d’interesse; bensì da avvenimenti quali realmente si verificano: il prezzo di mercato della messe di un campo, il fitto corrente di una casa, il prezzo d’un vestito, il prezzo di un pane, il nolo di un cavallo per un anno. Il reddito «guadagnato» è un dato derivato. Noi non lo conosciamo, se non abbiamo il dato primo del reddito «realizzato»; e se contemporaneamente non conosciamo, per deduzione da un saggio di interesse e da un periodo noto di durata, il valore del capitale originario, e se non possiamo calcolare, per via di raffronti e di calcoli, il deprezzamento o l’apprezzamento che il capitale subisce durante un certo periodo di tempo.
Le due quantità coincidono, quando il capitale ha durata perpetua, e il saggio d’interesse è supposto invariabile. Allora il campo che rende 1.000 lire, supponendo un saggio di interesse del 5%, vale in capitale 20.000 lire; 1.000 lire sono reddito «realizzato», frutti che ogni anno si distaccano dalla terra madre; e 1.000 lire sono reddito «guadagnato» perché non v’è deprezzamento da dedurre od apprezzamento da aggiungere, rimanendo sempre il valor capitale invariato in lire 20.000. Ma casi rarissimi.
Fin qui si è parlato di reddito «realizzato» e «guadagnato» rispetto alle diverse cose feconde di reddito. Ma la stessa distinzione può farsi rispetto alle persone fisiche che posseggono quelle cose. Anzi è questa la distinzione più interessante, la sola interessante per noi, essendoché le imposte sono pagate non dalle cose ma dalle persone fisiche. Almeno questa è l’ipotesi fondamentale che, senz’altro ripeterla, si assumerà in tutte le cose discorse in seguito. Reddito «realizzato» si dirà allora la massa (flusso) dei servizi della ricchezza goduti dall’uomo durante un certo periodo di tempo; in altre paro e le 1.000 o 10.000 o 20.000 lire consumate dall’individuo durante, ad es., l’anno finanziario, sia che siano uguali al reddito «realizzato» del capitale proprio dell’individuo, sia che siano minori, perché l’individuo ha creduto opportuno di risparmiare una parte dei redditi che nell’anno la sua ricchezza gli ha largito, sia che siano maggiori, perché l’individuo ha consumato, oltre ai redditi, parte altresì del capitale iniziale. Ed è corretta questa maniera di concepire il reddito «realizzato» rispetto alla persona perché la quantità risparmiata non è realizzata per la persona, la quale anzi rinuncia a trarne un godimento qualsiasi; e il capitale consumato diventa, col consumo, reddito, trasformandosi in un flusso di godimenti che l’individuo si procaccia. Reddito «guadagnato» invece per l’individuo sarà il reddito «realizzato» ossia la ricchezza consumata più l’aumento verificatosi durante il periodo considerato nel valore del patrimonio o capitale posseduto al momento iniziale (aumento che può essere risparmio nel senso comune della parola, compiuto con parte dei frutti della ricchezza ovvero aumento di valore del patrimonio) e «meno» la diminuzione di valore del patrimonio rispetto al momento iniziale (diminuzione dovuta a logorio oggettivo od a consumo fattone dal proprietario).
Tizio, a cagion d’esempio, ha all’inizio dell’anno 1912 un patrimonio del valore di L. 100.000. Questo valore è stato ottenuto, sapendo in primo luogo che Tizio ne ricava un frutto annuo netto di 6.000 lire (raccolti agrari, fitti di casa, profitti di impresa industriale), che è il reddito «realizzato» del patrimonio, in quanto è il flusso dei servizi resi dal patrimonio (capitale) durante l’anno. Però Tizio, il quale si preoccupa di conservare «intatto» il valore del patrimonio iniziale, sa che, volendo raggiungere tale intento, non può consumare tutte le 6.000 lire di frutti netti «realizzati» ma deve dedurne 1.000 lire per provvedere alle riparazioni al fabbricato logorantesi via via od a rinnovare le piantagioni o le macchine, ecc. ecc. Il reddito «guadagnato» rispetto al patrimonio sarà solo di 5.000 lire; che appunto al 5% corrispondono ad un patrimonio o capitale costante di 100.000 lire.
Avendo calcolato il reddito «realizzato» e quello «guadagnato» rispetto al patrimonio di Tizio, passiamo a calcolarlo rispetto a Tizio in persona, cosa, ripetesi, unicamente interessante per noi. Rispetto al reddito guadagnato non v’è differenza dal calcolo precedente. Tizio, volendo mantenere intatto il suo patrimonio iniziale di 100.000 lire, non può considerare come «guadagnato» nulla più delle 5.000 lire sovraddette. Invece il reddito «realizzato» per Tizio sarà la ricchezza da lui effettivamente consumata; e questa potrà essere di 3.000 lire sole ed allora si dirà che ha risparmiato la differenza fra le 5.000 lire guadagnate e le 3.000 sue, ossia 2.000 lire; onde il capitale alla fine dell’anno sarà divenuto di 100.000 + 2.000 = 102.000 lire. Ovvero egli può consumare tutte le 5.000 lire guadagnate ed il suo capitale rimarrà invariato e coincideranno i due redditi; ovvero può consumare 10.000 lire e queste che compongono il reddito «realizzato» saranno costituite da 5.000 lire di reddito guadagnato più 5.000 lire di consumo del capitale originario che si troverà perciò ridotto a 95.000 lire alla fine dell’anno. Insomma il reddito «realizzato» è un fatto: 3.000 o 5.000 o 10.000 a seconda che Tizio più o meno consuma. Il reddito «guadagnato» è un tipo; ed equivale a ciò che Tizio potrebbe consumare (5.000 lire) se volesse mantenere il suo capitale intatto a 100.000 lire. Il primo rappresenta ciò «che è», il secondo ciò che dovrebbe essere se tutti gli uomini fossero fatti in modo da volere sempre ed unicamente conservare i patrimoni iniziali. Se noi indichiamo con Rr il reddito «realizzato», con Rg il reddito «guadagnato», con Cc.i. il «consumo del capitale esistente all’inizio del periodo», diremo che il reddito realizzato differisce dal guadagnato per ciò che:
L. 3.000 Rr + 2.000 risparmio = L. 5.000 Rg
L. 5.000 Rr + 2.000 risparmio = L. 5.000 Rg
L. 10.000 Rr – 5.000 risparmio Cc.i = L. 5.000 Rg
Il reddito guadagnato è sempre uguale al reddito realizzato più il risparmio e meno il consumo del capitale originario.
L’esempio addotto potrebbe essere complicato, supponendo che siano diverse le fonti di reddito per Tizio; ma sarebbe complicazione puramente aritmetica, che non porta alcuna difficoltà; ovvero supponendo che il patrimonio di Tizio subisca un aumento di valore durante il 1912 (per semplicità ed evitare calcoli di interessi supporremo che ciò accada al 31 dicembre 1912), perché si prevede che durante il 1913 ed anni seguenti il reddito «realizzato» del patrimonio salirà da 6.000 a 7.000 lire ed il «guadagnato», ossia ciò che risulta deducendo la quota di logorio di 1.000 lire necessaria a mantenere intatto il valore iniziale al principio d’ogni anno, da 5.000 a 6.000 lire. È evidente che in siffatta ipotesi il valore del patrimonio da 100.000 (capitale corrispondente ad un reddito perpetuo di 5.000 lire annue) sale a 120.000 lire (capitale corrispondente ad un reddito perpetuo di 6.000 lire annue). Tizio «durante» il 1912 ha dal patrimonio un «realizzo» sempre di 6.000 lire, che sono i frutti effettivamente distaccatisi dal fondo; ma ha un «guadagno» di 5.000 lire che sono il reddito guadagnato in senso stretto come sopra, più le 20.000 di aumento del valor capitale del patrimonio. Infatti, se egli volesse soltanto conservare intatto il valore iniziale del patrimonio, – ipotesi fondamentale per il calcolo del reddito guadagnato – egli potrebbe consumare le 5.000 lire di reddito guadagnato in senso stretto ed ancora le 20.000 lire di aumento di valore; ed avrebbe sempre alla fine dell’anno un patrimonio di 100.000 lire come aveva in sul principio.[1] Onde il reddito «guadagnato» riferito al patrimonio di Tizio, è uguale al reddito «realizzato» di 6.000 lire, meno il logorio fisico di 1.000 lire, più l’aumento di valore intervenuto nel frattempo, di 20.000; in tutto 25.000 lire.
Passando a considerare i due concetti rispetto alla persona di Tizio, troviamo che il reddito «guadagnato» è ancora di 25.000 lire, come s’è calcolato sopra. Se infatti Tizio vuole conservare il suo patrimonio intatto in 100.000 lire, né crescendolo né diminuendolo, egli potrà consumare appunto 25.000 lire. Il reddito «realizzato» risulta di nuovo dal fatto puro e semplice della quantità di ricchezza da lui consumata, 3.000 o 5.000 o 25.000 o 30.000 lire. Non importa affatto che egli consumi meno o più del reddito guadagnato in senso stretto o in senso proprio, o conservi appena il capitale originario o persino lo diminuisca. Il reddito realizzato è dato dal fatto dei suoi consumi e – indicando, oltrechè con le notazioni già dette sovra i concetti espressi, con Ic.i. l’«incremento di valore del capitale esistente all’inizio del periodo» – differisce dal reddito guadagnato per ciò che:
a) L. 3.000 Rr + 2.000 risparmio + 20.000 Ic.i = 25.000 Rg
b) L. 5.000 Rr + 2.000 risparmio + 20.000 Ic.i = 25.000 Rg
c) L. 15.000 Rr + 2.000 risparmio + 20.000 Ic.i = 25.000 Rg
d) L. 30.000 Rr + 2.000 risparmio + 20.000 Ic.i = 25.000 Rg
Nel caso (a) Tizio non solo ha cresciuto nell’anno il valore del suo patrimonio delle 20.000 lire di aumento verificatosi, per così dire, spontaneamente nel valore stesso, ma di altre 2.000 lire risparmiate; nel caso (b) s’è contentato di veder crescere il suo patrimonio per l’incremento di valore; nel caso (c) non ha fatto risparmii ed oltre ai frutti ha consumato l’aumento di valore, rimanendo alla fine dell’anno col solo capitale originario di 100.000 lire; nel caso (d) finalmente ha consumato i frutti, l’aumento di valore e parte del capitale iniziale medesimo, rimanendo con un capitale terminale di sole 95.000 lire.
Altre complicazioni ancora potrebbero immaginarsi; ma il fin qui detto può reputarsi bastevole a dare un’idea chiara dei due concetti di reddito realizzato e di reddito guadagnato e delle principali differenze che fra essi intercedono. Il reddito «guadagnato» potrebbe anche essere detto reddito «secondo la definizione corrente», perché legislatori, studiosi e magistrati tendono a definire il reddito «imponibile» nella maniera che sopra s’è indicato per il reddito «guadagnato». Dopochè, insieme ai frutti (reddito «guadagnato» del patrimonio oggettivamente calcolato od in genere delle singole fonti di reddito) i legislatori ed i magistrati vennero colpendo d’imposta le eredità, le vincite al giuoco, gli incrementi di valore delle aree fabbricabili, i prezzi di avviamento delle aziende commerciali ed industriali, i sovraprezzi delle azioni di nuova emissione, si può affermare che reddito imponibile secondo la definizione corrente è «la massa netta di ricchezza acquistata da una persona fisica in un determinato periodo di tempo (anno finanziario) e consumabile (disponibile per consumi privati e pubblici della persona fisica) senza variare (diminuire o crescere) la massa di ricchezza posseduta all’inizio dello stesso periodo di tempo». A questo concetto del reddito «guadagnato» o «secondo la definizione corrente» si contrappone il concetto del reddito «realizzato» che è «la massa di ricchezza effettivamente consumata durante un certo periodo di tempo (anno finanziario) dalla persona fisica sia che varii in più o in meno o rimanga immutata la massa di ricchezza posseduta all’inizio dello stesso periodo di tempo». La qual’ultima specie di reddito in seguito sarà promiscuamente chiamata reddito «realizzato» o «consumato». Si preferirà dirla «reddito consumato» quando si voglia parlare del reddito della «persona fisica»; e sarà il più frequentemente; mentre la si dirà di preferenza «reddito realizzato» ogni volta che occorra riferirsi al reddito della «cosa».
II
Il postulato dell’uguaglianza ed il teorema milliano della esenzione del risparmio dall’imposta
Ora è teorema dimostrato dal Fisher, e prima di lui da altri, tra cui devesi sovratutto ricordare Giovanni Stuart Mill, che la tassazione del reddito «guadagnato» conduce ad una doppia tassazione sulla medesima quantità di ricchezza. Qui si riproduce testualmente, per non guastare una pagina bellissima, la dimostrazione che del teorema dà lo Stuart Mill (in Principles of Political Economy, V, II, 4). Notisi soltanto, a guisa di chiarimento, che lo Stuart Mill non s’impacciò di definire espressamente quel che egli intendesse per reddito (income); ma dal contesto del discorso si comprende come egli per reddito intendesse quello che sopra fu detto «guadagnato» senza tuttavia comprendervi gli incrementi dei valori capitali, dei quali poco si discorreva, quando egli scrisse. Epperciò, quando egli afferma che devesi tassare il reddito meno il risparmio, logicamente si conclude che egli volesse tassare quello che noi oggi chiamiamo reddito «realizzato» o «consumato». Il che è anzi espressamente affermato quando dice che «la maniera più corretta di ripartire l’imposta sul reddito sarebbe di tassare soltanto quella parte di reddito che è destinata alla spesa». Ecco ora senz’altro il brano classico:
«Se si potesse fare affidamento sulla coscienza dei contribuenti, o si potesse garantire, con controlli e precauzioni, a bastanza la esattezza delle loro dichiarazioni, la maniera più corretta di ripartire l’imposta sul reddito sarebbe di tassare soltanto quella parte di reddito che è destinata alla spesa, esentando la parte risparmiata. Poiché quando è risparmiata ed investita (e tutti i risparmi sono, generalmente parlando, investiti), dessa paga l’imposta sull’interesse o profitto che frutta, malgrado sia già stata tassata sul principale. A meno che, perciò, i risparmi sieno esenti dall’imposta sul reddito, i contribuenti sono tassati due volte su ciò che risparmiano e una volta sola su ciò che consumano. Il contribuente, il quale spenda tutto il suo reddito, paga il 3% d’imposta e nulla più; mentre se egli risparmii parte del suo reddito annuo e compri titoli, allora in aggiunta al 3% che egli ha pagato sul principale e che diminuisce l’interesse nella stessa ragione, egli paga il 3% annualmente sull’interesse medesimo, il che equivale ad un secondo 3% sul principale. Cosicché, mentre la spesa improduttiva paga solo il 3% i risparmi pagano il 6%; o più correttamente il 3% sul tutto ed un altro 3% sulle rimanenti 97 lire. La sperequazione, così creata a danno della previdenza e del risparmio, è non soltanto impolitica ma altresì ingiusta. Tassare la somma investita ed in seguito tassare altresì i frutti dell’investimento, vuol dire tassare due volte la medesima quota della ricchezza del contribuente. Il principale e l’interesse non possono amendue formar parte nel tempo stesso della sua ricchezza disponibile: essi sono la medesima cosa ripetutamente conteggiata; se egli ha l’interesse, ciò accade perché si astiene dall’usare il principale; se spende il principale, non riceve l’interesse. Tuttavia poiché egli può attenersi a suo piacimento all’uno od all’altro partito, egli è tassato come se potesse fare amendue le cose, come se potesse avere cioè il beneficio del risparmio e contemporaneamente il vantaggio dello spendere».
È chiaro il significato di questo teorema. Supponendo – è premessa questa essenzialissima che si può assumere come il postulato della uguaglianza – che due ricchezze uguali debbano essere tassate ugualmente, che se si tassa 1 lira con 10 centesimi, ogni altra lira, di qualunque reddito faccia parte ed a chiunque spetti, deve essere tassata del pari con 10 centesimi, si deduce che Tizio deve essere tassato ugualmente tanto sulle 5.000 lire di reddito «consumato» quanto sulle 5.000 di reddito «risparmiato», componenti, tra tutte e due insieme, il reddito «guadagnato» di 10.000 lire. È evidente che, se non si ammette il postulato ora detto, diventa lecitissimo tassare con 10 centesimi ogni lira consumata e con 10 e magari con 20 o più centesimi ogni lira risparmiata e deve ancora considerarsi lecita ogni altra regola più arbitraria. Il teorema milliano significa qualcosa solo se si ammette come repugnante una disuguale tassazione delle diverse lire di ricchezza che si vogliono tassare. Naturalmente non si può dare una dimostrazione logica di questa repugnanza; la quale si annuncia coi caratteri della evidenza, essendo quella che risponde al consiglio politico del minimo arbitrio ed alla massima: essere la legge uguale per tutti.[2] Epperciò il principio che se si tassa una data lira con dieci centesimi di imposta ogni altra lira, di qualunque reddito uguale maggiore o minore faccia parte ed a chiunque spetti, deve essere tassata con gli stessi dieci centesimi è accolto come assiomatico e chiamasi qui postulato dell’uguaglianza. Questo è il postulato il quale viene violato sé si tassano tutte le 10.000 lire. Poiché Tizio sulle 5.000 lire consumate avrà pagato, se l’aliquota imposta è del 10%, 500 lire e nulla più. Invece sulle 5.000 lire risparmiate avrà pagato 500 lire una prima volta, riducendosi così il risparmio effettivamente fatto a 4.500 lire. In seguito, quando egli avrà investito le 4.500 lire trasformandole in un reddito perpetuo, al 5% d’interesse, di 225 lire annue, egli sarà nuovamente tassato sulle 225 lire con un imposta di 22,50 all’anno. E poiché un pagamento annuo in perpetuo di lire 22,50 equivale ad un pagamento presente, fatto una volta tanto, di 450 lire, resta dimostrato che Tizio, per le 5.000 lire risparmiate paga lire d’imposta ossia quasi il doppio delle 500 lire che unicamente paga sulle 5.000 lire consumate. Dalla quale verità si deduce quest’altra: se si vuole osservare il postulato dell’uguaglianza, bisogna esentare dall’imposta o il risparmio o degli interessi del risparmio; e poiché questa seconda alternativa, per molti motivi che qui è inutile discorrere, si deve respingere, è necessario esentare il risparmio e tassare i soli interessi del risparmio. Infatti se si tassano le 5.000 lire consumate e si esentano le 5.000 lire risparmiate, accadrà che sulle prime sono pagate 500 lire d’imposta; e così pure sugli interessi delle seconde, che saranno, al 5% di 150 lire l’anno in perpetuo, si pagheranno 15 lire d’imposta all’anno in perpetuo; e poiché un pagamento annuo perpetuo di 25 lire equivale ad un pagamento immediato di 500 lire, resta dimostrato che soltanto la esenzione del risparmio consente tassare egualmente, con 500 lire, tanto la quota consumata (reddito realizzato) quanto la quota risparmiata del reddito guadagnato.
La medesima dimostrazione vale per gli incrementi di valore capitale. Tizio durante l’anno ha 10.000 lire di reddito «guadagnato» in senso stretto, ossia frutti del patrimonio, ed in più vede aumentare il valore capitale del suo patrimonio da 200 a 210 mila lire; onde il totale suo reddito guadagnato, per le cose dette sopra, risulta di 20.000 lire. Se egli consuma tutte le 20.000 lire, l’imposta deve colpirle tutte; e nessun doppio d’imposta si sarà verificato, poiché egli pagherà 2.000 lire e in avvenire nessun altro tributo potrà di nuovo – con offesa al postulato dell’uguaglianza – gravare le stesse 20.000 o parte di esse, perché più non esisteranno, almeno rispetto alla sua persona. Se invece egli consumasse sono le 20.000 lire di frutti e risparmiasse (non consumare una ricchezza nuova equivale a risparmiare) l’incremento di valore di 10.000 lire; egli dovrà essere tassato solo sulle prime 10.000 ed esentato sulle seconde. Così operandosi, egli pagherà 1.000 lire di tributo sulle prime 10.000 lire; e pagherà 50 lire all’anno sulle 500 lire di maggior reddito annuo corrispondenti all’incremento di valore capitale di 10.000 lire (non può concepirsi, tenuto conto dell’avvertenza in nota al capo precedente, incremento di valore capitale senza incremento di reddito e viceversa), ossia poiché un pagamento di 50 lire all’anno in perpetuo equivale ad un pagamento immediato di 1.000 lire, pagherà altresì 1.000 lire sull’incremento; il che è appunto quanto vuole il postulato dell’uguaglianza. Se invece fosse stato tassato subito con 1.000 lire sui frutti consumati e con 1.000 lire sull’incremento risparmiato, il postulato dell’uguaglianza sarebbe stato violato; perché l’incremento da 10.000 si sarebbe ridotto a 9.000 lire; e i frutti perpetui di queste in 450 lire essendo tassati con 45 lire annue, Tizio avrebbe nuovamente pagato una somma equivalente ad altre 900 lire immediate; onde sui frutti consumati avrebbe pagato solo 1.000 lire d’imposta ed invece sull’incremento risparmiato lire.
Così pure si può dimostrare che il postulato dell’uguaglianza esige la tassazione non solo della quota consumata del reddito «guadagnato»; ma puranco della quota consumata del capitale. Suppongasi Tizio privo inizialmente di qualsiasi capitale; e che nel primo anno guadagni 10.000 lire coll’esercizio della sua professione, di cui 5.000 consuma e 5.000 risparmia. Per le cose già dette, in questo primo anno, se non si vuole violare il postulato dell’uguaglianza, Tizio deve essere tassato sulle 5.000 consumate (e pagherà 500 lire); ed esentato sulle 5.000 lire risparmiate. Alla fine del secondo e del terzo anno egli ricava 250 lire di interesse dal suo risparmio (divenuto capitale) e paga 25 lire d’imposta. Se egli conservasse il suo capitale in perpetuo, pagherebbe pure l’imposta in perpetuo, il che sarebbe, come fu dimostrato, uguale al pagamento immediato (nel primo anno) di 500 lire, imposto dal postulato dell’uguaglianza. Invece egli conserva il capitale per due anni (secondo e terzo) e paga quindi di imposta due volte 25 lire. Alla fine del terzo anno egli consuma (per un motivo qualunque: giuoco, viaggio di piacere, mobilio di casa, ecc. ecc.) le 5.000 lire. Se su queste, all’atto del consumo, non fosse tassato pel pretesto che desse sono capitale, egli avrebbe pagato sulla quota risparmiata appena 50 lire (anzi meno di 50 lire, perché 25 pagate alla fine del secondo anno equivalgono, supponendo, come sempre, un saggio d’interesse del 5%, a L. 23,81 alla fine del primo anno, e 25 lire pagate alla fine del terzo anno equivalgono a L. 22,67 alla fine del primo anno, quando furono pagate le 500 lire di tributo sulla parte consumata); mentre sulla quota consumata aveva pagato fin dalla fine del primo anno 500 lire; il che viola il postulato dell’uguaglianza, essendo le due quantità uguali e per giunta identicamente consumate, sebbene in momenti diversi. Se adunque si vuole osservare il postulato fondamentale (così si può chiamare il postulato dell’uguaglianza, inteso nel senso definito più sopra) è necessario colpire con 25 lire le 250 lire di interesse guadagnate e consumate nel secondo anno, con altre 25 lire le 250 lire del terzo anno e con 500 lire le 5.000 lire di risparmio capitalizzato e poi consumato alla fine del terzo anno. Infatti queste tre quantità di 25 e 25 e 500 (non dicesi 25+25+500, perché non si possono sommare quantità di lire pagate in tempi diversi) pagate successivamente equivalgono nello stesso momento della fine del primo anno a 23,81+22,67+453,52, ossia precisamente alle 500 lire pagate alla fine del primo anno sulla quota consumata subito.
È dunque dimostrato che, se si vuole osservare il postulato dell’uguaglianza, importa tassare il solo reddito consumato, non preoccupandosi punto della sua origine, ossia non curandosi di sapere se esso derivi dal reddito guadagnato o dall’incremento di capitale o dal capitale medesimo; e bisogna invece esentare il risparmio, sia che questo consista nei frutti o nell’incremento del capitale. S’intende che deve essere esentato il capitale costituito con risparmio precedente, fino al momento in cui esso non venga consumato; ché allora dovrà essere tassato. Osservando queste regole, si osserva il postulato dell’eguaglianza. E poiché si è assunta come premessa indiscutibile questa osservanza, anche l’osservanza delle regole precedenti si impone.
La dimostrazione data qui sopra e che discende logicamente dal teorema dello Stuart Mill fu arricchita dal Fisher di molteplici sviluppi ed elegantissimi esempi, che qui è inutile ripetere. Supporrò che siano conosciuti; non essendo mio proposito di costruire una teoria economica del reddito, sibbene di studiare quale sia la teoria finanziaria della ripartizione delle imposte che si deduce dal teorema milliano, di cui la teoria fisheriana del reddito è, sotto il rispetto economico, la genialissima sistemazione.
È vero che contro il teorema di Stuart Mill – le cui applicazioni alle imposte non furono vedute se non in piccola parte; e sovratutto non fu veduta la possibilità che ne discende di una sistemazione unitaria delle imposte – furono elevate obbiezioni; ma poiché esse in parte furono già dallo Stuart Mill confutate, in parte sono di poco conto ed in parte sono evitabili mercé un’opportuna estensione del concetto di risparmio, così me ne passerò, salvo, ove occorra, a ritornarvi sopra di proposito in altra occasione. Chi creda, per qualsiasi motivo, falso il teorema di Stuart Mill ed arbitrario il postulato dell’uguaglianza, abbia provvisoriamente, fino a quando cioè in successive memorie, mie o d’altri, non siano chiarite la verità o la falsità del teorema e la necessità o arbitrarietà del postulato, la compiacenza di considerare le pagine seguenti come un tentativo di deduzione delle conseguenze logiche di alcune premesse supposte vere. È noto del resto come la bontà o l’assurdità delle conseguenze sia uno dei mezzi più efficaci per dimostrare la verità o la falsità delle premesse; sicché dal giudizio che essi faranno delle prime potranno i lettori trarre argomento per accogliere o respingere le seconde.
III
Delle difficoltà di applicazione del teorema milliano
In teoria pura, quando si ammetta che il postulato della uguaglianza richiede la tassazione del reddito «consumato» dalla persona fisica, il problema tributario sarebbe senz’altro risoluto, null’altro dovendosi accertare fuorché la quantità di ricchezza consumata dall’uomo per acquistare tutti i servizi da lui reputati utili a procacciargli godimenti, dai servizi del cibo a quelli della casa e del riscaldamento, da quelli del vestito e dell’adornamento alle cure personali, dai divertimenti all’istruzione, dai viaggi allo sfoggio di vane ricchezze. In teoria pura l’«accertamento» della quantità di ricchezza consumata dall’uomo durante un anno finanziario dovrebbe essere considerato facilissimo, trattandosi di un dato primo, come si vide sopra, che non richiede alcun calcolo complesso, alcun intervento di ipotesi contabili, come la capitalizzazione ad un dato saggio di interesse, la determinazione di quote di deperimento, di redditi normali che si possono consumare senza intaccare il capitale, ecc., ecc. Basterebbe conoscere i bilanci famigliari dei singoli uomini; e per mezzo di questi bilanci (redatti, ad esempio, sul tipo dei bilanci Le Play) constatare la spesa annua di ogni contribuente. La quale componendosi di due elementi primi: quantità fisiche di merci comperate o quantità numeriche (in unità di tempo od altra) di servizi personali e prezzo unitario di mercato, non presenta teoricamente difficoltà rilevante.
Le cose stanno purtroppo ben diversamente quando si voglia applicare la regola. Accade nella realtà che noi non conosciamo affatto quei tali bilanci famigliari. Forse ne esiste qualcuno; ma esso è libro chiuso con sette suggelli agli occhi indagatori del fisco. Quelli che sono resi pubblica ragione, sono di persone morte, ovvero di individui sconosciuti, a cui l’indagatore ha dovuto promettere il segreto; ovvero ancora sono faticosamente ricostrutti dagli studiosi su elementi strappati a gran fatica agli interessati, rielaborati in maniera approssimativa, in guisa che il bilancio non è quello di Tizio, persona fisica vivente nell’anno 1912, ma di una persona media (l’operaio medio, l’impiegato medio) e di un anno medio, non mai esistiti nella realtà. Non esistono bilanci di spese, che possano servire alla ripartizione delle imposte sul reddito: ecco il fatto certissimo, primissimo, che si impone colla forza dell’evidenza e da cui rampollano alcune verità fondamentali:
- di cui la prima è la seguente: che sebbene il reddito «realizzato» sia il dato primo, ed il reddito «guadagnato» sia il dato derivato; in realtà per l’uomo è assai più agevole conoscere il reddito «guadagnato» di quello «realizzato». In seconda approssimazione l’ordine delle idee è rovesciato da quello che era in prima approssimazione. Per l’agente delle imposte il dato primo è il «reddito guadagnato», ed il dato derivato è il reddito «realizzato». Noi non conosciamo la spesa in lire e centesimi degli uomini; ma possiamo conoscere approssimativamente il suo reddito «guadagnato». Per far ciò basta – dico basta sebbene si tratti di operazioni complicate e difficili e soggette ad innumeri errori – scomporre il patrimonio di Tizio nelle sue varie parti e di ciascuna di esse conoscere i frutti annui, il deperimento e l’apprezzamento. Si sa che Tizio possiede un fondo rustico che gli frutta 5.000 lire all’anno, una casa cittadina che glie ne dà altre 5.000 e le sue facoltà personali le quali, impiegate nell’esercizio professionale, gli danno 5.000 lire; in tutto 15.000 lire. Se nel calcolare i frutti netti della terra e della casa, si è già tenuto conto del deprezzamento per logorio e se in quell’anno nessun apprezzamento di valore capitale si è verificato, se Tizio non ha debiti, su cui debba pagare interessi, si sa che il reddito «guadagnato» di Tizio è di 15.000 lire l’anno. È una nozione, questa, ripetesi, difficilissima a conoscersi con precisione; poiché i catasti dei terreni sono spesso imperfetti, le revisioni del reddito dei fabbricati rade, l’evasione dei redditi professionali grandissima (parlo dell’Italia, ma sono osservazioni che valgono per molti altri paesi); tuttavia è una nozione che può ritenersi non impossibile a raggiungersi. Per giungere alla constatazione del reddito «consumato» l’agente delle imposte deve fare una operazione di più; togliere dalle 15.000 lire di «reddito guadagnato» annuo le 5.000, a cagion d’esempio, risparmiate. Enunciare la possibilità di fare questa operazione, in maniera corretta, è enunciare l’assurdo. Nello stesso modo che nessun uomo andrebbe a confessare la sua vera spesa all’agente delle imposte, quando sapesse che su quella quantità di spesa sarebbe tassato, anzi tutti confesserebbero una spesa di gran lunga minore del vero; così tutti, quando sapessero di essere esenti sul risparmio annualmente fatto, accorrerebbero a dichiarare risparmi mai più visti. Dilapidatori incorreggibili di patrimoni aviti e degli averi altrui, diventerebbero d’un subito previdentissimi risparmiatori. Le statistiche del risparmio segnalerebbero improvvisi confortanti incrementi; statisti e filantropi gioirebbero pel diffondersi delle abitudini di previdenza e pel diminuire delle spese inutili di vino, acquavite, tabacco. La virtù regnerebbe in ogni paese ed i vizi andrebbero sbanditi. Accadimenti meravigliosi anche per ciò che rimarrebbero notati solo sui registri degli agenti delle imposte. Ciò che in realtà accadrebbe sarebbe il diffondersi di un vizio già fin troppo imperversante: la frode fiscale. Il diritto alla esenzione dei risparmi sarebbe strumento efficacissimo di frode in mano ai furbi, per scaricare il peso dei tributi sulle spalle degli ingenui e degli inabili. In breve volgere di tempo, rimanendo costante il fabbisogno del fisco, e diminuendo, pel crescere apparente del risparmio, la materia imponibile, le aliquote delle imposte dovrebbero giungere ad altezze insopportabili e la ripartizione sarebbe afflitta da stridentissime iniquità.
- il risparmio (parlasi sempre, s’intende, del risparmio apparente dichiarato, non del risparmio effettivo, che solo vorrebbesi esentare) crescerebbe specialmente quando s’avesse apprensione o si fosse già verificato un aumento temporaneo di imposte, per far fronte, mettiamo, alle spese di una guerra. L’aliquota, che normalmente è del 10%, debba essere portata per tre anni al 20%. Il contribuente «onesto», che non vuole frodare il fisco se non in maniera legale, accresce, durante i tre anni, il suo risparmio di 3.000 lire all’anno; ed ottiene così l’esenzione da un’imposta che giungerebbe a 600 lire all’anno ed in tutto a 1.800 lire. Finita la guerra, l’aliquota viene ridotta al 10%; ed il contribuente consuma allora il suo risparmio temporaneo di 9.000 lire, dedicandolo a spese, come viaggi, compra di mobilio, abbellimenti alla villa, ecc., che potevano benissimo essere prorogate. Onesto come egli è, dichiara al fisco l’avvenuto consumo del risparmio, temporaneamente capitalizzato, e, secondo la regola della tassazione del reddito realizzato, paga su questa spesa l’imposta nel quarto anno. Ma, pagando quando l’aliquota è ridotta nuovamente al 10%, il tributo assolto è di 900 lire. Egli s’è sottratto alle spese della guerra, trasferendo i suoi consumi nel tempo. Non solo, ma durante quei tre anni può aver avuto occasione di comprare buoni del tesoro emessi dallo stato per procacciarsi fondi temporanei ed ha quindi, grazie alla frode fiscale, anche fatta un’ottima investita ad un interesse più elevato dell’ordinario. Se tutti agissero ugualmente, come potrebbe lo stato ottenere i fondi per la guerra? Dovrebbe aumentare l’aliquota non al 20, sibbene al 30 o 40%, provocando nuove simulazioni di risparmio.
- se l’accertamento del risparmio fatto sui redditi guadagnati dell’anno è difficile, ancor più difficile è l’accertamento della spesa fatta coi risparmi degli anni precedenti, spesa che dovrebbe essere colpita da imposta, secondo la teoria della tassazione del reddito «consumato». Supposi sopra che Tizio confessi spontaneamente nel quarto anno d’avere consumato le 9.000 lire da lui rispamiate nei tre anni precedenti. Costui ha voluto «legalmente» evadere un’imposta; ma è onestissimo, poiché v’è ogni probabilità che i suoi compagni di evasione si dimentichino di denunciare l’avvenuto consumo del risparmio precedente. Come potrebbe il fisco opporsi a simiglianti frodi? Si rizzano i capelli in testa pel terrore al solo pensiero della contabilità perfettissima che le agenzie delle imposte dovrebbero tenere per ogni contribuente dalla nascita alla morte. Ognuno dovrebbe avere una partita aperta sul gran libro dell’inventario dei guadagni, dei consumi e dei risparmi. In questa partita ogni avvenimento della sua vita dovrebbe essere registrato; da un lato tutti i flussi di ricchezza: dai guadagni professionali ai frutti patrimoniali, dalle eredità alle donazioni, dalle vincite al giuoco agli incrementi di valore delle azioni e dei beni posseduti; dall’altro tutti gli efflussi di ricchezza: dalle spese fatte coi redditi guadagnati nell’anno a quelle fatte consumando il patrimonio precedentemente accumulato od ereditato. Il saldo attivo risultante sui libri fiscali dovrebbe corrispondere con precisione al valore del patrimonio in ogni istante effettivamente posseduto dal contribuente. Ogni discrepanza metterebbe in orgasmo i contabili fiscali; così come la mancanza di un centesimo nei saldi di bilancio d’una bene organizzata casa commerciale sovreccita gli impiegati responsabili della contabilità e li costringe a febbrili, affannose ricerche per mesi e mesi per giungere alla scoperta del centesimo smarrito. Poiché se risultasse ad un dato momento che il saldo attivo di Tizio è di 100.000 lire sui libri della contabilità fiscale, mentre è notorio che Tizio, rovinato, va chiedendo l’elemosina dinnanzi alle porte delle chiese, o suona l’organetto nei crocicchi delle vie, manifesto sarebbe che Tizio avrebbe speso le 100.000 lire senza denunciare la spesa ed assolvere il dovuto tributo. Ragionevoli sono le previsioni che non poche sarebbero siffatte sorprese; a togliere le quali il fisco dovrebbe mantenere legioni di spie, specialmente nei luoghi dove si disfrena il lusso, dove il gioco e nei bagordi si perdono i patrimonii dai degeneri figli di padri parsimoniosi, per sorprendere la spesa nell’attimo fuggente in cui avviene ed asserire in quell’istante i diritti sui premi del fisco. Con scarso risultato però; e con nocumento gravissimo della dignità dello stato.
Onde è d’uopo conchiudere che ogni tentativo inteso ad accertare direttamente il reddito «consumato» ed a tassarlo secondo la sua quantità precisa e presso il contribuente di diritto è destinato a fallire. Almeno finché sulla terra non sia sorta una generazione di uomini «puri» che sappiano valutare degnamente l’importanza dei servizi pubblici e dirittamente denuncino i fatti veri. Nel qual caso ogni discorso sarebbe inutile, perché questi uomini «puri», operanti in ossequio alla teoria, farebbero volontariamente richiesta di servizi pubblici e di imposte non sarebbe d’uopo parlare, bensì soltanto di «prezzi pubblici» o «tasse».
IV
Le due approssimazioni: le imposte cosidette sui consumi e le imposte cosidette sui redditi
Da queste imperfezioni pratiche non rimane tuttavia minimamente scossa l’eccellenza del principio della tassazione del reddito «consumato»; resta dimostrata soltanto la necessità di ricorrere a spedienti di applicazione che eliminino, nella misura del possibile, i malanni derivanti dall’indole invincibilmente frodolenta dell’uomo.
Gli spedienti fin qui divisati dai legislatori, sono stati principalmente due: la tassazione dei beni materiali e dei servizi personali che l’uomo acquista col reddito che egli vuole effettivamente consumare,[3] e la esenzione di una quota presunta di risparmio nella tassazione del reddito guadagnato.
In primo luogo la tassazione dei beni consumati dall’uomo. Si vide sopra come il reddito «consumato» sia un dato primo difficilissimo, anzi impossibile a conoscersi. Ma l’uomo,che serba con così gelosa cura il segreto dei suoi bilanci famigliari, non può sottrarsi alla necessità di «spendere» quella ricchezza che vuol consumare, e che si chiama appunto reddito consumato o realizzato. Egli deve recarsi dal padron di casa e pagargli il fitto dell’appartamento da lui occupato; o, se egli stesso è proprietario di casa, può facilmente risapersi quale sia il prezzo che egli pagherebbe se fosse inquilino in casa propria. Egli deve comperare i mobili ed ogni anno pagare il premio d’assicurazione contro l’incendio dei suoi mobili, cosicché è facile conoscere quale ne sia il pregio e quale il vantaggio annuo, in lire, soldi e denari, che egli ne ricava. Egli tiene domestici, vetture, cavalli, automobili, cani, e si sa quanto spende per procacciarsene i servigi. Egli per cibarsi, vestirsi, per adornare se stesso e le donne da lui amate deve comprare beni a un prezzo di mercato. Or dunque lo stato, il quale ha abbandonato ogni speranza di accertare direttamente la quantità del reddito consumato, la accerta indirettamente, apprestandosi al varco in quei passi dove l’uomo necessariamente deve transitare per convertire la moneta il numerario indistinto, in cui si concreta la ricchezza destinata al consumo, in beni, i cui servizi egli appunto vuol consumare.
Se si potesse immaginare che lo stato conoscesse la via che deve compiere il numerario destinato al consumo per trasformarsi in servizi di beni effettivamente consumati, l’imposta ideale sarebbe raggiunta. Nessuna diversità sostanziale esisterebbe tra l’imposta pura sul reddito consumato e questa, che per brevità e per conformarci all’uso universale diremo imposta sui consumi. La differenza, secondariissima, starebbe soltanto nel momento dell’accertamento del reddito: nel primo caso volendosi accertare la quantità del numerario destinata al consumo e nel secondo caso la quantità dei servigi utili acquistata con quello numerario. Non si può disconoscere persino che la palma dell’eccellenza spetterebbe al secondo metodo; perché, se anche si riuscisse, cosa per fermo assurda, ad accertare la quantità di numerario destinata al consumo, non potrebbe evitarsi – per la impossibilità di compiere le indagini a consumi fatti, quando cioè il reddito più non esiste e quindi spesse volte difetterebbero le maniere di esigere coattivamente l’imposta, e per la necessità di fare perciò gli accertamenti prima dell’avvenuto consumo – una non infrequente discrepanza tra la quantità di numerario destinata al consumo e la quantità di numerario di fatto consumata; ben potendo darsi che nel frattempo l’uomo abbia mutato proposito e destinato al risparmio ciò che prima voleva consumare e viceversa. L’imposta sui consumi sfugge a quest’obbiezione; poiché aspetta a colpire il numerario nell’istante medesimo in che l’uomo effettivamente lo trasforma in servigi consumati di beni o di persone. Se il contribuente non paga fitto di casa neppure paga l’imposta sul valor locativo; se non tiene domestici od automobili, non viene su di essi tassato; e tarda a pagare i tributi sul caffè, lo zucchero, il vino, il pane, finché non li abbia effettivamente acquistati.
Per raggiungere la perfezione che sopra si è detto basterebbe che il fisco sapesse appostare un gabelliere al varco ogni via percorsa dal numerario per trasformarsi in consumi; e su ogni consumo prelevasse un tributo rigorosamente proporzionale. Supponendo che Tizio consumi 5.000 lire all’anno, è chiaramente uguale tassare col 10% direttamente le 5.000 lire; ovvero, pure col 10%, le 1.000 lire consumate nel fitto di casa, le 2.000 lire del cibo, le 500 dei vestiti, le 500 di servizi personali, le 1.000 lire di spese varie per istruzione (libri, tasse scolastiche, giornali), viaggi, divertimenti, ecc. In amendue i casi il fisco percepirebbe 500 lire d’imposta ed in amendue i casi sarebbe passato tutto e solo il reddito realizzato, in conformità al postulato dell’uguaglianza.
L’altra via prescelta dai legislatori per attuare il postulato dell’uguaglianza è la tassazione del reddito guadagnato, con detrazione di una quota presunta di risparmio.
Diceva già Giovanni Stuart Mill:
«Se nessun metodo può essere immaginato per esentare i risparmi effettivi, il quale sia bastevolmente immune dal pericolo di frode, è necessario, a guisa di seconda approssimazione alla giustizia, nel distribuire l’imposta, tener conto di quel che le varie categorie di contribuenti dovrebbero risparmiare».
Poiché l’accertamento diretto del reddito guadagnato è per fermo difficile, ma l’accertamento del risparmio effettivo è assurdo, il legislatore, dopo avere accertato il reddito guadagnato, ne deduce non il risparmio «effettivo» ma il risparmio «presunto». Fa cioè il legislatore l’analisi psicologica del contribuente e constata che questi, data la natura del suo reddito, la composizione della sua famiglia, l’età, le condizioni di salute, deve, per ogni 100 lire di reddito «guadagnato» ed accertato, risparmiare 20 ovvero 30 ovvero magari 50; e queste esenta da tributo, tassando solo la parte che si suppone dovere essere consumata. Nel compiere queste presunzioni di risparmio il legislatore sarà mosso da numerosi indizi, tra cui potranno noverarsi pure i risparmi effettivamente compiuti dal contribuente in modo irrevocabile, in modo tale cioè che il risparmio non possa tornare ad essere consumato frodolentemente ma solo nell’istante in che si verifica l’avvenimento (malattia, infortunio, vecchiaia, morte) per cui il risparmio fu costituito; di qui la detrazione, oltreché di quote presunte di risparmio, dei premi effettivi di assicurazione.
Le differenze che; in questo primo momento, si possono notare tra i due tipi d’imposta, il primo sui servizi consumati dall’uomo (cosidette comunemente imposte sui consumi) e il secondo sul reddito guadagnato con detrazione del risparmio presunto (cosidette imposte sui redditi), sono le seguenti:
a) le imposte sui consumi rispondono ai fatti reali, le imposte sui redditi ai fatti immaginati dal legislatore. Le imposte sui consumi non possono non esentare il risparmio; le imposte sul reddito lo esentano solo in quanto le presunzioni del legislatore corrispondano alla realtà. E poiché il legislatore non può far presunzioni individuate per ogni contribuente, che sarebbero odiosissime e farebbero rinascere tutte le obbiezioni che già si fecero contro gli accertamenti diretti della spesa e del risparmio, se le indagini fossero compiute sul serio e sarebbero reputate partigiane, se fatte alla lesta; ma deve necessariamente contentarsi di presunzioni fatte per classi di contribuenti, distinguendo tra le classi che possono essere imprevidenti e quelle che devono essere previdentissime e le altre che possono tenere una condotta manifesta, così è manifesto che sempre le presunzioni del legislatore, corrette per l’uomo medio d’ogni classe, saranno scorrettissime per i singoli individui della classe. Laddove per una classe il legislatore avrà supposto un risparmio del 20%, vi sarà tra i componenti della classe chi nulla risparmia, e chi risparmia il 5 e il 10; mentre altri si terranno vicini alla media presunta ed altri andranno al di là, al 30, 40 e magari 50%. Onde le imposte sui redditi, per quanto si faccia, sempre riusciranno disformi dall’ideale, intendendo per «ideale» l’imposta sul reddito consumato.
b) le imposte sui consumi devono dunque lottare precipuamente contro difficoltà di applicazione; metre le imposte sui redditi contro difficoltà di principio. Il legislatore può cioè immaginare una imposta sui consumi perfettissima; bastando a ciò decretare che tutti i consumi degli uomini siano percossi da un proporzionale balzello del 10% e le difficoltà sorgeranno quando i gabellieri dovranno scovrire tutti i varchi, attraverso ai quali il numerario si trasforma in consumi. Ma il legislatore, anche volendo, non può immaginare una imposta (cosidetta) sui redditi perfetta; perché gli converrebbe determinare delle presunzioni di risparmio conformi ai risparmi effettivi; il che, per le cose discorse sopra, ossia per la necessità assoluta di procedere per classi, gli è perentoriamente vietato.
Epperciò è corretto concludere questo primo raffronto, affermando che le imposte sui consumi meglio si avvicinano teoricamente all’ideale, definito come si disse, che non le imposte sul reddito guadagnato, da cui sia stato dedotto il risparmio presunto (cosidette imposte sui redditi). Vedremo, in seguito, per quali ragioni tecniche lo stato sia obbligato ad attenersi insieme alle une ed alle altre: e, non bastando amendue, a creare altri tipi ancora di balzelli, come le imposte successorie o sui trasferimenti onerosi o sul patrimonio, che sono varianti delle imposte sui redditi.
V
Critica delle dottrine correnti rispetto alle suddette due maniere di imposta e fecondità della dottrina qui accolta
Frattanto, a guisa di intermezzo, veggansi come siano fuor di luogo le lodi spropositate che si tributano alle cosidette imposte sui redditi e come siano teoricamente immeritati i vituperi onde si coprono i tributi cosidetti sui consumi. Fu sempre ritenuto, quasi per ispirazione divina, che vero oggetto dell’imposta fosse il reddito «guadagnato»; cosicché senza impacciarsi a ricercare le fondamenta di siffatta curiosa «fede», studiosi e legislatori si trovarono imbarazzatissimi di fronte al fatto imponente delle imposte sui consumi. Come spiegare la esistenza, ripugnante, se vuolsi, ma reale, delle imposte sui consumi partendo dal presupposto che l’imposta debba colpire i redditi guadagnati? Trattasi di due concetti irriducibili. Il consumo, la distruzione della ricchezza non può convertirsi nel nascimento dei frutti, nell’incremento del patrimonio, nell’aggiunta di nuove masse di ricchezza. La creazione, il guadagno di valori nuovi è precisamente l’opposto della caduta nel nulla delle cose esistenti.
Di qui svariatissime sorta di inani sforzi per spiegare l’inesplicabile. I tribuni della plebe ne trassero argomento per proclamare ancora una volta, e forse non a torto, che la scienza finanziaria non è vera scienza, ma ricettario di norme utili ai governanti ed alle classi dominanti. Le imposte sui consumi furono descritte come lo strumento di cui le classi proprietarie, capitalistiche, trovandosi al potere, si servono per opprimere i poveri, per ridurre i loro salari al minimo e per riversare sui più l’obbligo tributario, che spetterebbe ai meno. Il che evidentemente non spiega come i poveri, giunti talvolta al potere, dopo inani tentativi, abbiano dovuto ristabilire le aborrite gabelle. D’altro canto, i giuristi dell’imperatore, gli scribi prezzolati che difendono gli istituti esistenti, anche pessimi, quando piaccia al principe (sovrano assoluto o popolo) di conservarli, non tardarono a creare la teoria «speciale» atta a dare contezza della ragion d’essere delle comodissime imposte sui consumi. Si colpirebbero i consumi non in quanto tali, ma come indici del reddito del consumatore. Chi affitta una casa, chi ha cavalli, vettura, automobile, chi consuma sale, pane, carne, vino, dimostra con ciò di possedere il «reddito» necessario per fare quei consumi. Dunque la tassazione dei consumi sarebbe una maniera diversa, forse più comoda, meno sentita, più fruttuosa, di tassare i redditi. Ma la più ovvia riflessione basta a mettere in luce l’insufficienza del ripiego. I consumi non sono l’indice del reddito guadagnato, se non forse nel caso dei redditi minimi, che non lasciano alcun margine al risparmio. In questi casi l’uomo consuma solo e tutto ciò che di «guadagno» fa nell’anno, perché non ha ricchezza preesistente da intaccare, né trova credito presso gli altri uomini per consumare più del guadagno, né può consumare di meno, se non voglia morire per inanizione. Tuttalpiù i consumi potranno superare il reddito guadagnato per l’ammontare di qualche minuto latrocinio o carpita elemosina. Ma appena si supera il livello del submerged tenth, del sub proletariato, subito si manifestano profonde discrepanze tra quantità consumo e quantità reddito guadagnato. V’ha l’operaio che sul salario settimanale risparmia le quote alla società di mutuo soccorso per le malattie o alla lega di resistenza; e nemmeno per costui le due quantità coincidono. V’ha l’impiegato, il professionista che faticosamente risparmia una decima, una quinta parte del reddito; v’ha il ricco, che non può consumare i suoi proventi, per la fisica impossibilità di darvi fondo. V’ha il prodigo che consuma il reddito guadagnato ed inoltre tutto o parte del patrimonio. E v’ha chi, millantando ricchezze immaginarie, riesce, senza reddito, a vivere con splendidezza per anni ed anni. Insomma, ben difficilmente o quasi mai la quantità consumo è uguale alla quantità reddito guadagnato; onde non può il legislatore che vuole tassare i «redditi guadagnati», non può lo studioso, che assume come articolo di fede la «giustizia» della tassazione di quei redditi, affermare sul serio che egli intende raggiungere lo scopo tassando i «consumi» che ne sarebbero l’indice perspicuo ed apparente. La via, oltreché obliqua, appare viziosa e diretta ad altra meta. Perciò è accaduto che, disperati, gli studiosi «sereni», né tribuni della plebe né giuristi dell’imperatore, abbiano abbandonato alla loro sorte le imposte sui consumi; accettandole come dura necessità imposta dai voraci appetiti degli enti pubblici e dalla difficoltà tecnica di scovrire e tassare i redditi; ma condannandole come ripugnanti alle dottrine più «moderne», alle esigenze della giustizia, come fossili residui di età barbare. Perciò si esulta ogni qualvolta una imposta sui consumi viene ridotta od abolita e si afferma che la tendenza delle legislazioni «moderne» è verso la progressiva eliminazione delle imposte sui consumi. E vieppiù si irritano studiosi e riformatori quando debbono constatare che siffatta asserita tendenza è unicamente frutto della loro eccitata fantasia, che a miliardi si noverano i proventi delle imposte sui consumi negli stati moderni e che tuttodì si creano nuovi monopoli intesi a crescere, sotto menzognere sembianze, i balzelli sui consumi. Ogni trattato di scienza finanziaria, almeno ogni trattato che abbia stile di modernità, reca indelebili tracce della rabbiosa stizza degli studiosi contro l’inesplicabile «residuo» delle imposte sui consumi; sicché, posti tra la voglia di dannarle al fuoco purificatore dell’oblio e la necessità di parlarne per il loro pervicace vigoreggiare, tutti assegnano alle imposte sui consumi l’ultimo posto nella trattazione, quasiché, mettendole per ultime e maltrattandole nella fugace trattazione, se ne possa far dimenticare l’esistenza. Il quale atteggiamento non è, per fermo, conforme a serietà scientifica. Essendo compito della scienza di studiare tutti i fatti, anche quelli che hanno la virtù di irritare gli studiosi; e di collegarli possibilmente sotto un’unica legge.
Né più soddisfacente fu il contegno della dottrina rispetto alle imposte da essa predilette alle sole imposte «vere» ossia a quelle sul reddito guadagnato. Ove non si parta dalla teoria milliana della esenzione del risparmio, il reddito guadagnato diventa una massa omogenea. Non più distinzione fra parte consumata e parte risparmiata: tutto è reddito e tutto deve essere tassato. Ma i fatti ancora una volta smentiscono l’audace supposizione. Unanimi i legislatori si ostinano a frazionare il reddito in porzioni eterogenee e diversamente trattate; a trattare in un modo le lire guadagnate lavorando e in un altro modo le lire ottenute impiegando capitali; e queste diversamente da quelle vinte al giuoco od ottenute per eredità; e nelle lire ereditarie distinguendo le lire provenienti dai parenti prossimi da quelle venute dagli zii d’America. A maggior mortificazione degli adoratori del «reddito guadagnato», il legislatore sempre più bada al fine a cui servono le lire; e benignamente considera quelle destinate a garantire la persona fisica dai rischi di malattia, di infortunio, di morte prematura, più di quelle destinate a godimenti immediati. Si preoccupa anche il legislatore delle famiglie numerose e dopo avere esentato sotto Roma i patres trium liberorum e nell’antico regime i padri di dodici figli, oggi reputa che la lira di reddito dello scapolo o dei genitori senza prole sia considerata davvero eguale ad una lira; mentre riduce ad 80, 70, 60, 50 centesimi le lire dai padri di prole via via più numerosa. Naturalmente i giuristi dell’imperatore ed anche gli studiosi «sereni» e di «cuor generoso» si affrettarono ad addurre i più diversi pretesti per spiegare le singolari deviazioni dalla regola che tutto il reddito guadagnato debba essere percosso dall’imposta; e si recarono in campo i doveri sociali dello stato, l’ufficio sociale delle imposte di perequare le fortune cominciando a scemare le disuguaglianze create dalla sorte cieca delle eredità, l’opportunità di incoraggiare la previdenza e di reprimere le malsane passioni del giuoco, la giustizia di avocare allo stato gli incrementi di valore dovuti all’energia di fattori sociali; l’interesse di opporsi alla tendenza pericolosa degli uomini a diminuire il saggio di natalità. Altri più ambiziosi, tentarono teorie generali per spiegare la diversità delle aliquote d’imposta sui redditi diversi per indole o la progressività del tributo col crescere del reddito. Si disse che alcuni contribuenti avevano una capacità contributiva maggiore degli altri, ma subito si abbandonò la spiegazione, perché si vide che era puramente verbale ed equivaleva a constatare che a certe lire si fa pagare di più che ad altre lire, perché si ritiene che siano costrutte o composte in tal maniera da poter pagare di più. E volendosi determinare la ragione di questa diversa loro composizione chimico tributaria, furono esposte molteplici dottrine sul sacrificio minimo, od equi marginale, uguale o proporzionale, con un dosaggio sapientissimo della pena, del dolore che ogni uomo soffre nel separarsi dalle proprie ricchezze e anzi dalle dosi successive della ricchezza. Ma si abbandonò poi per disperata l’impresa di misurare i piaceri e i dolori dell’imposta quando si vide che, per essere corretta, questa misurazione avrebbe dovuto farsi individuo per individuo; essendo diversissima da uomo a uomo la sensibilità al dipartirsi dalla ricchezza; ed essendo ingannatrici le presunzioni medie che a tal proposito si possono istituire, di gran lunga più ingannatrici delle, pure insufficienti, presunzioni sul risparmio, le quali hanno almeno il privilegio di potersi confortare di riprove statistiche sull’ammontare dei risparmi depositati, delle investite di capitale, degli incrementi di valore e via dicendo. Cosicché ben si può dire che la dottrina corrente della tassazione del «reddito guadagnato» rassomigli al mantello pezzato della zebra e su di essa abbiano lasciato tracce le più svariate e peregrine divagazioni sociali, umanitarie, filantropiche, morali, psicologiche, fisiologiche, politiche.
Principalissima causa per cui ad uno spirito adusato alla severa disciplina logica della scienza economica o del diritto privato le trattazioni finanziarie appaiono prive di sistema, di filo conduttore, un’accozzaglia incoerente di regole di buona condotta per governanti deliberati a condursi malissimamente.
Le incongruenze, le contraddizioni, le insufficienze scompaiono invece quando si ammetta che il postulato dell’uguaglianza esige la tassazione del reddito realizzato o consumato. Od almeno tutte si riducono a difficoltà tecniche, pratiche di applicazione per le imposte sui consumi e ad inevitabile difetto di nozioni statistiche per le imposte cosidette sui redditi. Le imposte sui consumi, invece di essere relegate come un residuo inesplicabile ed irritante nel luogo dove si racconta come nelle età più civili perdurano istituti delle età barbare, o dove vergognosamente si narrano le malefatte dei governi spinti dal bisogno di accattare purchessia denari, si avanzano alla ribalta sul palcoscenico dove si recita il dramma tributario; e da imperfettissime e contennende diventano realizzazioni pratiche teoricamente perfettissime del concetto della tassazione del «vero» reddito, quello realizzato. Le imposte sul reddito guadagnato mutano indole altresì; e dalla condanna si salvano soltanto, tentando di avvicinarsi alle imposte sui consumi, mercé la detrazione delle quote di risparmio presunto. Cessa la necessità di ricorrere a considerazioni extravaganti di giustizia sociale, di sacrificio minimo o uguale o proporzionale, di incoraggiamenti alla previdenza o di pene per la stravaganza, di premi alle famiglie numerose e di multe agli scapoli ed altrettali nozioni estranee alla materia stessa tributaria. Uno è il punto di partenza per l’una e per l’altra imposta: la necessità di osservare il postulato dell’uguaglianza, non tassando due volte la medesima ricchezza. Ammesso siffatto assioma, di natura prettamente tributaria, ne discende logicamente che il risparmio deve essere esentato dall’imposta; e ne discende ancora che, dove non si vogliano o non si possano tassare soltanto i consumi e tutti i consumi (del che si vedranno sotto i motivi), e sia d’uopo discendere, nella scala della perfezione astratta, sino a tassare il reddito guadagnato, importi dedurre una quota per il risparmio. E poiché sono infinite le ragioni e le modalità del risparmiare così si spiegano ad una ad una tutte quelle detrazioni – per età, per famiglia, per malattia, per assicurazione, per redditi minimi o mediocri, per la fatica del lavoro – dal reddito imponibile che i legislatori vanno concedendo e che tutte si riconnettono, come poi si vedrà, alla necessità di provvedere a qualche maniera di risparmio capitalistico o personale. Invece di andare elemosinando dalla sociologia chiaccheroide o dal decalogo di un inverecondo politicantismo le ragioni per attenuare qua, aggravare altrove ed esentare talvolta i redditi, a seconda che piacciano o spiacciano agli uomini politici, la scienza finanziaria può tenersi stretta ai suoi postulati e tassare dovunque vi sia reddito realizzato ed esentare in ogni altro caso.
Fecondo diventa così finalmente il compito della scienza finanziaria per quanto riflette la ripartizione dei tributi. Invece di un albero sottile che si piega ad ogni soffiar di vento, invece d’un accomodevole cameralismo industriantesi a cercare le buone e generose e moderne ragioni con le quali si possa giustificare la volontà ultima del legislatore, la scienza finanziaria diventa – meglio, potrà diventare col tempo – una costruzione logica dedotta da un unico principio e svolta con dirittura sino alle sue ultime conseguenze. Oggi si condanna una novità tributaria appellandola «ingiusta», «iniqua», «antiquata», «oppressiva» e altrettali gentilezze. Perché poi ingiusta od iniqua non si sa di preciso; o si sa che così è chiamata perché spiace al buon cuore dello studioso od irrita chi la deve pagare; mentre per converso coloro che non la pagano e ne godono i frutti la proclamano giustissima e modernissima. Ove si ammetta il punto di vista della presente memoria, ogni nuova o vecchia imposta sarà detta, non più giusta od ingiusta, bensì corretta o scorretta, conforme cioè o disforme dalle regole che logicamente si deducono dal principio della tassazione del reddito realizzato. Se vi saranno legislatori i quali vorranno adottare imposte «scorrette», buon pro lor faccia. La scienza potrà trattarne nella terza o quarta approssimazione nella teoria delle illusioni tributarie o degli effetti economici delle imposte «scorrette». Le imposte hanno invero molti effetti; effetti utili, ossia tali da promuovere l’incremento della ricchezza quando le imposte sono corrette; dannosi ossia distruttori di ricchezza quando quelle sono scorrette. Essendo manifesto che un legislatore può volere questa seconda maniera di effetti e non la prima, nessuno mai potrà far esulare dalla realtà le imposte scorrette; e queste rimarranno mai sempre, alla pari delle prime, oggetto di indagine scientifica, intesa appunto a rivelarne la illogicità e il danno. L’ufficio della critica scientifica rispetto ai tributi esistenti nella realtà deve dunque essere esercitato in due modi: primamente per vedere se quel tributo risponda alle esigenze del postulato e del teorema ammessi come fondamentali; esaminando per quali aspetti si discosti dall’ideale e quali sarebbero le maniere di correggerne i vizi; e in secondo luogo per studiare quali siano gli effetti, tristi o buoni, del tributo che si allontani e di quello che si avvicini all’ideale.
Una osservazione ancora sia consentita: quando sopra si è parlato di concetto «vero» del reddito, di postulato dell’uguaglianza, di teorema della esenzione del risparmio per evitare la doppia tassazione, non si è affatto preteso che quei concetti siano i soli realmente applicabili, che il legislatore non possa, volendo, tassare una volta una parte del reddito e due o tre volte un’altra parte. Se questo immaginassimo, saremmo imitatori di quelli che bruciano incensi dinanzi all’altare del reddito «guadagnato» perché così fu a loro ordinato dalla rivelazione divina o dalla volontà del legislatore. Le definizioni e i concetti sono etichette che noi appiccichiamo ai fatti, per chiarirli, collegarli insieme logicamente e dedurne leggi, che valgano a spiegarceli. Il legislatore può, volendo, tassare replicate volte il medesimo reddito; e ben è noto come le molteplici tassazioni tuttodì accadano. Qui si è voluto affermare soltanto che se non si vuole tassare due volte la medesima ricchezza e se non si vogliono gli effetti dannosi della duplice o molteplice, tassazione, è duopo tassare il reddito consumato e non il reddito guadagnato; e, per chiarezza, si è definito il significato di queste due parole od etichette diverse; e, per brevità, si è detto «vero» il concetto del reddito consumato, perché consente di attuare la premessa, e «falso» il concetto del reddito guadagnato, perché non l’attua. Poiché il cammino universalmente percorso dalla scienza fu di partire da alcune premesse, supposte vere, sembra lecito costruire un sistema d’imposte partendo dalla premessa del postulato dell’uguaglianza. Coloro a cui la premessa non piaccia ne pongano un’altra e su quella procedano. Ma non si illudano di edificare la casa scordandosi delle fondamenta.
VI
Esame critico delle imposte sul reddito consumato e loro eccellenza in confronto alle imposte sul reddito guadagnato
Intanto si veggano le particolarità dell’edificio iniziato partendo dalle nostre premesse. E, dovendosi dire prima delle imposte sui consumi le quali teoricamente più si avvicinano alla perfezione, si aggiunga che questa perfezione teorica incontra difficoltà gravissime quando voglia essere concretata.
- Sarebbe infatti mestieri potere aspettare al varco ogni unità di numerario quando voglia convertirsi in godimenti per l’individuo. Tassando col 10% d’imposta tutte le merci e tutti i servigi acquistati dall’uomo, senz’altro sarebbe tassato l’intiero suo reddito consumato. Ma questa è una condizione che non può in alcun modo essere soddisfatta. Come è scarsa la sapienza del fisco nello scovrire direttamente la quantità del reddito realizzato o guadagnato, altrettanto è manchevole la sua abilità a tendere gli opportuni lacci per cogliere al varco il numerario del contribuente, quando si trasforma in servigi di merci o di persone. Occorrerebbero falangi innumere di gabellieri per giungere a tanto e quando anche vi si giungesse, il costo dell’impresa sarebbe elevatissimo. Le imposte, è inutile ricordarlo, non si esigono per amore dell’arte, sibbene per soddisfare alle esigenze dei servigi pubblici; ed a queste esigenze non si soddisfa quando occorra spendere una troppo rilevante proporzione dell’esatto per sopperire alle spese di esazione (quarto canone di Adamo Smith). A voler attuare la condizione di tassare tutti i servizi occorrerebbe appostare sorveglianti in ogni casa, in ogni bottega, in ogni luogo di ritrovo, per i crocicchi delle vie, sulle fiere, sui mercati, ecc. Siffatta maniera di vessazione rivolterebbe i popoli, che non amano essere angariati. Perciò la tassazione dei consumi deve limitarsi a quelli che tecnicamente possono essere accertati con moderata spesa di riscossione. Pochi sono i consumi che soddisfano a questa condizione; ossiano quelli che sono compiuti in modo universale, costante, visibile agli occhi di tutti (spesa dell’alloggio o dei domestici); e quelli altri che consistono nell’acquisto di beni che devono necessariamente passare attraverso a taluni pochi punti, ai quali stanno appostati i gabellieri (dogane, dazi di consumo), o che devono essere fabbricati in grandi stabilimenti facili a sorvegliarsi (imposte di fabbricazione) o la cui fabbricazione può essere vietata ai privati per assegnarla allo stato tassatore (monopoli o privative). Moltissimi sono i consumi, che parrebbero atti a tassazione e che tuttavia non possono essere tassati perché non soddisfano all’una od all’altra delle predette condizioni. A cagion di esempio, il vino, materia intrinsicamente attissima a tassazione, può essere tassato quando proviene dall’estero (dogane sui vini di lusso) o quando entra nelle città murate (dazio consumo); ma per tutta la restante quantità consumata sfugge all’imposta. Esistettero invero in passato imposte sulla fabbricazione e circolazione del vino (imbottato); e furono di recente nuovamente proposte in Italia. Ma basti pensare alla moltitudine dei piccoli produttori di vino in Italia, all’indole sparsa delle cantine rustiche, alla diffidenza all’abilità dei contadini nel dissimulare, per rimanere persuasi che un imbottato incorrerebbe fra noi nelle più gravi difficoltà di esazione, ben maggiori di quante non esistano per la tassazione dell’acquavite fabbricata dagli agricoltori, per cui per tanti anni in Francia e in Germania si dovette concedere il cosidetto privilegio dei proprietari distillatori. E come del vino, così si dica di quasi tutti gli altri prodotti agricoli, dal frumento agli ortaggi, dalle frutta agli agrumi, dalle ova ai fiori. Eppure tutti bisognerebbe tassare, se si volessero sul serio colpire tutti i consumi. Impresa assurda, che avrebbe per effetto immediato di cogliere alle statistiche agricole quel valore che con grandi sforzi vengono oggi riconquistando. Si pensi inoltre alle difficoltà di tassare gli oggetti prodotti dalla piccola industria, o dall’industria casalinga dell’abbigliamento o dell’ornamento; di accertare i servizi personali resi occasionalmente da un’infinita serie di persone che non stanno ai servizi permanenti di altre e non possono essere raggiunte coi balzelli sul servidorame; e si rimarrà persuasi che una imposta su tutti i consumi non è possibile.
- Il difetto ora enunciato che si può chiamare della parzialità sarebbe tuttavia lievissimo, anzi irrilevante se non andasse consuetamente congiunto ad un altro; la disuguaglianza invero se anche si potesse tassare soltanto una decima parte dei consumi fatti dagli uomini, nessuna offesa ne deriverebbe al postulato dell’uguaglianza, se quella decima parte fosse ugualmente tassata presso tutti gli uomini. È manifestamente indifferente tassare coll’1% tutta Ia ricchezza consumata, ovvero col 10% la decima parte della ricchezza consumata. Con l’uno e con l’altro metodo i contribuenti pagano e lo stato incassa la medesima somma. Onde è dimostrato che la mancanza di generalità per sé medesima non ha alcuna importanza.
La acquista quando si metta in correlazione col difetto di uguaglianza. Non tutti i consumi, che la tecnica fiscale consente di tassare, entrano medesimamente nei bilanci della spesa degli uomini. Per gli uni essi entreranno a comporre il 50% della sua spesa, per altri il 30%, e per altri ancora il 20%. Non tutti consumano nelle medesime proporzioni servizi di abitazione, di domestici, di vetture, di pane, di alcool, di sale, di tabacco. Le proporzioni dei consumi nei bilanci famigliari variano all’infinito, onde una imposta del 10% sui consumi tassati equivarrà ad un tributo del 5% sulla spesa totale nei casi in cui i consumi tassati siano il 50% dei consumi totali, o del 3%, se la proporzione dei consumi tassati ai consumi totali sia del 30%, o ancora del 2% se quella proporzione diminuisca al 20%. Bisognerebbe fare una indagine statistica assai minuziosa per vedere in che misura i singoli consumi entrano nei bilanci della spesa e dedurne le regole con cui l’offesa alla uguaglianza possa essere ridotta al minimo ed insieme calcolare l’estensione della offesa nei sistemi tributari vigenti.
Mentre si attende questa indagine statistica, la quale sarà feconda di applicazioni fiscali interessantissime, si noti come la mancanza di proporzionalità appaia di gran lunga meno grave quando si parta dal concetto del reddito consumato che non quando si assuma a criterio di giudizio il concetto del reddito guadagnato e come sia grandemente esagerato il baccano pseudo scientifico istituito nei tempi moderni contro le imposte sui consumi.
Infatti è chiaro che se si assume una proporzione variabile tra l’intiero reddito consumato e i consumi tassati, per esempio del 50, del 30 e del 20%, e se si colpiscono col 10 i consumi tassati, l’imposta starà all’intiero reddito consumato di 100 lire nelle proporzioni del 5, 3 e 2%, come sopra fu esposto; proporzioni tra di loro per fermo discordanti ed offensive del principio dell’uguaglianza. Ma l’offesa è vieppiù grave; se si bada al reddito guadagnato, che per Caio sarà precisamente di 100, essendo per lui fastidioso così il risparmiare come lo scemare il patrimonio posseduto per Tizio sarà di 80, essendochè egli consuma anno per anno un po’ per volta il patrimonio e per Sempronio sarà di 150, amando egli crescere gli averi suoi risparmiando od astenendosi dal consumarne l’incremento di valore. Si suppose come è verosimile, che Tizio, distruttore di ricchezze, abbia la proporzione più elevata, del 50%, di consumi tassati in rapporto ai consumi totali; essendo egli viziosissimo e propenso perciò a comprare di quei beni che lo stato più volentieri tassa o dovrebbe tassare, come l’alcool, il vino, le speranze di vincita al giuoco, il servidorame, i cavalli, ecc. ecc. Caio, conservatore, farà un consumo medio di quelle merci che sono percosse da imposta; e Sempronio, accumulatore, se ne asterrà deliberatamente, ripugnando a pagare i prezzi cresciuti per virtù dei balzelli. E l’imposta si comporterà così come si vede dal quadro seguente:
|
Tizio
|
Caio
|
Sempronio
|
| Reddito realizzato o consumato…… |
100
|
100
|
100
|
| Risparmio od aumento……………… |
–
|
–
|
50
|
| Consumo del patrimonio iniziale…… |
20
|
–
|
–
|
| Reddito guadagnato………………… |
80
|
100
|
150
|
| Consumi tassati …………………….. |
50
|
30
|
20
|
| Imposta 10% sui consumi………….. |
5
|
3
|
2
|
| Proporzione dell’imposta al reddito consumato…………………………… |
5%
|
3%
|
2%
|
| Proporzione dell’imposta al reddito guadagnato …………………………. |
6,25%
|
3%
|
1,33%
|
Il quadro in breve cerchia spiega la varietà dei giudizi che si danno intorno alle imposte sui consumi a seconda che si parte dal concetto del reddito consumato o del reddito guadagnato. Chi per fede innata crede nel dogma della tassazione del reddito guadagnato dovrà giudicarle assai più severamente di chi ritenga dimostrata dal teorema milliano la necessità di tassare soltanto il reddito consumato. Imperocché, per questi le sperequazioni od offese al postulato dell’uguaglianza, stanno come 2 a 5; e non dipendono, se non in quella parte che poi si dirà, dalla volontà dell’uomo, sibbene in gran parte dalla possibilità oggettiva tecnica di scegliere ad oggetto di tassazione precisamente quei servigi, che, nel loro complesso, compongano una proporzione approssimativamente uguale del reddito consumato dei contribuenti. Problema difficile, ma non del tutto insolubile, almeno con quella larga approssimazione che nelle cose umane in genere e tributarie in ispecie si impone. Non è assurdo sperare di riuscire a tassare consumi che stiano, in proporzione al reddito consumato, nel rappotto del 50, 45 e 40% invece che del 50, 30 e 20%, come sopra fu supposto; ed allora lo scarto nella tassazione si ridurrebbe da 5 a 4 e sarebbe comportabilissimo e rimediabile con avvedimenti già noti. Invece chi crede alla tassazione del reddito guadagnato, ha fondata ragione di mostrarsi ben altrimenti inorridito dinnanzi ai tributi sui consumi; perché la proporzione di essi al reddito guadagnato varia non solo in funzione dell’abilità dello stato ad aspettare al varco i consumi, ma ancora in funzione della fantasia umana la quale fa essere gli uni conservatori dei patrimoni, gli altri dilapidatori e gli ultimi accumulatori. Soltanto a Caio, ossia all’uomo neutro, consumatore di ciò che possiede e contento di spendere tutto il guadagnato è indifferente essere tassato nell’una o nell’altra maniera; mentre Tizio, dilapidatore, vede la proporzione dell’imposta essere maggiore sul guadagnato che sul consumato, perché le 5 lire d’imposta si ragguagliano nel primo caso ad 80 lire di reddito e nel secondo caso a 100; onde egli preferirebbe essere tassato sulle 80, perché fermo restando il fabbisogno dello stato in 5+3+2 ossia 10, egli spererebbe di contribuire non in ragione dei 5/10, ma solo degli 8/33. Dal canto suo Sempronio, accumulatore, gioisce per la tassazione sul consumato; perché in tal modo paga solo 2 lire, ossia 2/10 del fabbisogno totale dello stato; mentre se fosse tassato in proporzione del reddito guadagnato egli dovrebbe pagare i 15/33 del fabbisogno medesimo. Dal che si vede come il sistema della tassazione del reddito consumato porta a sgravare i risparmiatori e ad aggravare i distruttori di ricchezza, lasciando indifferenti gli uomini medi, a Dio spiacenti ed ai nimici sui. Ma ciò irrita grandemente gli uomini di grande fede, i quali considerano come un postulato di giustizia la tassazione sul guadagnato; e subito esclamano che le imposte sui consumi sono inique, tassando Tizio col 6,25%, Caio col 3% e Sempronio coll’1,33%; ed additano il povero bisognoso (è noto che gli uomini della tribù dei Tizii sono sempre, agli occhi di taluni, poveri bisognosi), il quale tanto più è tassato quanto più la sventura lo costringe a dar fondo al suo patrimonio; mentre i Sempronii, avari, grandemente arricchiscono e in premio della loro progressiva accumulazione ottengono il guiderdone di imposte decrescenti. Onde basta essere avaro per pagare poche o punte imposte; mentre la generosità e l’altruismo sono puniti con balzelli opprimenti. Così discorrono gli uomini del reddito guadagnato; e non s’accorgono che le loro querimonie discendono dalla superstizione in che sono incappati di volere ad ogni costo considerare il reddito guadagnato come l’«unico» e «vero» reddito. Ed essendo cotesto reddito caratterizzato dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci, dal riprodursi cioè, per illusione ottica, del medesimo oggetto ripetute volte sotto variate spoglie, qual meraviglia che essi inferociscano nel vedere immuni da imposta le ombre ripetute dell’unico oggetto tassabile?
La maggior sperequazione od «iniquità» delle imposte sui consumi in confronto al reddito guadagnato, più che non al consumato, ancor meglio si vede quando si faccia astrazione dalle sperequazioni che sappiamo esistere anche in rapporto a quest’ultimo concetto. Supponiamo cioè che il legislatore sia riuscito a scovrire un gruppo di consumi tassabili che costituiscano una proporzione costante del totale reddito consumato. L’imposta diventa «equa» rispetto al reddito consumato; ma è ancora «iniqua» rispetto ai reddito guadagnato. Come si vede dal seguente specchietto:
|
Tizio
|
Caio
|
Sempronio
|
| Reddito realizzato o consumato…… |
100
|
100
|
100
|
| Risparmio od aumento di patrimonio……………………………. |
–
|
–
|
50
|
| Consumo di patrimonio ………………. |
20
|
–
|
–
|
| Reddito guadagnato………………… |
80
|
100
|
150
|
| Consumi tassati …………………….. |
33
|
33
|
33
|
| Imposta 10% sui consumi………….. |
3.33
|
3.33
|
3.33
|
| Proporzione dell’imposta al reddito consumato…………………………… |
3.33%
|
3.33%
|
3.33%
|
| Proporzione dell’imposta al reddito guadagnato …………………………. |
4,16%
|
3.33%
|
2,22%
|
L’imposta sul guadagnato è maggiore dell’equo su Tizio, perché tassa altresì le 20 lire che i «credenti» considerano capitale intangibile e minore dell’equo su Sempronio: perché esenta le 50 lire che si reputano reddito benché siano risparmiate. Lasciamo i credenti stridere a loro posta per la fede conculcata, non essendovi rimedio alcuno contro le superstizioni; e limitiamoci a constatare come per noi, che credenti non siamo nel dogma del reddito guadagnato, le «iniquità» delle imposte sui consumi appaiono meno gravi che ad essi ed inoltre esclusivamente dipendenti da difficoltà tecniche, non impossibili a superarsi.
- A consolare alquanto i «credenti» vogliamo qui di seguito addurre quello che è davvero il difetto più grave delle imposte sui consumi, sebbene da loro non visto ed anzi neppure reputato un difetto: vuolsi accennare alla possibilità di tassare col loro strumento una parte del risparmio, che per distinguerlo dal risparmio ordinario capitalistico, chiamiamo «risparmio personale». È certissima cosa che le imposte sui consumi esentano tutto il risparmio che ha forma di depositi bancari, di investimenti fondiari, edilizi, mobiliari ed anche i semplici tesoreggiamenti; perché tutto il numerario disponibile che non è destinato a compra di servizi utili è senz’altro, per definizione, esente da un’imposta la quale può soltanto colpire la ricchezza quando sia spesa nell’acquisto di servizi consumabili. Questo è il risparmio «capitalistico» ed è l’unico che di solito sia preso in considerazione quando si parla di risparmio. Accanto a questa maniera di risparmio esiste e cresce d’importanza una seconda maniera: il risparmio personale, che consiste nello spendere che faccia l’uomo parte del suo numerario disponibile nel perfezionamento, fisico e intellettuale, di se stesso e dalle persone da lui dipendenti, sovratutto i figli. La linea di distinzione fra ciò che è spesa e ciò che è risparmio personale non è facile ad essere tracciata e meriterebbe uno studio apposito. Pare che il criterio fondamentale per distinguere sia quello stesso che serve a distinguere in genere la spesa dal risparmio: se cioè la spesa sia tale da esaurire per il contribuente il suo effetto in uno spazio breve di tempo che nelle faccende tributarie è giuocoforza assumere sia l’anno finanziario, ovvero estenda la sua efficacia ad un periodo di tempo più lungo. Così se uno viaggia o va ai bagni o ai monti per semplice diletto o per rinfrancare la salute scossa, quella è spesa e non risparmio. Egli aveva risparmiato prima quando mise da parte il numerario occorrente a quella spesa; e doveva essere teoricamente esentato in un precedente anno finanziario, salvo a pagare oggi. Che se invece l’uomo viaggia per procurarsi cognizioni, apprendere le modalità di arti o industrie famose in contrade straniere allora la spesa per ciò sostenuta deve essere reputata un investimento di capitali, un risparmio, che, esente oggi da tributo, dovrà assolverlo quando darà frutti di maggior rendimento professionale o industriale e questi saranno consumati per procacciare all’uomo godimenti immediati.
Il risparmio personale è di due maniere: egoistico e di specie. Il primo è fatto per migliorare se stesso e rendersi atto a lucrare maggiormente nella vita futura. Ha per caratteristica di essere in generale poco rilevante, perché l’uomo, durante la sua vita produttiva, che va dai 15-25 ai 55-65 anni circa, vive consuetamente sul fondo di vitalità e di cognizioni acquistato nella prima parte della vita; e cerca soltanto di conservarlo e qua e là migliorarlo. Il risparmio personale egoistico si esaurisce colla fine della vita produttiva; poiché quando l’uomo ha finito di guadagnare, ai 55-65 anni, egli può vivere unicamente sul fondo trasmessogli dalle età precedenti, e salvo eccezioni rarissime, non lo può più crescere. Anzi, non potendo più lavorare, per il venir meno delle forze, egli deve vivere sui frutti del risparmio capitalistico proprio, compiuto nelle età precedenti, che è il solo che possa essere apparecchiato a pro della vecchiaia.
Più importante assai è il risparmio personale di specie. Per esso l’uomo rinuncia a godere la ricchezza presente e la trasforma in spese di allevamento, di istruzione ed educazione dei figli, delle generazioni nuove. Per questo risparmio si può ripetere lo stesso ragionamento che si fece per il risparmio capitalistico. Tizio, padre di tre figli, sul suo reddito guadagnato di 10.000, consacra 5.000 lire alle spese correnti sue e della moglie, e dei vecchi genitori, se ancora vivono; e queste sono reddito consumato per godimenti presenti; economizza 2.500 lire, che versa su un libretto di risparmio al 5% e investe 2.500 lire nell’allevare, istruire ed educare i suoi figli. Se tutte le 10.000 lire fossero tassate (tassazione del reddito guadagnato), evidente sarebbe la doppia tassazione per ambe le maniere di risparmio, capitalistico e personale. Le 5.000 lire consumate per godimenti presenti del contribuente pagherebbero infatti 500 lire d’imposta attuale e nulla più; mentre le 2.500 lire di risparmio capitalistico pagherebbero subito 250 lire e poi ancora 11,25 all’anno sull’annualità perpetua di reddito di lire 112,50 fruttate dalle 2.250 risparmiate dopo il prelievo dell’imposta, ossia altre 225 lire di imposta calcolata al suo valore attuale. Lo stesso accadrebbe per le 2.500 lire di risparmio personale di specie; perché, oltre le 250 lire di tributo da lui pagato subito, i figli suoi, quando saranno giunti all’età di 15/25 anni e lucreranno un maggior salario annuo, che non lucrerebbero se il genitore li avesse lasciati premorire, o non se ne fosse curato, lasciandoli diventare vagabondi o mendichi o criminali o semplicemente li avesse fatti crescere capaci a lavori ordinari, su quel maggior salario pagheranno imposta. E poiché quel sovrappiù di salario in confronto ai salari dell’operaio comune può essere economicamente considerato come la restituzione ed insieme il frutto di tutte le somme investite dalla generazione passata e che non sarebbero state investite se non si fosse preveduto che avrebbero recato frutto, così è manifesto che, se prima si tassa la somma investita e poi quella, maggiore, restituita, vi è doppia tassazione. Si rifletta ora quanto sia grande l’importanza di educare ed istruire le nuove generazioni per accrescere la ricchezza ed il benessere del paese; e come non a torto a molti pensatori paiano ugualmente fruttiferi gli investimenti fatti nel crescere l’abilità tecnica, la sapienza teorica, l’attitudine artistica del popolo in confronto a quelli che consistono nel bonificar terre o comprare o costruire macchine nuove. Si pensi come, se da sole le qualità personali a nulla varrebbero senza l’ausilio del capitale, i risparmi capitalistici sarebbero del pari inutili ed infruttiferi se non vi fossero gli uomini atti a trarne partito, impiantando nuove imprese o perfezionando quelle esistenti od inventando nuove maniere di soddisfare ai bisogni umani; e si rimarrà persuasi della opportunità del rivolgimento operatosi nell’ultimo mezzo secolo, per cui le scuole, prima neglette, stanno o dovrebbero stare al sommo dei pensieri d’ogni statista; e si rimarrà convinti della importanza straordinaria del risparmio personale «di specie».
Nessun tributo può essere considerato corretto, in rapporto alle premesse poste in principio, se non esenta, insieme al risparmio capitalistico, altresì il risparmio personale, ed è chiaro perciò come sotto questo rispetto le imposte sui consumi siano scorrette; poiché esse tassando oggettivamente la spesa per alloggio, per servitori, per servizi personali, per cibi, per vestiti, colpiscono ugualmente sia la quota destinata a gratificazione personale presente del contribuente sia la quota destinata ad incremento della capacità produttiva futura sua o dei suoi figli. Sennonché il difetto, il quale dovrebbe servire a far dichiarare scorrette pure le imposte sul reddito guadagnato, le quali in più hanno il vizio loro, proprio della tassazione del risparmio capitalistico, sembra assai più agevolmente evitabile, almeno in parte, nelle imposte sul reddito consumato che in quelle sul reddito guadagnato. Infatti, mentre bisognerà per queste assumere delle presunzioni di risparmio personale per classi, più o meno lontane della verità, è possibile regolare le imposte sui consumi in modo che alle presunzioni per classi si aggiungano immunità particolari delle spese destinate all’istruzione ed educazione dei figli ed al miglioramento proprio. A ciò giovano massimamente i due vizi – che perciò diventano qui due qualità – della parzialità e della non proporzionalità delle imposte sui consumi. Basta non tassare i servizi dell’istruzione e dell’educazione, ossia non mettere alcuna imposta sulla spesa fatta per comprar libri, per seguire corsi scolastici elementari, medi, o superiori, classici o tecnici o commerciali;[4] e disporre i tributi sui consumi in maniera da scegliere preferibilmente come oggetto di tassazione quei servizi che non conferiscono al miglioramento della capacità produttiva dell’individuo od all’elevazione della specie. Per una fortunata coincidenza, i consumi che meglio si prestano tecnicamente ad essere tassati non cadono quasi mai nel novero dei consumi «educativi»; basti accennare ai fondamentali piedestalli dell’edificio gabellario d’ogni paese: bevande alcooliche, tabacco, caffè, tè, giuochi. Qualcuno di questi consumi sollecita transitoriamente le attitudini nervose dell’uomo, nessuno ne accresce in modo definitivo vigoria fisica o la potenza intellettuale; anzi tutti la diminuiscono per verdetto quasi concorde degli studiosi. Nessuno di quei consumi può essere considerato come un investimento di risparmio a pro delle nuove generazioni. Che se dalle imposte sui consumi propriamente dette passiamo alle imposte suntuarie, che appartengono alla stessa categoria delle imposte sulla spesa, non si potrà certo affermare che con esse, ossia tassando la spesa per il servidorame, per i cani, cavalli, automobili, mobilio, casa, si colpisca qualche porzione di risparmio personale. Ché anzi, ove non esistano imposte sui servizi dei precettori e degli insegnanti privati, quasi tutte quelle imposte colpiscono consumi volti non ad educare i giovani, sibbene a renderli incapaci al lavoro, rendendoli dipendenti da altri nelle faccende ordinarie della vita. Unica eccezione: l’imposta sul valor locativo della casa abitata, che vorrebbesi da tutti ampia, bella, soleggiata ad incremento della salute fisica e dello sviluppo intellettuale dei bambini e dei giovani. Ma nulla di così agevole come tener conto di questa esigenza: bastando esentare dalla tassazione una quota della spesa per la casa per ognuno dei membri della famiglia, una quota che sia più elevata per i ragazzi e i giovani che per gli uomini adulti, in guisa da distinguere quella che sia spesa per godimento presente dalla spesa fatta a preparare godimenti in un tempo futuro. Come più empiriche e grossolane ed erronee appaiono le analoghe deduzioni che, per lo stesso motivo, si pretendono concedere nelle imposte sui redditi guadagnati! Qui si concede, per esempio, la detrazione del reddito guadagnato di 400 lire per ogni membro della famiglia nella ipotesi che esse servano in parte a procacciare l’agio di una casa più ampia ai bambini brulicanti; ed invece il padre di famiglia egoisticamente costipa la prole in angusta camera per avere margine a procacciare nelle osterie gran copia di cibo o di vino a se stesso. Mentre la detrazione di un decimo dal valore locativo della casa abitata per ogni persona componente la famiglia viene data sulla spesa effettivamente fatta per la casa, cosicché il padre di quattro figli otterrà per le sei persone della sua famiglia (compresa la moglie) la detrazione di sei decimi del fitto, ossia di 300 lire se ne spende 500, di 600 se ne spende 1.000, di 1.200 se ne spende 2.000; e quindi a mano a mano diminuirà di fatto (e non solo per presunzione generica, che può essere erratissima nei casi singoli) la spesa per alcool, vino, tabacco, eccitanti, giuochi, e crescerà la spesa per la casa, diminuirà l’imposta pagata dal contribuente, in esatta proporzione al sostituirsi nel suo bilancio famigliare dei risparmi personali individuali o dispecie alle spese risultanti in godimenti presenti.
Talché si può concludere, che il difetto massimo che per noi si riscontra nelle imposte sui consumi, di non concedere l’immunità doverosa al risparmio personale, può essere facilmente e quasi in tutto evitato; fornendo, in aggiunta, un preziosissimo criterio per distinguere tra i consumi che devono essere tassati e quelli che devono essere esenti da un contributo il quale, per necessità tecniche, non può essere universale. Ed un altro canone fondamentale si può ricavare dalle cose dette dianzi intorno al «contribuente». Già dissi per incidente, che s’era assunta nella trattazione l’ipotesi che «contribuente» obbligato a pagare l’imposta fosse esclusivamente la persona fisica, della quale ipotesi, che si suppone dimostrata, non è qui il luogo di dire le ragioni. Adesso si può aggiungere che non tutte le persone fisiche sono contribuenti, sibbene quelle soltanto che hanno oltrepassata la minore età, intendendo questa nel significato economico di età nella quale si consuma ricchezza destinata a fruttare in un periodo successivo. La maggiore età varia a seconda delle classi sociali; e sarà dai 12 ai 15 anni per la classe manuale agricola ed operaia, dai 18 ai 20 per la borghesia commerciale o burocratica, dai 21 ai 25 per i professionisti ed i capi di imprese. Fino a quelle età l’uomo non deve essere considerato un consumatore di ricchezza, bensì un recipiente di risparmio, quasi un libretto di risparmio vincolato a certa scadenza, su cui si fanno versamenti sotto colore di cibi, vestiti, casa, istruzione, educazione, versamenti di cui non potrà essere richiesto il rimborso se non quando l’uomo sia giunto alla maggiore età economica e sia in grado di lucrare salari, stipendi, guadagni professionali, lucri d’intrapresa. Durante la minore età economica l’uomo non è contribuente, perché tutto ciò che consuma è risparmio, è investimento personale. Dopo la maggiore età egli diventa contribuente, perché egli comincia a realizzare i frutti dell’investita fatta a suo profitto, guadagnando e consumando salari e altre maniere di lucri. Né alcuna eccezione può farsi per i minori d’età che vivono di redditi patrimoniali proprii; perché o le spese da essi (o dai loro tutori) fatte tornano a vantaggio della formazione loro fisica od intellettuale e sono risparmi e come tali vanno esenti; o sono spese inutili per quel fine ed essi stessi le vogliono ed allora, sebbene abbiano pochi anni ed esperienza piccola, costoro debbono reputarsi aver raggiunta la maggiore età economica e diventano perciò stesso contribuenti; ovvero, essendo ancora quelle spese inutili per quel fine, essi ne sono l’involontario pretesto ed allora i veri contribuenti non sono i minori d’età, bensì i tutori e curatori che s’approfittano, a proprio vantaggio e spasso, delle rendite del pupillo affidato alle loro cure.
- Ben si può dunque passar sopra, dopo le cose discorse, nelle quali si vollero valutare con la maggiore esattezza possibile gli scarti reali delle imposte sui consumi dalla ideale imposta sul reddito consumato, a taluni pretesi difetti delle imposte sui consumi, che in realtà non sussistono.
Nulla vale l’obbiezione che le imposte sui consumi tassano i prodighi e risparmiano gli avari; alla quale si rispose già osservando che gli avari sono mitemente tassati solo in quanto si industrino a rinunciare in parte al proprio reddito guadagnato e, poco consumandone a proprio beneficio, lo volgano prevalentemente a beneficio altrui. E similmente si può rispondere a quelli che gridano al privilegio dei ricchi, i quali unicamente possono risparmiare, mentre i poveri non capitali, ma prole soltanto sono in grado di dare alla patria; anzi a costoro si può rispondere con le stesse parole di Giovanni Stuart Mill:
«che il privilegio elargito [ai ricchi] solo in quanto essi abdichino all’uso personale della loro ricchezza; in quanto essi distolgano il loro reddito dal soddisfacimento dei loro bisogni personali a pro di un investimento produttivo in guisa da, distribuirlo in salari tra i poveri, invece di goderselo essi stessi. Se ciò significa favorire i ricchi, io amerei mi fosse detto quale maniera di ripartire le imposte meriti d’essere chiamata favoreggiatrice dei poveri».
Alla quale risposta si può aggiungere quell’osservazione fatta dianzi, che lo Stuart Mill non aveva veduto nel pur densissimo brano consacrato all’argomento: non essere il risparmio capitalistico la sola maniera possibile di risparmio; essere anzi desso sopravanzato in importanza dal risparmio personale, accessibile ai ricchi come ai poveri, e per avvedimenti già esposti, esentabile così per gli uni come per gli altri. S’aggiunga doversi dare ancora la dimostrazione probante che pure il risparmio capitalistico sia di fatto compiuto sovratutto dai già ricchi; e non invece da quelli che stanno diventando tali da mediocri o poveri quali erano. Il che del resto non ci interessa direttamente, bastando all’assunto esentare il risparmio, da chiunque e in qualunque maniera sia compiuto.
Nulla monta l’altra obbiezione che le imposte sui consumi danneggino i padri di numerosa prole in confronto ai genitori sterili od agli scapoli. Intanto non si capisce perché in argomenti tributari si abbiano a introdurre surrettiziamente propositi politici o sociali di lotta contro la sterilità crescente o contro la propaganda malthusiana. Questi sono discorsi che nulla hanno a che fare con le imposte. Il legislatore potrà, volendo partire in guerra contro la minaccia di spopolamento o persuadere gli egoisti individuali a diventare egoisti di specie, altresì valersi dello strumento fiscale; ma non saranno «imposte» le sue, sebbene «multe». Le quali esigono una teoria tutta loro particolare, supposto che esse comportino una teoria; della quale ad ogni modo non è questo il momento d’impacciarsi. né dicasi che anche noi vogliamo promuovere il risparmio con l’esenzione punire la spesa con l’imposta, che l’obbiettatore dimostrerebbe di non aver nulla compreso intorno all’indole delle nostre argomentazioni; ed a lui si potrebbe rispondere ancora con le parole di Stuart Mill (e con questa citazione è chiusa la riproduzione delle brevi chiose aggiunte dall’economista inglese al brano fondamentale citato sopra nel capo secondo) contro chi gli rimproverava
«che la legge non dovrebbe perturbare, con interventi artificiosi, la naturale concorrenza tra i nuovi per risparmiare e quelli per spendere»:
essere vero invece
«che la legge perturba questa naturale concorrenza quando essa tassa i risparmi e non quando li esenta; poiché, siccome i risparmi pagano in ogni caso l’intiera imposta appena essi sono investiti, la loro esenzione dall’imposta nello stadio precedente è necessaria per evitare che essi paghino due volte, mentre il consumo paga solo una volta».
Dunque alle famiglie grosse si dovranno concedere agevolezze per la parte risparmiata del loro reddito, sia che essendo agiati o ricchi possano investire risparmi capitalisticamente, sia che si debbano contentare di risparmi personali investiti sulla testa dei numerosi figliuoli; non si dovranno concedere se nulla risparmiano in una maniera o nell’altra, salvo ché, per considerazioni extravaganti, che qui sfuggono ad una esatta valutazione, il legislatore non credesse di esentarle concedendo, a guisa di premio, l’esenzione dall’imposta.
Neppure può essere accolta l’obbiezione che l’imposta sulla spesa colpisce talvolta la spesa fatta non per godimento personale, ma a guisa di lustra destinata ad attirare clientela all’ufficio professionale o alla banca o alla bottega. Trattasi di questione secondariissima; e rispetto a cui si può solo affermare che devesi, nei limiti del possibile, distinguere fra ciò che è spesa per la casa da ciò che è spesa per l’esercizio dell’impresa. Dovendosi escludere, in un sistema ben costrutto di imposte sul reddito consumato, ogni tassazione sui locali d’ufficio, sul personale di studio o di negozio. Che se un tale, privo di redditi guadagnati proprii, tuttavia spende per uccellare ai gonzi, ragion vuole si constati il fatto della spesa, che almeno in apparenza è rivolta a suo beneficio e la si tassi.
VII
Costruzione di un sistema corretto di imposte sul reddito consumato
Volendosi ora costruire un sistema di imposte sui consumi che soddisfi alle condizioni che sopra si dissero, di essere cioè se non universali, il che è impossibile, almanco in proporzione costante al reddito consumato e di esentare il risparmio personale, soccorre primamente una regola, ottima in via approssimativa, la quale dice: doversi scegliere innanzitutto come oggetto di tassazione quelle merci o quei servizi in cui si investono le rendite di consumatore lasciate disponibili dal consumo di quei beni che vengono primissimi nell’ordine dei consumi e che sono indispensabili alla vita fisica del contribuente.
Ampio è lo scarto tra i prezzi delle merci che il consumatore effettivamente paga, date le condizioni correnti del mercato, e i prezzi che egli potrebbe pagare se in circostanze diverse il mercato imponesse prezzi più elevati. Il consumatore paga il pane di frumento 40 centesimi per chilogrammo in condizioni normali medie, dati i costi della farina, dei fitti, dei salari, del logorio del macchinario e strumenti ecc. e data la richiesta esistente; ma pagherebbe ben più, 1 lira, 2, 3, forse anche 10 lire per chilogrammo in caso di carestia, blocco marittimo, assedio di una piazza forte. Il massimo prezzo a cui il consumatore può spingersi varia a seconda della ricchezza sua e di altri fattori; il povero potrà giungere sino a 1 lira, l’agiato sino a 3, il ricco sino a 10 lire ed in casi estremi, pur di aver salva la vita, a prezzi ancor più elevati, quasi fantastici. La differenza tra il prezzo che si sarebbe in altre circostanze indotti a pagare ed il prezzo che effettivamente si paga chiamasi rendita o guadagno del consumatore. Questo concetto, la cui importanza non conviene esagerare, può essere utilizzato per scegliere le merci le quali conviene colpire coll’imposta.
In una prima approssimazione è indifferente tassare il sale o il caffè, il petrolio o il vino, il pane o il tabacco, perché, come hanno dimostrato egregiamente il Gobbi e il Pantaleoni,[5] dato che una imposta di 100 debba essere pagata, nulla importa il nome che viene dato all’imposta, se di imposta sul sale o sul tabacco, o sui giuochi, o sul valor locativo o sul reddito. Sempre l’imposta di 100 verrà pagata dal contribuente mercé il sacrificio dei consumi marginali, i quali vengono ultimi nell’ordine delle sue spese, qualunque siano i consumi colpiti dall’imposta ed i pretesti con i quali viene esatta. In altri termini, se l’imposta è messa sul sale, il contribuente non sarà nient’affatto obbligato a ridurre il consumo del sale; ma potrà comprarne, a prezzo aumentato, la stessa quantità di prima, rinunciando in tutto od in parte al consumo del tabacco. Il che vuol dire che il prezzo precedente del sale lasciava al consumatore una rendita, da lui inavvertita, la quale veniva destinata alla compra di tabacco. Questa verità non rimane scrollata dall’ovvia osservazione, pur verissima, che spesso l’aumento del prezzo di un bene, in conseguenza dell’imposta, fa diminuire il consumo per l’appunto di quel bene e non di altri; come può accadere per le imposte sul valor locativo; perché questo fatto vuol dire soltanto che prima il contribuente usava investire il guadagno o la rendita goduta per il fatto che il fitto di tre stanze era di 300 lire, mentre egli sarebbe stato disposto a pagarne, occorrendo, 400, nel consumo di una quarta stanza; laddove ora, crescendo, a causa dell’imposta, il fitto di tre stanze a 400 lire e non rimanendogli più alcuna rendita disponibile, egli deve ristringere il suo consumo a quelle tre stanze e non più.
Codesta verità dipende però dalla premessa: dato che una imposta di 100 debba essere pagata. La qual premessa si tratta appunto di vedere quando debba essere resa effettiva dal legislatore. Orbene io dico che l’imposta deve colpire di preferenza le merci, i beni, i servizi nella cui compra si investono le rendite di consumatore lasciate libere dall’acquisto, ai prezzi di mercato, di beni, merci, servizi che vengono prima nell’ordine dei consumi. In ogni paese, per ogni classe sociale, per ogni individuo esiste una scala nell’ordine dei consumi. Non si vuol dire con ciò che alcuni beni siano necessari, altri di comodità, altri di lusso, come usavano gli antichi trattatisti. Siffatta distinzione, se fatta in via generale ed assoluta, sarebbe assurda, come quella che non tiene conto delle variazioni stragrandi nei gusti degli uomini da epoca ad epoca, da paese a paese, da classe a classe, da persona a persona. Ma è certo, che per ogni paese e per le diverse classi si possono in ogni tempo constatare empiricamente, statisticamente quali siano i consumi primari e quali quelli secondari o terziari. Studiando un numero sufficientemente ampio e vario di bilanci famigliari, siffatta nozione empirica può essere acquisita. Si sappia dunque che gli uomini prima cominciano a consumare pane e verdura e poi carni; prima una stanza e poi due e poi tre; prima vestiti di cotone e poi vestiti di lana e di seta; prima pane e minestra e vestiti e casa e poi vino e giuochi e tabacco e servitori, prima petrolio e poi luce elettrica. E si sappia senz’altro che nelle carni, negli alloggi ampi, nei vestiti di seta, nel vino, nei giuochi, nel tabacco, nei servitori, nella luce elettrica si investono le rendite lasciate disponibili ai consumatori dopo che essi hanno provveduto a comprare, ai prezzi correnti, pane, verdura, vestiti di cotone, alloggi da una stanza, petrolio ed altrettali beni primari. Quindi ancora se noi faremo cadere l’imposta sui consumi secondari sapremo come cosa certissima che quei contribuenti i quali hanno appena tanto reddito [consumato] da poter comprare beni primari, non pagheranno imposta veruna; e che quelli a cui avanzano poche rendite, dopo il consumo dei beni primari, pagheranno poca imposta e molta ne pagheranno quelli a cui avanzano grosse rendite. Dunque è tutt’altro che indifferente tassare o l’una o l’altra specie di merci, sebbene sia indifferente prelevare la medesima imposta con uno o con altro nome. In questo caso trattasi soltanto di cambiar nome ad una imposta certamente esatta; nel primo invece dubitasi se imporla ovvero no.
A non imporla non si è, nel sistema ora delineato delle imposte sui consumi, spinti da considerazioni umanitarie o psicologiche intorno ai redditi minimi. Nessun concetto estraneo deve penetrare nel campo dove impera il postulato dell’uguaglianza. Se chi ha appena una lira al giorno (reddito che in Italia stimasi universalmente minimo) spende 50 centesimi in pane e 50 centesimi in vino e se il pane è reputato consumo primario e il vino consumo secondario, quegli deve essere esente da imposta sui 50 centesimi di pane ma percosso sui 50 centesimi di vino. Né si ritenga che i consumi «primari» debbano essere esenti perché si indicano con siffatto aggettivo o perché siano necessari alla vita fisica del contribuente, il quale altrimenti morrebbe di fame. Questa non può essere una buona ragione per esimerlo dai tributi, in contraddizione col principio della tassazione del reddito consumato intiero; bensì per raccomandarlo alla pietà del legislatore, il quale gli farà l’elemosina di rimborsargli l’imposta pagata (l’esenzione apparente è solo un ripiego contabile per evitare inutili scritturazioni di incasso di imposte e di erogazione di elemosine, con conseguenti elevatissimi costi di esazione e di carità legale), elemosina condizionata talora alla perdita dei diritti elettorali, alla prigionia nelle case di lavoro (workhouses), all’infamia civica e talaltra nobilitata ed incoraggiata sotto nome di panem et circenses, di pensioni di stato, di diritto all’esistenza, ecc. ecc.
La vera ragione per cui i consumi primari debbono andare esenti da imposta è quest’altra: che essi si suppongono destinati a risparmio personale, individuale o di specie. La qual verità è certissima per i minori d’età, poiché ogni spesa fatta per tenerli in vita è una spesa d’allevamento, di formazione di un capitale che alla maggiore età [economica] diventerà produttivo di frutti consumabili. Ed è verità attendibilissima pure per gli uomini adulti, perché non tutta la spesa compiuta dall’uomo adulto è spesa per godimenti personali; una parte potendo essere considerata come una quota di riparazione e di sostituzione della macchina uomo, quota dunque di risparmio che si capitalizza per dar frutti nel periodo successivo. I fisiologi insegnano che le cellule dell’uomo continuamente si logorano e vengono sostituite; dimodochè l’uomo di 50 anni è composto di una materia tutt’affatto diversa da quella ond’era composto al ventesimo anno di età. Traducendo la qual proposizione in linguaggio economico, si può dire che ad ogni anno o ad ogni momento, finché dura la vita produttiva dell’uomo, vi è una parte della spesa che non dà godimento all’uomo, ma giova soltanto a metterlo in condizioni di potere fruttare e godere nell’anno o nel momento successivo. E poiché la finanza non può tener conto di spazi minimi di tempo, parlisi soltanto di anni intieri. Nell’anno corrente l’organismo dell’uomo è produttore di ricchezza ed un ricettacolo di sensazioni piacevoli; ma cesserebbe di esserlo nell’anno successivo, se col consumo di beni primari non si ricostituissero le cellule distrutte; dunque quei beni primari non sono consumati, sibbene impiegati produttivamente a creare la possibilità di consumi veri e proprii negli anni successivi, possibilità che sarà misurata precisamente dalla quantità di beni secondari che saranno consumati in quegli anni.
S’intende che questi sono concetti generalissimi, che giovano soltanto a dare un indirizzo all’azione pratica del legislatore. Ma paiono concetti fecondi, perché pongono termine alle oziose quistioni intorno all’esenzione dei redditi minimi, se il minimo debba intendersi un assoluto necessario alla vita fisica dell’uomo od un relativo variabile a seconda del tenor di vita delle classi sociali; se debba concedersi l’esenzione del minimo solo per quelli che non lo superino od anche, fino alla sua concorrenza, a quelli che abbiano redditi maggiori e magari vistosissimi; questioni che si decidevano a norma di considerazioni extravaganti. Secondo il sistema derivato dal postulato dell’uguaglianza si dirà che è esente tutta quella quantità di ricchezza che per essere consumata in beni primari può considerarsi come un risparmio personale; quindi una quantità non relativa ai diversi gradi di fortuna od alle diverse classi sociali, ma quantità oggettiva di beni che l’opinione comune del tempo dichiara investiti per il perfezionamento fisico od intellettuale e per il proseguimento dell’esistenza medesima dell’uomo. Tanto i ricchi come i poveri ed i mediocri possono aspirare a questa esenzione; e la raggiungono di fatto ove consumino beni primari considerati fatti a scopo di risparmio o capitalizzazione personale. E poiché variano, a seconda della ricchezza e del tenor di vita, le spese considerate necessarie per l’allevamento della prole e per il mantenimento della produttività negli adulti, così è spiegabile perché il minimo da esentarsi, non sia un fisso, ma varii in relazione coi tempi e coi luoghi. Si comprende così la ragione per la quale un giorno l’imposta di macinato tassava il pane di frumento ed esentava il pane di segala, di barbariato, d’orzo, di miglio, perché questi erano assai più usitati del primo ed erano la base della alimentazione; mentre a mano a mano cresce la raffinatezza del vivere, crescono di finezza anche i consumi risparmio, maggiori cure essendo reputate necessarie alla vita del fanciullo od alla fruttificazione dell’organismo adulto, considerato come un recipiente di risparmio capitalizzato in forma personale. Perciò si esenta il pane di frumento e poi il sale e poi ancora lo zucchero ed i vestiti e i valori locativi iniziali. Non per questo vien meno la materia imponibile; poiché se quello che era godimento una volta diviene oggi capitalizzazione nervosa, muscolare od intellettuale, sorgono nuovi beni e nuovi servizi atti a dare godimento e si profila una serie indefinita di tassazioni su di essi.
La teoria ora costrutta lascia un solo residuo da essa inesplicato; ed è l’esenzione concessa ai consumi primari non solo per i minori d’età e gli adulti per i quali può concepirsi una capitalizzazione, bensì anche per gli adulti dipendenti od oziosi o criminali (non accenno genericamente alle donne, perché esse sono in grandissima maggioranza produttrici di ricchezza sia col lavoro nelle fabbriche o a domicilio, sia colla gestione della casa, coll’allevamento della prole, ecc.) e per i vecchi. Per costoro il criterio del risparmio personale dovrebbe essere interpretato non nel senso che essi debbano fare certi consumi primari per poter produrre frutti in un periodo successivo, ché essi o non furono mai capaci di fruttare alcunché, o godono meritamente i frutti dei risparmi passati, né hanno alcun dovere di nuovamente risparmiare; bensì unicamente nel senso che essi debbano fare i consumi primari per conservarsi capaci di godere successivamente. Dicasi invece che, dovendosi applicare un principio, non si può far astrazione dal costo, che può essere eccessivo, della sua applicazione in maniera rigida e precisa. Poiché cioè si debbono esentare, in ossequio al canone della esenzione del risparmio, i consumi primari e poiché tecnicamente è impossibile distinguere tra consumi primari fatti dai minori di età e dagli adulti produttivi per cui l’esistenza del risparmio personale è indiscutibile, e consumi primari fatti da oziosi, criminali, vagabondi, mendichi, di cui sarebbe augurabile la scomparsa e non la conservazione, dai dipendenti e dai vecchi, per cui è dubbio se essi facciano risparmio personale; e poiché d’altra parte, fortunatamente, queste classi sono per numero meno importanti delle prime, così, in ossequio al canone del minimo costo d’esazione delle imposte (quarto canone già citato di Adamo Smith), l’esenzione deve essere estesa oggettivamente a tutti i consumi primari.
Ma anche così difettosa l’esenzione del minimo di reddito nel sistema delle imposte sul reddito consumato è più perfetta che nel sistema delle imposte sul reddito guadagnato. Perché in quelle vengono esentati di fatto solo quei consumi che effettivamente contribuiscono a crescere il valore dei capitali personali, o almeno che sono reputati atti a crescerlo nell’opinione comune interpretata dal legislatore; mentre in queste sono esentate 400 o 1.000 o 4.000 lire indifferenziate di reddito, sia che il contribuente le destini all’acquisto di beni risparmio ovvero alla compra di beni consumo, che forse distruggono e danneggiano l’organismo, rendendolo meno atto a dar frutti. Anche stavolta il sistema della tassazione del reddito consumato esenta i risparmi personali effettivi; mentre l’altro sistema che colpisce il reddito guadagnato esenta i risparmi presunti che possono non verificarsi.
La esenzione dall’imposta dei consumi primari, essendo richiesta dalla logica del sistema, produce due principalissime conseguenze logiche e perciò benefiche:
a) la imposta, che, potendo colpire, per ragioni tecniche, solo alcuni consumi, corre il rischio di non essere proporzionale al reddito consumato (Capo sesto, n. 2), meglio soddisfa al postulato dell’uguaglianza quando siano esenti i consumi primari. Siano infatti i redditi consumati totali, compreso il consumato a scopo di risparmio personale, di Tizio, Caio e Sempronio di 1.000, 5.000 e 14.000 lire. Siccome non tutto il reddito consumato può essere tassato, ma solo alcuni consumi, scegliendo a caso si è certi di offendere la regola dell’uguaglianza, per cui ogni lira di reddito consumato, a chiunque spetti, deve pagare l’uguale tributo. Ma l’offesa sarebbe massima se ad oggetto di tassazione si scegliessero i consumi primari. Perché questi hanno la caratteristica di essere in quantità assoluta non così diversi come sono diverse le quantità del reddito consumato totale. Alcuni volendo esagerare artificiosamente i difetti delle imposte sui consumi, o meglio delle imposte sui consumi risparmio, già abbastanza scorrette perché sia necessario esagerarne la scorrettezza, affermano che Tizio, Caio e Sempronio consumano l’uguale quantità, ad es. 700 lire, di beni primari. Il che è falso. Perché se Tizio consuma 700 lire di pane, cibi, vestiti, casa, Caio consumerà cibi più scelti, vestiti di panno più fino, casa più ampia; e Sempronio migliorerà e varierà ancor di più questi suoi consumi. Già si vide sopra che il concetto dei consumi primari o consumi risparmio è variabile da epoca ad epoca e da paese a paese; ma è variabile nel tempo stesso e nel medesimo paese altresì da classe a classe a seconda del tenor di vita, dell’ideale di cultura che si vuol raggiungere, della produttività futura a cui si mira. Dunque Caio non si contenta degli stessi beni primari che bastano a Tizio e Sempronio di quelli che paiono sufficienti a Caio. Questo soltanto si può ragionevolmente affermare: che i consumi primari, pur non rimanendo costanti, non crescono nella ragione medesima del crescere dei consumi totali: e ciò perché la fantasia e l’amore ai godimenti immediati sono per la comune degli uomini qualità o passioni ben più potenti della previdenza e dell’aspirazione al proprio miglioramento intellettuale o fisico; onde più volontieri, appena il bilancio famigliare si amplia, si corre dietro alle chimere (giuochi), alle vanità (abiti di lusso, domestici, cavalli, automobili) ed ai piaceri (vino, tabacco, donne, teatri, viaggi), che ai consumi veramente vantaggiosi alla vita. Del che sono testimonio suggestivo le difficoltà che s’incontrano a persuadere coloro, che pure largamente bevono o fumano o si pavoneggiano con vestiti di moda o con gioielli, a spendere somme più cospicue nella casa. Se Tizio perciò spende 700 su 1.000 lire per i consumi primari (e cioè il 70% del suo reddito); Caio spenderà una somma tra 500 e 2.500, mettiamo 1.500 (e cioè il 30% del suo reddito); e Sempronio una fra 500 e 5.000, supponiamo 2.800 ossia il 20% del reddito.
Il reddito totale consumato di questa società di tre contribuenti, Tizio, Caio e Sempronio, si decompone dunque in questa maniera:
|
|
Tizio |
Caio |
Sempronio |
Totale |
|
Reddito consumato totale, compreso il consumato a scopo di risp. personale
|
1.000
|
5.000 |
14.000 |
20.000 |
|
Reddito destinato a consumi primari o consumi risparmio esenti
|
700 |
1.500 |
2.800 |
5.000 |
|
Reddito destinato a consumi secondari
|
300 |
3.500 |
11.200 |
15.000 |
|
Conferimento proporzionale di ogni contribuente al fabbisogno pubblico supponendo che si tassino soltanto i consumi
|
primari |
14 |
30 |
56 |
100 |
|
secondari |
2 |
23,33 |
74,66 |
100 |
L’imposta deve, in ossequio al principio dell’uguaglianza tributaria, esentare i consumi primari, perché questi non sono reddito consumato, ma risparmio. Quindi una ripartizione delle imposte che costringesse Tizio a contribuire il 14% del fabbisogno totale, Caio il 30% e Sempronio il 56% sarebbe scorrettissima.[6] Nemmeno si potrebbe dire corretta del tutto una imposta la quale colpisse tutti i consumi secondari, perché anche questi possono comprendere somme destinate alla istruzione dei figli o al perfezionamento proprio (viaggio d’istruzione professionale). Ma è facilissima, anzi universale l’esenzione dei consumi educativi, come sopra si disse; essendo ben raro e strano che un governo colpisca di imposta le spese per libri, viaggi, maestri, ginnastica, ecc. Onde si può dire che la ripartizione del fabbisogno secondo la regola del 2%, del 23,33% e del 74,66% sia quella più vicina alla ripartizione corretta, dato che il contribuente provvederà da sé a procacciarsi l’esenzione per i consumi secondari che siano davvero consumi risparmio. Ed è evidente che a raggiungere questo secondo tipo di ripartizione gioverà assai che la scelta dei consumi tecnicamente passibili di imposta venga fatta soltanto tra i consumi secondari e non tra questi e quelli primari insieme. Poiché questi stando fra di loro nei rapporti, assai diversi, del 14, 30 e 56%, una scelta fatta tra amendue rischia di allontanarsi assai dalla proporzionalità corretta. Tanto più rischierebbe di allontanarsene in quanto i consumi primari, sebbene variabili da persona a persona, non sono variabilissimi; e per ragioni tecniche l’imposta deve colpire i consumi meno variabili tra essi, cosicché la tassazione facilmente prende l’aspetto di capitazione. Si può tassare, invero, una o due o tre camere, a norma del loro valor locativo; si può far variare l’imposta sul sale da 40 a 60 ad 80 centesimi per chilogrammo a seconda che i consumatori, arricchendo, preferiscono qualità più fini; ma l’imposta sulle farine e sul pane rimane fissa in 10 centesimi per chilogramma (in Italia questa è l’aliquota dell’imposta all’incirca pagata allo stato, ai proprietari fondiari ed ai mugnai a titolo di dazio doganale sul frumento e sulle farine) qualunque sia la ricchezza del contribuente. I consumi primari differiscono di così poco qualitativamente gli uni dagli altri da rendere disagevole operare compensazioni tra diverse merci; laddove tanto ampia e tanto varia è la cerchia dei consumi secondari, che è per noi abbastanza agevole cogliere un mazzo di consumi i quali in complesso entrino in tutti i bilanci e costituiscano una proporzione costante dei consumi secondari stessi; ed a questa condizione si restringono in ultimo le esigenze del postulato della uguaglianza tributaria. Vi sarà chi non fuma, ma avrà il vizio del bere; e se non avrà nessuna delle due passioni, avrà quella del giuoco; e se anche da questa sia immune, è difficile voglia rinunciare anche all’uso della casa ampia, di una domesticità numerosa, di bevande eccitanti del sistema nervoso, come il caffè o il tè; sicché graduando con accortezza le une e le altre imposte non è assurda la speranza di riuscire a tassare proporzionatamente il reddito consumato. Sarebbe assurdo sperare di poter con ciò ugualmente colpire il reddito guadagnato; ma si sa oramai abbastanza che il fine medesimo di tassare il reddito «guadagnato» deve considerarsi «iniquo».
b) la seconda conseguenza dell’esenzione dei consumi primari e perciò della tassazione del vero reddito consumato è questa: che viene in gran parte meno la vigoria dell’accusa la quale si muove all’imposte sui consumi di essere inavvertite dai popoli e perciò illusorie e perciò corruttrici perché danno ai governanti propensi al malfare i mezzi per tradurre in atto le loro prave intenzioni senza che i contribuenti si accorgano dell’estorsione cui vano soggetti e siano perciò spinti subitamente a reagire.
La quale accusa è verissima quanto alle imposte falsamente dette sui consumi, mentre riguardando i consumi primari, dovrebbero essere dette imposte sui consumi risparmio. I consumi primari hanno invero quasi sempre la caratteristica della rigidità; entro certi limiti di variazioni di prezzo, la domanda essendo costante o magari crescente. Se aumenta da 40 a 60 centesimi il prezzo del pane, il consumo del pane non scema, ma anzi aumenta, perché diminuirà il consumo della carne, ossia il consumo di quelle merci in cui si investivano le rendite di consumatore lasciate disponibili dal basso prezzo del pane. Ora che non esistono più quelle rendite o sono scemate, si può comprare minor copia di carne o di vino; e per colmare i vuoti lasciati nell’organismo importa consumare maggiormente pane. Così è difficile scemi il consumo di sale, o della casa già ridotta all’indispensabile secondo il vario tenor di vita, o dei vestiti, se il prezzo non ne aumenti disordinatamente. Perciò accade che i governi possono sbizzarrirsi a lor posta nel crescere le imposte sui consumi primari senza che della eccessiva tassazione trapeli neppure un pallido indizio nelle statistiche dei consumi; potendo anzi sembrare che i popoli siano lieti delle gravi imposte, e la lor letizia manifestino col consumare maggiormente la merce tassata. Il legislatore può dunque ciecamente procedere sulla pericolosa via della sopratassazione, incoraggiato dal continuo aumento nel reddito dei balzelli da esso escogitati; e potrà procedere sino a quando l’ira repressa del popolo non trabocchi in incendi di casotti daziari, tumulti, disordini sanguinosi, rivolte e forsanco rivoluzioni. Questo è il danno delle imposte sui consumi primari o consumi risparmio, falsamente dette sui consumi; venendo esse a recidere le sorgenti stesse della vita al popolo e alle nuove generazioni, rendono i contribuenti inetti alle maniere ordinarie di reagire contro la ferocia fiscale e capaci soltanto di estreme e dolorose rivolte, le quali segnano la rovina dei malcauti e inconsapevoli governi.
Tutta diversa è invece la maniera di comportarsi delle imposte sui consumi secondari, ossia delle vere imposte sul reddito consumato. Appunto perché soddisfano a bisogni che vengono dopo nell’ordine volontariamente prescelto dagli uomini, accade che il loro consumo si contrae e si espande con notevole sensibilità in funzione dei prezzi. E poiché l’imposta fa aumentare necessariamente i prezzi, quindi l’imposta preme sul consumo e lo fa diminuire. Può accadere che, se l’imposta è lieve, la diminuzione del consumo sia inavvertita o sia elisa da un contemporaneo suo aumento, il quale ha luogo in ragione del mutarsi di altre circostanze, come l’incremento ancor maggiore del prezzo di altre merci che, per trattarsi di beni congiunti, ha rigettato la richiesta dei consumatori sul bene tassato; o come un aumento della ricchezza generale che renda i consumatori atti a comprare quantità crescenti di merci anche a prezzi crescenti. Ma se l’imposta è molto forte, vanamente spera il legislatore che il consumo non diminuisca. La ripugnanza dei consumatori a comprare la stessa quantità di merci tassate lo fa avvertito che nella tassazione si è oltrepassato il punto pericoloso. Chiamasi pericoloso quel punto, variabile da consumo a consumo, al di là del quale l’aumento dell’imposta non solo non produce più incrementi di gettito proporzionati al consumo precedente ed all’ammontare dell’imposta nuovamente aggiunta, anzi non dà luogo affatto ad incremento veruno o questo è troppo irrilevante. Suppongasi che il consumo prima dell’imposta fosse di 1.000.000 di unità al prezzo di 10. Se l’imposta di 1 accresce il prezzo ad 11 (mettasi il se essendo ben noto che gli effetti sono un po’ più complicati; ma da questa maggior complicazione si può astrarre) ed il consumo resta di 1.000.000 di unità, vuol dire che l’imposta, per la sua picciolezza, non ha reagito sul consumo. Crescendo l’imposta a 2 e il prezzo a 12, il consumo diminuisce a 900.000 unità; onde il gettito per lo stato che era, ad 1 d’imposta, di 1.000.000 diventa di 1.800.000. L’aumento di 800.000 è ancora sufficientemente rilevante per spiegare l’inasprimento del tributo. Postisi questo a 3 e il prezzo a 13, con un consumo scemato ad 800.000 unità. L’imposta frutta ora 2.400.000, con un aumento ancora di 600.000 in confronto del saggio precedente. Ma procedendo l’imposta a 4 e il prezzo a 14 ed il consumo diminuendo a 700.000 unità, il gettito risulta di 2.800.000 con un aumento di soltanto 400.000; troppo scarso risultato in confronto al danno dei consumatori che consumano 100.000 unità di meno, da cui ritraevano un’utilità unitaria come 13 (tant’è vero che a quel prezzo le consumavano) ossia di 1.300.000 in complesso. Il legislatore si accorge automaticamente che l’imposta si è avvicinata al punto pericoloso; e la consapevolezza di ciò lo trattiene dal compiere un passo innanzi portando l’imposta a 5 e il prezzo a 15, perché prevede che, ciò facendo, il consumo diminuirebbe a 600.000 unità ed il provento sarebbe di 3.000.000, ossia di appena 200.000 superiore al gettito precedente; finché aumentando ancora l’imposta a 6 e il prezzo a 16 e il consumo decrescendo a 500.000 unità, il gettito rimarrebbe costante a 3.000.000 con grande suo scorno; ed ostinandosi esso a crescere il balzello, il gettito persino diminuirebbe. La qual vicenda in Italia si verificò ripetutamente: dapprima per gli spiriti ed in seguito pel caffè e pel petrolio; talché il legislatore, fatto avvertito della reazione dei contribuenti dal malo risultato finanziario delle sue estorsioni, dovette rifare a ritroso in parte il cammino percorso con troppa precipitazione. E subito si vide come egli si fosse bene apposto, onde i contribuenti lieti consumano viemmeglio ed il fisco riceve plauso sincero e pecunia abbondante.
A torto dunque si afferma che col sistema delle imposte sui consumi, i contribuenti non esercitano controllo veruno sull’opera dei governanti; ché anzi il loro controllo è squisitissimo, imperocché, appena ritengono di pagare per le merci tassate un prezzo troppo elevato, si ritraggono dal consumo, mettendo sull’avviso i governanti che essi stanno per oltrepassasse od hanno già oltrepassato il punto pericoloso. Di tutte le maniere di reazione del contribuente contro l’oppressione fiscale, questa è la più sollecita; e, per i suoi effetti morali e politici, preferibile al contrabbando, che è la maniera più vicina, nelle imposte sui consumi, alla frode fiscale, all’emigrazione degli uomini e dei capitali, alle rivolte e alle rivoluzioni. Maniera così squisita di reazione non esiste certamente nelle imposte sul reddito guadagnato, dove occorre cominciare dalla frode od occultamento della materia imponibile e solo quando tal via appaia troppo ardua o pericolosa, ci si decide alla emigrazione a campi tributari immuni o meno vessati nello stesso paese od alla emigrazione all’estero.
Vero è che i contribuenti reagiscono non contro imposta, ma contro il rincaro dei prezzi delle merci tassate; e perciò, se si raggiunge l’effetto di avvertimento sui governanti, non si ottiene, se non in parte, l’effetto di educazione del popolo intorno al rapporto di causalità tra le spese inutili ed eccessive nei governi e il rialzo dei prezzi da esso risentito. Già si deve notare come, nei tempi odierni di educazione tribunizia diffusa e di gazzette imperversanti, ben difficilmente riesca tal rapporto di causalità a rimanere occulto anche ai più ottusi tra i governati; onde questi doppiamente si inferociscono, per le spese inutili e per l’inganno loro teso di aver voluto mascherare l’imposta sotto sembianza di un aumento di prezzi; e doppiamente gioiscono potendo sottrarsi, come per i consumi secondari è possibile entro certi limiti, all’aumento dell’imposta con la diminuzione del consumo: pel risparmio di spesa e per lo scorno dei governanti.
Ma quand’anche si voglia accogliere l’obbiezione sovra ricordata contro le imposte sui consumi, di non essere cioè abbastanza educative, vuolsi notare che questo carattere esse hanno soltanto quando siano imposte su merci e derrate materiali di consumo immediato, le quali cioè rendono servigio all’uomo per una volta sola. Le imposte sul caffè, sul tè, sulle bevande alcooliche, sul tabacco sono sotto questo rispetto poco educative, perché l’imposta si compenetra nel prezzo; e non è possibile accada diversamente, data la necessità di sorprendere la merce al varco e tassarla in un momento in cui essa non è peranco giunta al consumatore, il quale può quindi rimanere, sebbene sia certissimo che spesso non rimane, all’oscuro intorno alla causa dell’aumento di prezzo che lo esagita. Vi sono tuttavia parecchie altre imposte sui consumi, in cui questo effetto illusorio non si riscontra; e sono quelle sul consumo di beni durevoli, di beni cioè i quali rendono ripetuti servigi all’uomo per un periodo di tempo lungo. Ho già accennato alle imposte sul valor locativo della casa, sul valore del mobilio, sui domestici, sui cani, sui cavalli, sulle vetture, sulle automobili e si può aggiungere sulle livree, sugli stemmi, ecc. Sono le imposte che i nostri vecchi chiamavano suntuarie e che senza alcuna ragione furono abbandonate nei tempi moderni, sebbene in Inghilterra, nel Belgio e in Francia se ne osservino tuttora imponenti residui, i quali farebbero bene augurare da una più ampia loro applicazione. Per questi consumi è possibilissima ed è frequente l’imposizione diretta del consumatore, che è il vero contribuente; ed è perciò possibile che l’imposta esacerbi, inquieti, inferocisca il contribuente vero. Ciò che è massimamente desiderabile, essendochè l’unica maniera di ridurre alla ragione i governanti ambiziosi e stravaganti è il controllo assiduo e diretto dei governati, è la loro reazione continua e spietata contro le spese pubbliche inutili, è il timore dei rappresentanti di essere sostituiti da altri, per convinzione od interesse elettorale, meglio disposti a frenare le voglie della burocrazia famelica. I parlamenti non servono più spontaneamente all’uopo; creati per sorvegliare l’opera del principe, per scrutare a soldo a soldo la necessità delle spese pubbliche si sono trasformati nel principe medesimo, sicché si veggono tuttodì i rappresentanti d’ogni paese proporre spese nuove e si debbono escogitare complicati ordinamenti contabili per togliere ai parlamenti l’iniziativa delle spese, nella speranza vana di scemare queste, ristringendo il potere di proporle al governo; speranza vana finché il governo è l’emanazione delle maggioranze. Unica via di salvezza: l’esacerbazione dei contribuenti, i quali terrorizzino per modo i rappresentanti, da richiamarli all’osservanza dei loro doveri.
In fondo, una tra le principalissime spiegazioni delle imposte sul reddito guadagnato è la attitudine di alcune tra esse a risvegliare il senso di controllo da parte dei contribuenti. Non tutte hanno questa virtù; non l’hanno, ad es., quelle che sono trasferite dal contribuente legale su altra persona o che paiono così trasferite (imposta sugli interessi dei capitali dati a mutuo e sui fabbricati), quelle che si ammortizzano nel prezzo capitale (imposte sui terreni e sui titoli); quelle che sono pagate da contribuenti esattori salvo diritto di rivalsa (imposta sui redditi degli azionisti, obbligazionisti, impiegati, operai delle società anonime); quelle che sono esatte per ritenuta e che sembrano una partita di giro (imposte sugli impiegati degli enti pubblici e sui creditori dello stato). A ben guardare, in Inghilterra e in Italia, dove vige il sistema delle imposte cedolari o per categorie esatte all’origine su fittizi contribuenti esattori, le uniche imposte atte ad inquietare i contribuenti sono in parte le imposte sulle categorie da noi dette B e C e precisamente quelle che colpiscono commercianti, industriali e professionisti. Per estendere maggiormente lo spirito di controllo tra i contribuenti uopo è creare l’imposta sul reddito globale guadagnato, da noi chiamata imposta di famiglia. Ed è forse sovratutto per questo motivo che l’imposta sul reddito globale guadagnato, pur, come sappiamo, difettosissima teoricamente per l’indole sua intrinseca, può diventare di fatto raccomandabile.
Non è però per nulla necessario di scendere sino a coteste degenerazioni dell’istituto tributario per ottenere l’effetto desiderabilissimo del controllo dei governati sulle spese pubbliche deliberate dai governanti: soccorrendo mirabilmente all’uopo il gruppo «suntuario» delle imposte sul reddito consumato. Non è qui il luogo di esporre tutto un piano di applicazione di questi tributi, che ebbero difensori eloquenti in Italia nei tempi nei quali pensiero e linguaggio finanziario non erano turbati dall’odierno turpe lenocinio democratico; ricordiamo il nome di uno dei migliori economisti italiani dell’epoca cavouriana, il Giulio.[7] Per il Belgio, dove il sistema esiste da un secolo, ma è degenerato per incuria amministrativa e per inframmettenze politiche,[8] l’Ingenbleek, in uno dei libri di scienza tributaria meglio meritevoli di essere letti tra quelli comparsi nell’ultimo decennio,[9] delinea tutto un sistema compiuto d’imposte suntuarie sul reddito consumato.
Dopo aver dimostrato quanto siano fallaci le statistiche le quali affermano essere la spesa per la casa una proporzione rapidamente decrescente col crescere del reddito consumato, egli costruisce il sistema in questa maniera: I) una imposta sui valori locativi effettivi, risultanti dalle convenzioni tra le parti, controllate dal fisco, variabile dal 4% al 6% a seconda dell’importanza del comune, essendo l’aliquota minore per le grandi città, dove i fitti assorbono una proporzione elevata dei consumi totali e maggiore per i comuni rurali a fitti bassi. II) una imposta sul mobilio secondo il valore annualmente dichiarato dal contribuente e controllato dal fisco, anche per mezzo della comunicazione obbligatoria delle polizze di assicurazione contro gli incendi e in difetto per mezzo di perizia. L’imposta varierebbe dal 4.50 al 6.50 per mille a seconda della categoria dei comuni. Queste due prime basi dell’imposta dovrebbero secondo l’Ingenbleek dar luogo a detrazioni, attenuazioni e aumenti progressivi. Egli esenterebbe dalle due imposte i contribuenti con un fitto minore di 360 lire nei comuni di prima categoria, di 300 nei comuni di seconda, di 240 nei comuni di terza, di 204 nei comuni di quarta e di 156 lire nei comuni di quinta categoria; concederebbe ai genitori di figli conviventi di meno di 18 anni una detrazione della metà nel caso di fitti non superiori a 400-230 lire nelle prime quattro categorie e di un quarto per i fitti non superiori a 440-300 lire nelle prime tre categorie. Per i contribuenti di cui il fitto superasse le 1500, 1000, 700, 500 e 300 lire nelle cinque categorie, si dovrebbe stabilire un aumento del 2% del principale delle due prime basi d’imposta per ogni frazione in più di 250, 200, 150, 100 e 50 lire oltre i limiti sovraindicati per le cinque categorie. Un contribuente di prima categoria (Bruxelles e comuni assimilati) con un fitto di 3200 lire ed un mobilio di 12.000 lire, pagherebbe il 4% su 3200 ossia L. 128, il 4.50 per mille su 12.000 ossia L. 54, in tutto L. 182; più, siccome il suo fitto eccede di 1700 lire il limite delle 1500 ossia di 7 frazioni di 250, dovrebbe pagare 7 volte il 2%, ossia il 14% in più delle 182 lire e cioè L. 25,48 che aggiunte alle 182 porterebbero l’imposta a L. 207.48 in totale per le prime due basi. III) una imposta sulle automobili e sulle vetture esatta per mezzo di dichiarazione ed apposizione di placca, in ragione dei cavalli vapore, del numero e del valore. L’imposta dovrebbe essere dell’1,5% del valore. Per le prime tre basi di imposta, l’Ingenbleek vorrebbe tener conto altresì dei carichi di famiglia, diminuendo l’imposta dovuta, per i contribuenti con fitto non superiore a 1500, 1000, 700, 500 e 300 rispettivamente nelle cinque categorie, del 5% per i contribuenti aventi 1 figlio, non coniugato, di meno di 18 anni, del 7,5 se i figli sono 2, del 10% se i figli sono 3, e così via aumentando la detrazione del 2,5 per ogni figlio in più. L’imposta a sua volta dovrebbe essere, per i contribuenti il cui fitto eccedesse i limiti ora indicati, aumentata del 10% per i contribuenti che non hanno più di 2 figli, non coniugati, di età inferiore ai 23 anni, del 20% se i figli non sono più di uno e del 30% per i contribuenti senza figli. IV) una imposta sui domestici, per cui potrebbe essere accolto il sistema già vigente nel Belgio[10] il quale fa pagare 10 lire per una donna di servizio, 20 lire ciascuna, ossia 40 lire, se le donne sono due, e 25 lire ciascuna se le donne sono tre o più di tre; aumentando l’imposta a 25 lire in ogni caso, qualunque sia il numero delle donne, se si ha altresì un servitore maschio. Per i servitori maschi, se se ne tiene uno, si pagano 25 lire; 30 lire ciascuno se se ne tengono da 2 a 4; e 40 ciascuno se se ne tengono più di quattro; con un supplemento di 10 lire per il porto di livrea. V) una imposta sui cavalli di 50 lire per un cavallo di lusso, di 60 lire ciascuno, se i cavalli sono 2, di 70, se sono da 3 a 5 e di 80 se se ne tengono più di 5.
Questo nelle grandi linee il sistema quale l’Ingenbleek desidererebbe di vedere perfezionato nel Belgio. Qui fu addotto a guisa di esempio, perché si vegga la possibilità di costruire un sistema di imposte suntuarie, di facile accertamento, comode ad essere esatte, atte ad eccitare l’indignazione del contribuente direttamente colpito. E perché si vegga inoltre la possibilità di poter compensare, con acconce combinazioni di aliquote, variabili in funzione della località abitata, del numero dei figli, della importanza del fitto pagato, quel che di disuguale rimanga nel gruppo delle imposte sui beni di consumo immediato. Così combinandole insieme, il risultato si può dire perfetto: perfetto dal punto di vista della uguaglianza tributaria, come sopra definita, e perfetto dal punto di vista politico; le imposte sui beni di consumo immediato avvertendo, mercé la reazione pronta dell’aumento dei prezzi sul consumo, i legislatori di ogni eccesso loro e le imposte suntuarie sui beni durevoli spingendo i contribuenti a sostituire ai vecchi legislatori incauti o dimentichi del loro dovere nuovi legislatori meglio provvidi nella scelta e nella misura delle spese pubbliche.
VIII
La tecnica moderna ed i due tipi di imposta.
Ragioni d’essere delle imposte sul reddito guadagnato
Le condizioni nuove della tecnica industriale e commerciale e le facili migrazioni temporanee degli uomini da città a città, dal contado alla città e da stato a stato agevolano tecnicamente la formazione di un sistema di imposte sul reddito consumato in confronto del sistema di imposte sul reddito guadagnato.
a) La tecnica industriale favorisce, se non in tutti, in molti tipi di imprese la grande industria sulla piccola e media. Epperciò cessano quelle ragioni di animosità e di odio contro le imposte sui consumi, che erano vivissime nei tempi andati, perché il fisco doveva trovarsi a contatto con una moltitudine di piccoli produttori e quelli doveva controllare e vessare. L’unica grande imposta di fabbricazione nota in passato fu per lungo tempo quella di macinazione sui cereali, ed era odiosissima ai popoli perché i mugnai erano numerosissimi e disseminati in ogni piccolo borgo rurale, perché gli squadroni volanti di gabellieri dovevano sorvegliare l’opera di costoro, per lo più poco colti e per indole loro frodatori, perché l’esazione dell’imposta esigeva l’uso di bolle d’accompagnamento anche per piccole partite di farine condotte dai contadini al mulino. La ferocia necessaria dei rozzi arnesi del fisco cresceva l’ira e la resistenza nei contribuenti e si spiegano perciò i tumulti continui contro l’aborrita macina. Oggi anche questo balzello potrebbe esigersi con assai minore fastidio dei contribuenti; perché i piccoli mulini vanno a poco a poco diminuendo di numero, perché in pochi grandi mulini si macina copia grandissima di cereali, perché l’invenzione del contatore meccanico consentirebbe l’esazione del balzello con un insignificante numero di gabellieri, che potrebbero essere meglio scelti. A ragione l’imposta sulla macinazione fu abolita, perché tassava un consumo risparmio;[11] ma altre accise durano o sono nuovamente poste, favorite dalla tecnica moderna: come le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sullo zucchero, sui fiammiferi, sul gas e sulla luce elettrica, sulle materie esplodenti, sulle carte da giuoco. Di esse si può dire tecnicamente questo di bene: che basta una diligente sorveglianza su alcune centinaia di fabbriche (in Italia se ne può leggere l’elenco nominativo ogni anno nelle statistiche della direzione generale delle gabelle) per esigere centinaia di milioni. Senza sopprimere, quando trattisi di consumi secondari, la reazione del contribuente, virtù essenzialissima, la quale fu sopra discorsa, si sopprimono i rapporti sgradevoli ed inutili tra il fisco e moltissimi piccoli industriali e commercianti, che non erano, del resto, nemmeno nei tempi andati i veri contribuenti.
Le accise od imposte di fabbricazione hanno tuttavia un vizio: sorte e cresciute per virtù del sopravvento della grande impresa sulla piccola, provocano nuove vittorie della prima sulla seconda. Il quale nuovo trionfo artificioso della grande impresa deriva da ciò: che il pagamento anticipato della imposta esige una più alta messa di fondi da parte dell’imprenditore, alla quale i piccoli sono impreparati ed incapaci. Quando per fabbricar cicoria o fiammiferi o birra occorreva solo il capitale necessario alla compra della materia prima e al pagamento dei salari, poteva bastare un piccolo capitale, tanto più che i fornitori delle materie prime spesso attendevano per assai mesi il pagamento delle loro forniture. Ma lo stato non aspetta, volendo essere pagato appena la merce esce dai magazzini dell’industriale; e poiché l’imposta è per lo più superiore al costo della merce, si comprende come sia cresciuto a dismisura il capitale necessario all’esercizio dell’industria i cui prodotti sono colpiti da imposta di fabbricazione e come a poco a poco per progressiva eliminazione i più deboli tra i concorrenti siano perciò scomparsi. Il processo di concentrazione prosegue per un’altra ragione singolare, ed è la pubblicità data in ogni stato retto a forma parlamentare alle statistiche della produzione degli industriali tassati. Ogni anno, anzi ogni semestre, l’amministrazione finanziaria italiana pubblica la statistica delle imposte di fabbricazione; con l’elenco nominativo di tutti i produttori, la località dove lo stabilimento è posto, il carico di magazzino a principio d’anno, la quantità fabbricata, la quantità uscita, i cali di lavorazione, il carico di magazzino a fine d’anno, insieme con l’imposta pagata. Questa pubblicazione è indispensabile per evitare sospetti di frodi e di favoritismi e per assicurare il parlamento e il popolo intorno al corretto maneggio del pubblico danaro. Ma indispensabile come essa è partorisce l’effetto di rendere facili le costituzioni dei consorzi (sindacati, trusts, cartelli) tra produttori. Invero una delle cagioni più potenti di instabilità e di rovina dei consorzi medesimi è la sfiducia reciproca, la possibilità di inganni vicendevoli sulla quantità venduta, sui prezzi osservati, sulle zone di vendita. Se gli industriali consorziati si accordarono a non vendere più di una quantità fissata nel contratto per ciascheduno, ognuno teme che il concorrente di sottomano venda più dell’assegnatogli; se l’accordo fu sul prezzo minimo da osservarsi nelle vendite, ognuno teme che cotal prezzo si osservi in apparenza, mentre in sostanza si concedono abbuoni, sconti ed altre facilitazioni. L’imposta toglie tutte queste cause di discordia nel corpo dei consorziati; perché ognuno di essi può leggere nelle statistiche governative ad ogni fine di semestre od anno la quantità prodotta e venduta dai concorrenti. Il consorzio diventa dunque saldissimo, perché ogni violazione dei patti si riflette nelle cifre delle statistiche governative e fa temere la opportuna sanzione di multa.
Perciò l’imposta di fabbricazione ribadisce il giogo che i consorzi di produttori tentano di far pesare sui consumatori; e su di questi grava per causa di essa un onere maggiore del tributo percepito dallo stato, violando il già mentovato quarto canone di Adamo Smith. Ma il danno forse è controbilanciato dalle mutazioni che il tecnicismo moderno ha apportato nell’imposta di fabbricazione: – riducendo il numero delle merci di possibile tassazione, perché non tutte le merci sono prodotte dalla grande industria e solo queste ultime sono agevolmente tassabili; onde i contribuenti sono meno vessati da balzelli sui consumi primari, che per lo più sono consumi di merci producibili anche dalla piccola industria; – riducendo il numero delle merci tassabili con dazi doganali fiscali, essendochè nessun dazio fiscale può essere esatto, se non è controbilanciato da un’eguale imposta di fabbricazione; onde l’uno condiziona l’altro e viceversa ed, abolito il macinato, non è possibile un dazio fiscale sul frumento e sulle farine, ma solo un dazio protettivo; – riducendo sovratutto i costi di esazione delle imposte in maniera così imponente che i contribuenti risparmiano ben più di quanto essi medesimi in qualità di consumatori possono essere costretti a pagare di maggior prezzo per l’estorsione degli industriali consorziati. Talché, tutto bilanciato, l’imposta di fabbricazione palesa ancora indole di corretto ed elegante strumento fiscale.
b) Anche le contemporanee mutazioni nei mezzi di trasporto hanno resa più agevole e meno costosa e meno irritante l’esazione delle imposte sui consumi. Quando i trasporti avvenivano per carri, per barconi fluviali o per velieri, i quali potevano approdare in ogni porto, l’esazione delle dogane era difficile e fastidiosa, perché ogni strada di campagna, ogni porto anche miserrimo, poteva servire ad introdurre merci dall’estero. Oggi le grandi vie del commercio internazionale terrestre sono poche e si chiamano in Italia: Ventimiglia, Moncenisio, Sempione, Gottardo, Brennero e Tarvisio; e attraverso ad esse deve passare la gran massa delle merci transitanti, per evidenti ragioni di economicità. I porti, i cui fondali sieno abbastanza profondi da permettere l’approdo dei piroscafi da carico non sono molti e diventano sempre meno numerosi per la tendenza, che si potrebbe chiamare mania, delle grandi navi. Se le merci tassate non sono troppe (e non possono mai diventare molte in un sistema fiscale puro quale si delinea e si suppone esistente), e se, dovendo dare forti rendimenti, sono consumate in grandi masse, è assurdo supporre che il trasporto possa avvenire altrimenti che per strada ferrata o sbarcando sulle banchine di Savona, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Bari o Venezia e simiglianti porti. Tanto più facilmente questo accadrà se il fisco non dà un troppo grande premio ai contrabbandieri con l’altezza esorbitante dell’imposta. Date queste condizioni nuove dei traffici moderni, le dogane possono fruttare centinaia di milioni con una spesa minima di esazione, con assai ridotte masnade di guardie doganali, con pochissimo fastidio dei contribuenti. Se l’ideale in pratica è raggiunto solo nei paesi liberisti (Inghilterra e Belgio), il fatto medesimo dimostra come un sistema fiscale puro abbia virtù di raggiungerlo e come le vessazioni e gli attriti e le spese siano dovuti al malo innesto protezionistico sul vigoroso tronco dei tributi sui consumi.
c) Le abitudini degli uomini sono divenute nei tempi più recenti assai più vagabonde di quanto non fossero un giorno, quando eran usi a rimanere nel villaggio nativo e solo i muratori, gli sterratori, i pastori e alcune poche altre categorie di operai e di contadini facevano il giro del paese mentr’erano «compagni», o si recavano all’estero in cerca di lavoro. Oggi sono continue e frequentissime le migrazioni di genti dalla campagna alla città per affari, negozi, esercizio di industrie o di professioni, vendita di prodotti, salvo a tornare la sera in campagna; accade con frequenza vie maggiore che molti uomini eleggano domicilio in ferrovia, peregrinando perpetuamente da città a città in cerca di lucro; e sono imponenti le migrazioni temporanee di masse lavoratrici dall’interno all’estero nella stagione invernale o da regione a regione quando fervono i lavori agricoli. La mobilità grandissima degli uomini rende pressoché impossibile assidere ed esigere le imposte sul reddito guadagnato; perché queste suppongono accertamenti nel luogo di domicilio o residenza, avvisi personali, formazione di ruoli, atti esecutivi, tutte cose assurde o costosissime quando cresce il vagabondaggio delle genti umane. Come si tasserebbero in Italia i forestieri di passaggio per visitare le nostre bellezze naturali ed artistiche, se non esistessero le imposte sui consumi? Come i viaggiatori di commercio, stranieri ed italiani? Come gli immigranti giornalieri del contado potrebbero essere colpiti dalle città, che pure hanno d’uopo d’entrate ed incorrono in spese per provvedere alle esigenze del cresciuto traffico? Come gli operai, che hanno diritto all’esenzione, in quanto facciano consumi risparmio, o risparmio capitalistico, non mai in quanto abbiano nome di «operai»? Soltanto le imposte sui consumi danno il mezzo di raggiungere costoro; come soltanto le imposte suntuarie consentono di tassare coloro che, dovendo vivere e volendo vivere con agiatezza o lusso, hanno d’uopo di consumare casa, servizi di servitori, di cavalli, di carrozze, di automobili e sfuggirebbero alle imposte sul reddito guadagnato, perché essi sono di passaggio temporaneamente nello stato, o vivono in campagna per lo più gran parte dell’anno, quando la città esige l’imposta di famiglia.
Mentre così mutavano le condizioni tecniche e sociali in guisa da favorire l’applicazione delle imposte sul reddito consumato, peggioravano le condizioni che rendono facile l’esazione delle imposte sul reddito guadagnato. Queste invero esigono l’accertamento diretto dei redditi del contribuente, l’inventario della consistenza patrimoniale a periodi determinati, per saggiarne l’aumento o la diminuzione, astrazione fatta dai frutti netti annuali. Senza questi accertamenti precisi l’imposta sul reddito guadagnato è un’ingiuria alla verità, un sollazzo per orecchie democratiche, uno strumento di captazione di voti elettorali, una multa distribuita a casaccio contro quelli che non furono astuti o veloci abbastanza da sfuggire ai colpi del fisco; è tutto fuorché vera imposta. Ma quanto ardui ed ognora più ardui col progredire dei tempi moderni quegli accertamenti precisi! Poteva essere agevole la ripartizione dell’imposta sui redditi quando i redditi erano omogenei, derivanti da una o poche fonti, quando gli affari di ognuno erano risaputi da tutti nelle piccole cittadine. Oggi non più. L’uomo ricava redditi da una moltitudine di fonti diverse; e sono redditi che richiedono una finissima analisi qualitativa e quantitativa per essere determinati. I catasti odierni sono capolavori di complessità in confronto ai catasti semplici di duecento anni fa; né della complessità è possibile fare a meno, per la crescente diversità di culture, per il carattere scientifico dell’agricoltura moderna, che suppone anticipazioni a lunga scadenza, ritorni frazionati e conteggi ardui sulle quote di rischio, assicurazione, manutenzione, rinnovazione. Ben più ardua è la bisogna nell’accertamento dei redditi mobiliari; per cui ogni industria ha metodi suoi proprii e deduzioni particolari di spesa. Fu detto che gli agenti del fisco debbono essere magistrati e tecnici insieme; dotti nel diritto privato e fiscale ed insieme maestri del tecnicismo industriale ed esperti nelle valutazioni delle vicende commerciali e delle risultanze contabili. Il quale tipo ideale – eppur necessario – di agenti di accertamento ognun vede quanto sia rarissimo. Onde gli accertamenti nulla più sono di vaghissime approssimazioni, di wild guesses, che fanno disperare ognuno il quale serenamente vi rifletta della possibilità di attuare il postulato dell’uguaglianza nella ripartizione dei tributi sul reddito guadagnato.
Aggiungasi che le agevolezze di rapporti economici tra stato e stato, tra contado e città, tra città e città, rendono arduo ad ogni stato o comune di conoscere quali siano i redditi che cittadini o comunisti ritraggono da fonti straniere. Quei fatti che agevolano l’imposta sui consumi e le imposte suntuarie difficultano le imposte sul reddito guadagnato; ed è vano inveire contro le frodi dei ricchi, quando si vuole un metodo d’imposta che facilita le frodi e non si vuole quel metodo che efficacemente le combatte. Ed è inutile esacerbare gli accorgimenti inquisitivi per scovrire la ricchezza del contribuente, perché questi ognora recalcitrerà contro la pretesa del fisco di conoscere minutamente le sue faccende private, di scrutare nei libri contabili i suoi vizi e le virtù, di verificare l’impiego e le vicende del suo patrimonio. Sempre si troveranno maniere di eludere gli accorgimenti del fisco con avvedimenti ancor più accorti e di rendere sperequata e disuguale una ripartizione che è, sebbene non lo sia, nemmeno teoricamente, reputata equa nei libri e nelle parole della legge. Il contribuente non si rifiuta a manifestare l’essere suo, la sua ricchezza purché ciò avvenga nei modi da lui preferiti; ossia con la spesa. La qual verità è siffattamente nota all’universale ed agli agenti del fisco, che le imposte cosiddette sul reddito guadagnato sono in realtà imposte sulla spesa. Quando non soccorrano dati precisi, che si hanno solo per talune categorie di contribuenti, o valutazioni imperfette possedute per talune altre categorie, giuocoforza è per gli agenti fiscali attenersi alla «voce pubblica» la quale considera ricchi coloro che fanno grande sfoggio di servitori, livree, cavalli, automobili, divertimenti, ville, monti, bagnature, ecc. Così poco soddisfacenti, osserva lo Seligman (nel dotto e penetrante libro su The income tax, a study of the history, theory and practice of income taxation at home and abroad, by Edwin R. A. Seligman, New York, The Macmillan Co., 1911, pagg. 337 e 353), furono i risultati degli sforzi compiuti in Austria per accertare il reddito vero che «si dovette ricorrere in numerosissimi casi a quell’articolo della legge il quale autorizza i funzionari a stimare il reddito del contribuente secondo i suoi segni esteriori e principalmente secondo il fitto di casa da lui pagato. In pratica il reddito viene calcolato a circa cinque volte il valor locativo; cosicché, quella che doveva essere, nell’intenzione del legislatore, una corretta imposta sul reddito [guadagnato] in fatto diventò in notevole proporzione nulla più di una assai grossolana imposta sui valori locativi». E per l’Italia, osserva il medesimo autore come per gli industriali, commercianti e professionisti privati «l’amministrazione sia praticamente incapace a verificare gli accertamenti e si debba contentare di fare una stima assai grezza basata sovratutto sui valori locativi». Contuttociò un grande quotidiano belga, il Matin di Anversa, in un suo numero del settembre 1906 citato dall’Ingenbleek affermava: «Ognuno di noi è in grado di determinare il reddito dei suoi vicini ed amici, unicamente secondo il loro modo di vivere, tutti naturalmente adattando le proprie spese (son train de maison) alle proprie entrate». Idea grossolana, la quale dà luogo ad errori numerosi, tanto sono vaghe le nozioni correnti nell’opinione comune intorno al modo di vivere ed al reddito altrui; idea che pur tuttavia si accetta dai partigiani dell’imposta sul reddito guadagnato, pur di poter dire d’aver creata una imposta purchessia chiamata con quel nome e progressiva per giunta; mentre si respingono le maniere chiare, franche, disciplinate con accortezza di accertare precisamente quel reddito consumato, che tuttavia si colpisce, in cifra però erronea, mentre si dice di tassare il reddito guadagnato!
In ciò sta spesso la allegra vendetta che l’imposta sul reddito consumato trae delle invereconde lodi tributate a quella sul reddito guadagnato; quando, per le difficoltà tecniche crescenti di accertare sul serio il secondo reddito, la si trasforma insensibilmente, inavvertitamente in una imposta della prima specie; vergognosa tuttavia di se stessa, manipolata con criteri arbitrari e differenti da agente ad agente e tutta riposante sull’infido fondamento della voce pubblica.
Quando la «voce pubblica» dimostra per segni troppo chiari la sua inettitudine ingenita a consentire lo scoprimento della verità intorno al reddito guadagnato, si ricorre alla «inquisizione fiscale» affermando di imitare, ciò facendo, le regole già invalse nell’imposta sui consumi, per cui l’inquisizione sarebbe pacificamente ammessa da secoli. Per dimostrare la falsità della quale tesi, mi piace citare una pagina incalzante dell’Ingenbleek (vol. cit., pag. 361 e seg.), avvertendo che egli chiama, conformemente all’uso volgare, imposte sul reddito quelle che qui sono dette imposte sul reddito guadagnato, ed accise e imposte indiziarie alcune delle imposte che furono nella presente memoria dette sul reddito consumato:
«L’inquisione fiscale non merita veramente questo nome se non tocca la persona medesima del contribuente. Gambetta, preconizzando l’imposta sul reddito in Francia, sosteneva una volta la seguente opinione: “Si dice: come! Volete voi stabilire un’imposta sul reddito? Sarebbe l’inquisizione, sarebbe un’imposta impossibile ad accertarsi!Io rispondo: conosco nel nostro bel paese di Francia molte imposte che cagionano assai più vessazioni ai contribuenti: l’imposta sulle bevande, sulla circolazione e l’esercizio presso il distillatore e il fabbricante”. Citando queste parole alla Camera, il 10 luglio 1894, il signor Jaures le considerò come un argomento decisivo contro i timori dei suoi avversari. In verità è abusare un po’ troppo d’un’etichetta voler vedere dell’inquisizione nel fatto che i funzionari esercitano un controllo nelle fabbriche sottomesse alle leggi d’accisa. Ed è inesattissimo assimilare questo controllo alle investigazioni dirette negli affari personali del contribuente. Gli impiegati delle accise controllano e sorvegliano dei fatti evidenti; operano in locali quasi pubblici; non vogliono sorprendere nessun interesse professionale e non si lasciano andare affatto ad investigazioni vessatorie riguardo alla vita intima del contribuente. Raramente essi sono in contatto con costui; la loro azione è quasi automatica, esercitandosi su oggetti materiali e che sono a loro portata immediata; un termometro ed un densimetro regolano sovente la base dell’accisa negli stabilimenti. Finalmente il fabbricante non paga in realtà l’imposta; ne fa l’anticipazione, essendo l’intermediario momentaneo tra il contribuente consumatore e il fisco. Tutte queste considerazioni provano – e la pratica d’altronde lo dimostra abbastanza – che il controllo in materia d’accisa è una formalità che non tocca il fabbricante interessato. Ben altra cosa sarebbe, per esempio, rivedere le scritture di contabilità di questo industriale per conoscere l’importanza dei suoi sbocchi; voler conoscere il suo costo di produzione e di vendita per tassare il suo beneficio. Il controllo sarebbe allora personale, farebbe pesare una dominazione reale sul contribuente… Neppure può essere assimilata ragionevolmente l’imposta sul reddito alle imposte indiziarie sui cavalli, sui cani, sulle automobili, benché anche queste esigano delle dichiarazioni o delle verificazioni. Per queste il controllo è facile, è obbiettivo; riguarda cose visibili che si rivelano nella vita pubblica, e non la capacità economica, che si confonde colla vita intima del contribuente… L’inquisizione fiscale esiste solo quando il contribuente medesimo è soggetto ad una sorveglianza personale. Se il funzionario deve penetrate in un gabinetto da lavoro per compulsare una contabilità o sorprendere le fluttuazioni della vita privata; se deve controllare senza tregua i fatti minuti del modo di vivere di ognuno; se deve scrutare i segreti delle famiglie per sorprendere l’indole dei redditi e delle spese; nel momento, in una parola, in cui si stabiliscono contatti persistenti tra il funzionario schiavo del dovere fiscale ed il contribuente che si sottrae per tradizione ed è, altresì per tradizione, geloso della propria libertà, vi ha inquisizione fiscale».
Quali dunque le ragioni che spiegano l’esistenza delle imposte sul reddito guadagnato erronee nel loro principio fondamentale ed ipocrite nella loro applicazione pratica? Si deve mettere da parte, almeno come spiegazione generale, quella di chi dicesse essere le imposte sul reddito guadagnato necessarie per compensare le disuguaglianze delle imposte sul reddito consumato. Questa potrà essere una ragione ottima quando si parta dal falso concetto che il «vero» reddito sia quello guadagnato o quando le imposte sul reddito consumato siano male congegnate e percuotano più i consumi risparmio che i consumi spesa. Date però le nostre premesse e data l’attuazione del sistema delineato sopra, questa ragion d’essere compensatrice in generale cade. Potrà tuttalpiù sussistere per talune particolarità del sistema, che qui sarebbe lungo discorrere e fuor di luogo.
Le vere ragioni che spiegano l’esistenza delle imposte sul reddito guadagnato sono tre: l’una politica illusoria, la seconda politico reattiva e l’altra tecnica.
a) La prima ragione è d’indole politica illusoria, poiché i governanti di ogni tempo e d’ogni paese hanno sempre usato tra le loro armi di governo questa: di moltiplicare i tipi ed i nomi delle imposte, per far credere ai popoli che con ognuna d’esse si percuotono nuovi contribuenti, prima esenti o non abbastanza colpiti. La qual credenza è falsa; poiché con le imposte comunemente dette sul reddito [guadagnato] nuovamente si colpiscono quei redditi che già avevano assolto il debito tributario con le imposte sul reddito consumato; anzi, una parte del reddito, quella consumata, paga di nuovo una volta il tributo, l’altra parte lo ripaga due volte. Né contenti della nuova tassazione, presto inventarono nomi nuovi, come di imposta di successione, sui trasferimenti della proprietà o sul capitale, con cui lo stesso reddito viene percosso una terza o quarta volta; ed ora si inventano nomi nuovissimi, come di imposte sugli incrementi di valore, con cui la ripetizione si rinnova e forse non per l’ultima volta.
Cosiffatto sollazzo della ripetizione è in parte forse innocente; perché trattasi di frazionare un tributo del 20% sul reddito [consumato], che ha aspra apparenza e sarebbe risentito dai popoli, in parecchi altri tributi, più benigni nell’aspetto, l’uno del 2, l’altro del 5, il terzo del 10 ed un quarto del 3% del reddito. La somma non muta e non può mutare, essendo immutato il fabbisogno dello stato; ma l’impressione nei contribuenti è meno viva. Arte vecchia di governo, perché sempre si seppe che a spennare la gallina senza farla stridere troppo conviene levarle ad una ad una dolcemente le penne.
Ma in parte è indubbiamente dannoso; poiché la reazione dei contribuenti, sembrando meno viva la percossa dell’imposta, è meno pronta ed efficace; sicché le spese pubbliche possono crescere ad altezze che altrimenti non sarebbero comportate; e perché la creazione di tanti nomi diversi per la stessa cosa illude i contribuenti e li persuade che realmente si tratti di imposte per una diversa materia imponibile. E si ricerca allora l’uguaglianza tributaria nella cerchia di ogni singola imposta; e si grida alla immunità «ingiusta» ogni qualvolta un contribuente non sia colpito dall’imposta che ha un nome, senza cercare se non lo sia dall’imposta che ha altro nome. Le quali baruffe intestine fra contribuenti sono graditissime ai governanti, a cui apprestano nuova occasione di balzelli.
La creazione di parecchie categorie d’imposta soddisfa a volta a volta altresì agli interessi dei gruppi politici dominanti, i quali nel nome nuovo trovano un mezzo di farsi credere osservanti esecutori delle promesse fatte quand’erano all’opposizione e di indulgere all’abito democratico d’oggi come ai pregiudizi aristocratici d’un tempo. Come alle oligarchie aristocratiche dominanti nel secolo XVII e XVIII erano piacevolissime le imposte sulla spesa quando colpivano i consumi primari o consumi risparmio, perché costringendo al lavoro le plebi oziose, contente di poco guadagno, ottenuto con scarso lavoro, accrescevano la quantità delle maestranze, così sono oggi graditissime alle democrazie moderne le imposte sui redditi guadagnati, sulle eredità, sugli incrementi, perché sono imposte che godono nomea di colpire i ricchi. Che diversa sia poi spessissimo la realtà poco monta, purché l’effetto ottico sulle plebi sia ottenuto. E si dimostrano più grandi schiamazzatori a pro dell’imposta sul reddito coloro che di fatto meno la pagano, pur essendo fondata la persuasione che a pagarla dovrebbero sentirsi astretti dal dovere.[12]
b) La seconda ragione, che in parte fu già detta sopra nel capo settimo, è l’attitudine di alcune tra le imposte sul reddito guadagnato a risvegliare il senso di controllo dei contribuenti e la loro reazione contro le spese inutili. Ma già si disse che cotale virtù è limitata ad alcune poche tra le imposte sul reddito, ossia a quelle soltanto che sono direttamente esatte dal contribuente legale. Or si aggiunga, in questo capo destinato allo studio della azione che sul congegno tributario esercitano le mutate condizioni della tecnica e della vita moderna, che, sebbene gli innocenti propugnatori delle imposte sul reddito guadagnato non se ne siano accorti, nessuna imposta tende ad essere meno «diretta» di quelle che essi si affaticano a lodare come imposte dirette sul reddito. Chi studi la maniera reale, e non quella immaginata dal cabalista di riforme tributarie, con cui sono esatte le imposte sul reddito guadagnato si avvedrà di leggieri che cresce la proporzione di esse la quale è esatta su chi paga e diminuisce la proporzione esatta su chi riscuote il reddito. Il legislatore e più l’amministratore della pubblica finanza si sono accorti cioè che il tentativo di accertare il reddito ed esigere l’imposta a carico di chi riscuote il reddito e teoricamente deve essere considerato come il vero contribuente era unicamente fecondo di frodi e d’insuccessi fiscali; perché il contribuente, quando abbia incassato il reddito, ha mille modi di sfuggire alle indagini fiscali; e tanto è complessa la struttura economica odierna, tanto fini ed occulti i congegni creditizi e le maniere di investire capitali in lontani paesi e varii gli accorgimenti per esigere i guadagni che ogni speranza di strappare direttamente al contribuente la confessione dei suoi redditi è onninamente vana. Legga, chi voglia, i libri dello Seligman su The Income Tax, quello dell’Ingenbleek già citato e l’altro del Lia su L’imposta mobiliare e la riforma sui tributi diretti in Italia (Torino, S.T.E.N., 1906); e si persuada come l’esperienza universale, italiana, svizzera, austriaca, inglese, americana insegni la inanità degli sforzi compiuti ad accertare il reddito presso il contribuente «vero» che lo riceve; inanità che appare minore in un paese solo dal mondo, ed è la Prussia, dove i popoli supinamente son contenti di proclamarsi vassalli di una burocrazia forte, inquisitrice, persuasa della propria sapienza ed onestà. Le quali attitudini di ubbidienza e di dominio essendosi verificate per una volta sola nella storia delle genti umane, è probabile abbiano a tramontare nel loro medesimo paese d’elezione; e sarebbe impolitico da parte dei governanti di altri paesi fare affidamento sul loro inaspettato radicarsi in popoli che tuttodì vi si dimostrano ribelli. Ben fanno perciò i legislatori, volendosi tenere stretti alla teoria della tassazione del reddito guadagnato, a cercare altra via per ovviare alle frodi. E la via prescelta è l’accertamento del reddito presso non chi riceve, ma chi paga il reddito, col metodo della «ritenuta» da parte dello stato dell’imposta sugli interessi del suo debito o sugli stipendi dovuti agli impiegati pubblici, o colla tassazione a carico delle provincie, dei comuni, degli enti morali, delle società per azioni, degli industriali per i redditi degl’impiegati, degli operai, dei creditori, degli azionisti, degli obbligazionisti, ecc., che dai primi ricevono il proprio reddito. Sorge così la figura moderna del «contribuente esattore per contro altrui»,[13] il quale non ha il reddito, anzi lo paga altrui; ed è tassato perché il fisco ha maggiori facilità di accertare il reddito e di esigere l’imposta a carico degli enti pubblici, degli enti morali, delle società per azioni, tutti corpi astretti a severa disciplina di pubblicità di bilanci e di responsabilità degli amministratori e quindi incapaci, del tutto o quasi, di frodare il fisco. In Inghilterra forse i tre quarti dell’imposta sul reddito sono esatti da pseudo contribuenti; in Francia i nuovissimi progetti di imposta sul reddito pongono gran cura ad evitare, per quanto sia possibile, di mettere a contatto il fisco coi «veri» contribuenti, preferendo di gran lunga tassare i contribuenti esattori. Negli Stati Uniti lo Seligman guarda con onore al pericolo che si abbia ad abbracciare il partito di tassare i veri contribuenti sul reddito complessivo da essi ricevuto, e, mosso dal vivo disio di vedere introdotta nel suo paese l’imposta sul reddito guadagnato e di salvarla da un insuccesso che le sarebbe fatale, si industria con fatica ed ingegno grandi a delineare un sistema (a practical programme) di cui il concetto essenziale è di evitare con somma cura, per quanto sia possibile, ogni tassazione del reddito complessivo all’arrivo presso il contribuente «vero» e di estendere l’applicazione del concetto di tassare i redditi all’origine (stoppage-at-source system) presso i pseudo contribuenti esattori; e reputa sommo suo trionfo l’aver potuto dimostrare che negli Stati Uniti, paese economicamente progreditissimo per il prevalere sempre maggiore delle imprese rette a forma di società per azioni, la massima parte dell’imposta da lui auspicata sul reddito potrà essere esatta a mezzo di questi pseudo contribuenti.
Che cosa significa il fatto, certissimo ed universale e di crescente importanza, dell’esazione delle imposte sul reddito a carico dei pseudo contribuenti esattori? Che le imposte sul reddito guadagnato vanno via via perdendo l’attitudine che esse avevano di risvegliare la reazione del contribuente, che è la virtù politica massima di una buona imposta. Vero è che lo pseudo contribuente ha diritto di esercitare la «rivalsa» dell’imposta da lui anticipata nel momento in che paga il reddito al «vero» contribuente. Ma di fatto la rivalsa non viene quasi mai esercitata, amando meglio il pseudo contribuente sommare le imposte anticipate colle altre spese di gestione e pagare stipendi, salari, interessi, dividendi in cifre rotonde, nette da imposta da lui anticipata nel momento in che paga il reddito ai veri contribuenti; di guisa che nasce ed a poco a poco si radica in costoro la «illusione» di non pagare imposte; anzi, con nuova peregrina illusione, essi gioiscono delle imposte le quali cadono sui pseudo contribuenti, per lo più persone immaginarie o giuridiche, persuadendosi di non essere per nulla tocchi dalla sventura che quelli opprime. Con questo avvedimento della tassazione all’origine, gli accorti governanti raggiungono ad un tempo due per loro utilissimi fini: il primo dei quali si è di esigere agevolmente l’imposta ed il secondo di annebbiare per modo il genuino fatto tributario da persuadere ai «veri» contribuenti di essere immuni e di farsene strumenti ed alleati nella persecuzione contro gli pseudo contribuenti. Ma per tal modo le imposte sul reddito guadagnato perdono ogni virtù reattiva; essendoché le persone immaginarie, che son fatte contro lor voglia contribuenti esattori, sono incapaci a reagire e le persone, di carne ed ossa, che sono i veri contribuenti, son persuase di nulla pagare. Il quale inganno è lagrimevolissimo, perché torna massimamente utile a quelli tra i governanti che sono proni al malfare.
c) La terza ed invero più seria ragione del costituirsi di un gruppo di imposte sul reddito guadagnato è tecnica. Ogni imposta ha, come fu spiegato sopra, un limite al quale l’aumento dell’aliquota cessa di dare un rendimento o lo dà troppo scarso. È la teoria della produttività decrescente applicata alle imposte ed è il nocciolo di verità che sta nella illusione sopra descritta. Un sistema ottimamente costrutto di imposte sul reddito consumato incontra limiti al di là dei quali non è conveniente spingerne il rendimento. Se si rialza troppo l’imposta sulle bevande alcooliche, l’uomo si avvelena con spiriti inferiori o ricorre al contrabbando divenuto lucroso. Se si aumenta eccessivamente il prezzo dei sigari e delle sigarette, si inventa qualche vizio che surroghi l’abitudine del fumare. Se dal 10 si spinge al 20, al 30 e poi al 40 o 50% l’imposta, ottima se bene regolata, sul valore locativo, si spingono gli uomini a stiparsi in poche camere. Se si tassano troppo fortemente servitori, cani, carrozze, cavalli, automobili, i ricchi andranno in aeroplano o spenderanno più forti somme negli sports invernali o butteranno denari in maggior copia nel seno di femmine galanti, materia imponibile di che è meglio il fisco non s’impacci.
Or può ben darsi che quando il sistema delle imposte sul reddito consumato è giunto al punto di sua produttività massima, il fabbisogno dello stato non sia ancora coperto. Occorrono due miliardi di lire, ed il sistema ne frutta appena uno. Ecco un fatto dal quale non si può fare astrazione. Ed ecco la ragione di essere fondamentale delle imposte sul reddito guadagnato. Il fisco dopo essersi messo in imboscata presso tutte le vie percorse dal reddito per investirsi in consumi, dopo avere tassato tutti i consumi tecnicamente tassabili, dopo averli tassati in guisa da soddisfare al postulato dell’uguaglianza si trova ad aver più fame che pria. Ed allora rifà il cammino a ritroso. Ritorna al reddito consumato e cerca di colpirlo nello stadio quand’è tuttora indistinto, espresso in numerario. Ma farlo non può, se non traverso alla forma di reddito guadagnato. Ricordiamo le considerazioni esposte nel capo terzo intorno alla impossibilità di accertare direttamente il reddito consumato. Tutte le cose discorse dappoi ebbero ad oggetto la descrizione delle maniere diverse di tassare indirettamente il medesimo reddito. Ma poiché queste diverse maniere non bastano, si rifà il tentativo, approssimandosi all’ideale per altra via. La maniera fu già esposta, criticata, messa a raffronto con l’approssimazione finora descritta e trovata inferiore (capi quarto e quinto). Benché inferiore, essendo necessaria, conviene rassegnarvisi. Abbiamo così il secondo gruppo di imposte: sul reddito guadagnato, le quali devono però essere costruite in maniera da tassare nell’indistinto reddito guadagnato quella parte che il legislatore presume consumata, esentando la parte che il legislatore presume risparmiata.
IX
Si dimostra come anche le imposte sul reddito guadagnato tendono ad esentare il risparmio
Il nostro assunto sarà perciò conchiuso quando si provi che anche nel sistema delle imposte sul reddito guadagnato, definito come sopra si disse (capo primo) e comprendere perciò, insieme alle imposte sui frutti, le imposte sulle eredità, donazioni, giuochi, incrementi di valore delle imprese, dei titoli, dei terreni, ecc., il vero oggetto dell’imposta, l’oggetto «tendenziale», è il reddito consumato.
La qual dimostrazione è evidente che non può darsi in maniera diretta, perché i legislatori premuti dalla illusione delle molteplici materie imponibili e inconsapevolmente desiderosi di scoprirne sempre delle nuove a soddisfazione dell’erario e dei popoli affermano unanimi invece che l’imposta deve colpire il reddito guadagnato.
Ma i fatti sono più forti delle false teorie. Ed i fatti ci ammaestrano che, or con un pretesto, or con un altro, i legislatori tendono sempre più ad esentare il risparmio dall’imposta sul reddito guadagnato, rendendo così, mentre lo negano, stupendo omaggio alla tesi della tassazione del reddito consumato. Qui rapidamente, si elencano i principali fatti a sostegno dell’assunto di questa memoria.
Si avverta però, innanzi di procedere avanti, che la dimostrazione è volta soltanto a provare che le imposte vigenti sul reddito guadagnato – sotto il qual nome si comprendono, come fu chiarito nel capo primo, insieme alle cosidette imposte sul reddito, anche le imposte sul patrimonio, sulle successioni, sugli incrementi di valore, ecc. – debbono a viva forza riconoscere la verità del teorema dell’esenzione del risparmio, e sono costrette perciò a foggiarsi, sotto certi rispetti, in maniera che è contraddittoria al concetto della tassazione del reddito guadagnato. Ma, dando questa dimostrazione, non si è voluto affermare che le imposte sul reddito guadagnato manchino di una propria logica. Anzi l’hanno e imperiosa e siffattamente crudele da imporre sempre nuovi ampliamenti e ripetizioni della materia imponibile. È questa logica che dopo avere assoggettato all’imposta i guadagni ordinari certi vi assoggettò anche gli incerti ed eventuali; e poi a ragione non vide differenza alcuna tra i guadagni ricorrenti e quelli straordinari non ricorrenti e per questi creò le imposte sulle successioni, sulle donazioni, sulle vincite alle lotterie, le quali nonostante il loro «nome» peculiare sono tributi sul reddito guadagnato; e, non soddisfatta ancora, comprese nel reddito i prezzi d’avviamento delle imprese economiche ed ora crea le imposte sugli incrementi di valore. Nulla resiste all’impeto della logica intima che esagita l’imposta sul reddito guadagnato, costringendola a procacciare a se stessa sempre novella preda.
Qui si vuol dire che nella legislazione tributaria, accanto agli effetti di questa logica interna conquistatrice del principio della tassazione del reddito guadagnato si veggono altresì gli effetti benefici dell’azione limitatrice di un’altra logica, esterna a quella del principio accolto dal legislatore, anzi ad esso opposta e propria del principio della tassazione del reddito consumato. L’ordinamento tributario di fatto è una risultante di queste due forze logiche, l’una interna e propria del principio accolto dal legislatore e l’altra esterna e propria di un diverso principio che a parole il legislatore vigorosamente oppugna. Qui si riconosce che il principio «espressamente» voluto dal legislatore è quello della tassazione del reddito guadagnato;[14] e che a questo bisogna uniformarsi ogni qual volta si debba risolvere un dubbio di tassabilità e non soccorra un’immunità eccezionale e dichiarata dal legislatore; a questo principio, ad esempio, dovendosi da noi ricorrere qualora si discuta della tassabilità dei prezzi d’avviamento o dei sovraprezzi delle azioni di nuova emissione. Ma si afferma inoltre che il legislatore, inconsciamente e spinto dalla forza dei fatti, ben altrimenti potente della logica di un «falso» principio, ha già recato all’edificio della tassazione del reddito guadagnato numerose e profonde offese; che queste offese sono la conseguenza dell’imperiosa violenza con cui la verità del principio opposto della tassazione del reddito consumato si fa chiara alla mente riluttante del legislatore. Cosicché non è vana la speranza che finalmente il legislatore si persuada della verità del teorema milliano e, rifiutando il contrario principio oramai contennendo per le scelleraggini commesse e tutto diroccato dagli assalti vittoriosi del nemico suo, quest’ultimo accolga nella sua purezza adamantina. Ed ora si proceda alla narrazione degli assalti che il teorema dell’esenzione del risparmio o della tassazione del reddito consumato mosse contro la rocca forte della credenza falsa ed empia.
PROVA PRIMA: il risparmio presunto e la classificazione dei redditi.
La prima e fondamentale maniera di attuare la regola della esenzione del risparmio pur entro il sistema delle imposte sul reddito guadagnato si è di presumere per ogni contribuente una quota di risparmio e quella rendere immune dall’imposta. Già vedemmo che il sistema è difettoso, perché sostituisce alla constatazione dei fatti reali nei casi singoli che automaticamente si avvera colle imposte sul reddito consumato, la presunzione compiuta dal legislatore per classi di contribuenti, presunzione che potrà presentare scarti più o meno ampi dalla verità. Tuttavia il metodo può essere accolto, in difetto di meglio, come una grossolana approssimazione all’esenzione dell’effettivo risparmio ed è universalmente noto sotto il nome di diversificazione o discriminazione o classificazione dei redditi.
Ben è vero che il metodo per cui certuni redditi sono tassati di più ed altri meno viene dalla comune degli scrittori spiegato diversamente; ritenendosi che sieno meritevoli di trattamento più simpatico i redditi che derivarono dal lavoro, perché s’acquistarono con fatica di muscoli o di intelligenza, e di tassazione più severa quelli che s’ottennero senza fatica col semplice impiego dei capitali. Spiegazione fallace; perché si introduce nella finanza un concetto extravagante di valutazione morale dei redditi che non ha alcun fondamento. Nulla di più odioso di siffatte discussioni sull’origine del reddito: sarà «guadagnato» il reddito di un cantante famoso a cui il dotto naturale di un’ugola divina fa lucrare un milione di lire all’anno e sarà «gratuito, unearned» il reddito che l’operaio, la donna di servizio, il contadino ritrae a titolo di interessi sul libretto della cassa di risparmio o di rendita fondiaria dal brandello di terreno acquistato con le sudate economie? Sarà reddito di «lavoro» e quindi meritevole di benigno trattamento fiscale la pensione passata dal gran signore alla cortigiana famosa; e sarà reddito di «capitale» e perciò abominevole e soggetto ai colpi aggravati delle imposte il dividendo che l’avventuroso capitalista ritrae dalle azioni di una società esercente una industria rischiosa?
L’origine del reddito non conta nulla agli effetti tributari; sibbene conta assaissimo la sua destinazione; e si trattano benignamente i redditi di lavoro, non perché siano di «lavoro» sibbene perché essi in parte non sono «reddito». Badare all’origine del reddito vuol dire risuscitare a rovescio le vecchie distinzioni di classi, di cui le une sarebbero immuni, le altre taillables et corvéables à merci, con le funeste conseguenze che dalle immunità di classe derivarono sempre. Badare alla destinazione del «reddito guadagnato» significa semplicemente attuare, in maniera imperfetta e grossolana, ma attuare, il postulato dell’uguaglianza tributaria. Ciò fu ben visto dai primi legislatori che vollero applicare il principio dello Stuart Mill dell’esenzione del risparmio. L’Hubbard, relatore di un comitato inglese sulla riforma dell’imposta sul reddito (Report and evidence of the Committee of 1861 on the Income tax, page XIV), constatava che i dati disponibili allora intorno al risparmio delle diverse classi sociali facevano ritenere che i possessori di redditi immobiliari e mobiliari capitalistici risparmiassero il decimo circa dei loro redditi; mentre sui redditi professionali ed industriali la proporzione saliva ai quattro decimi. Quindi egli proponeva che si esentasse dall’imposta un decimo di tutti i redditi ed inoltre un altro terzo del reddito residuo per i redditi professionali od industriali, redditi provenienti cioè sovratutto dal lavoro. La proposta non fu accolta in Inghilterra se non tardissimo;[15] e se il penultimo cancelliere dello scacchiere, Mr Asquith, la volle adottata, dovette adornarla degli ornamenti del gergo democratico di moda e perciò atto a procacciare voti, dichiarando di volere, non esentare il risparmio, sia bene tassare con un’aliquota minore (9 d. per Ls.) i redditi «guadagnati» invece dell’aliquota normale di 1 scellino e 2 d. per lira sterlina applicata ai redditi «non guadagnati». Lo sconcio nome nulla toglie alla sostanza dell’istituto, che è di tassare meno coloro che hanno maggior bisogno di risparmiare per la vecchiaia, l’invalidità, le malattie, la famiglia.
Il legislatore però che primo mosse i più arditi passi sulla via dell’esenzione presuntiva del risparmio fu il nostro italiano, il quale costrusse coll’imposta sui redditi di ricchezza mobile una imposta, che nella sua struttura fondamentale era la migliore dei suoi tempi (legge 14 luglio 1864, n. 1830) ed è ancora bellissima oggi e sarebbe vieppiù ammiranda, ove noi non avessimo l’abitudine di lodare le cose altrui, lasciando via via degenerare le migliori istituzioni nostre. L’imposta di ricchezza mobile è nulla più di un rudere rovinato dell’edificio immaginato dai legislatori del periodo eroico della finanza italiana. Veggasi come sia stupendo l’edificio concepito: distinti i redditi mobiliari in tre categorie, di capitale puro, di lavoro puro e misti di capitale e lavoro. I redditi di capitale puro, detti di categoria A, si presume siano interamente consumati dai loro percettori e sono quindi interamente tassati, per gli otto ottavi del loro ammontare. La supposizione è, in tesi generale, accettabile, perché il reddito si forma senza uopo dell’intervento dell’opera dell’uomo. Il contribuente può morire, ammalarsi, diventar vecchio ed inabile al lavoro e ciononostante il reddito gli perviene nella stessa misura di prima, sicché egli non ha bisogno di premunirsi contro queste eventualità risparmiando. La supposizione non è in tutto corretta, potendo ben darsi che contribuenti capitalisti di fatto risparmino, pure non avendone bisogno; ma essendo questo l’inevitabile difetto di tutte le presunzioni generali, è inutile discorrerne. Ovvero si potrebbe osservare che qualche capitalista può «aver bisogno» di risparmiare, se i suoi redditi di capitale puro sono così esigui che lo lascerebbero alla mercé di quei danni che col risparmio si vogliono scongiurare; il possessore di un libretto di cassa di risparmio con 1000 lire versate, del reddito annuo di 30 lire, essendo meglio tutelato contro le malattie o l’invalidità di chi nulla possiede, ma essendo ben lungi dall’essere tutelato abbastanza; e non essendo in nulla sufficiente l’avere suo all’educazione ed istruzione dei figli in caso di sua morte prematura. Al che si provvederebbe concedendo l’esenzione dall’imposta in categoria A, fino alle 400 lire imponibili di reddito, così come si fa per le altre categorie o fino alle lire 10.000 di capitale. Esigenze alle quali si potrà soddisfare a mano a mano la pressione fiscale potrà farsi meno pesante e quando il legislatore moderno vorrà decidersi a perfezionare – invece di rappezzarlo guastandolo, come fece fin qui – lo strumento fabbricato dalla generazione passata.
I redditi di lavoro puro, ossia di categoria C, per loro indole rendono necessario per il contribuente medio, sufficientemente previdente, del tipo del buon pater familias, quale appunto il legislatore deve sempre presumere, una notevole capitalizzazione. Infatti l’operaio, il professionista, l’impiegato, vivendo del proprio lavoro, hanno un reddito che muore colla cessazione della vita fisica o produttiva del contribuente. Se essi ammalano o diventano inabili al lavoro, non possono più attendere alla clientela; e l’imprenditore, l’ente pubblico a cui prestano i loro uffici manuali od intellettuali, dopo alquanta attesa, si stanca di pagare stipendio o salario. Se invecchiano e non hanno un fondo risparmiato con cui sostentarsi, sono trascurati o maltrattati dai figli e devono cercare amaro ricovero in un ospizio. Se muoiono in età prematura, l’ultima loro ora sarà angosciata dal pensiero della moglie e dei figli miserabili, costretti a guadagnarsi subito un pane, senza perfezionare la loro educazione tecnica o professionale, discendendo forse ad uno strato sociale inferiore a quello a cui il padre s’era innalzato. Perciò il legislatore italiano del 1864 aveva supposto che i redditi di lavoro puro fossero consumabili solo per i cinque ottavi, onde esentò dall’imposta i rimanenti tre ottavi, da lui supposti destinati al risparmio. Anche questa è una supposizione spesso irreale, essendo molti contribuenti scapoli e bisognosi quindi soltanto di risparmio individuale e non di quello di specie ed essendo numerosi i lavoratori incapaci di pensare all’indomani per difetto di previdenza. A quelli che all’indomani non possono pensare perché hanno guadagni appena necessari al sostentamento della vita fisica, il legislatore accordò l’esenzione totale dall’imposta sino alle 400 lire imponibili (che vogliono dire 640 lire effettive nella categoria C ed 800 lire nella D nuova che è una suddivisione della prima) e minorazioni notevoli dalle 400 alle 800 lire, tenendo conto, in misura che potrà essere discussa e col tempo variata, del concetto espresso prima che il cosidetto reddito destinato o supposto destinato a consumi risparmi non è in realtà «reddito». Si può obbiettare ancora, contrariamente a quanto si osservò per i contribuenti di categoria A, che vi possono essere lavoratori provvisti, oltreché di redditi di lavoro, di redditi di capitale, così da non aver bisogno di risparmiare; ma, pur essendo questi casi frequentissimi, se ne deve fare astrazione per non complicare tecnicamente oltre misura l’assetto dell’imposta ed essendo inoltre probabile che si tratti di capitali modesti insufficienti ai molteplici bisogni a cui debbono servire, e bisognosi di incremento ad opera di nuovi risparmi.
A mezzo tra i redditi di capitale puro e di lavoro puro s’incontrano i redditi misti di capitale e lavoro (categoria B), che sono redditi di imprese industriali e commerciali. Per questi il bisogno di risparmio non è così vivo come per i redditi di lavoro puro, perché l’impresa sussiste e continua a fruttificare malgrado la malattia, l’invalidità, la vecchiaia, la morte dell’imprenditore; onde il contribuente ha già, entro certi limiti, provveduto ai casi tristi della sua vita mediante il semplice possesso dell’impresa. Non totalmente però; poiché quel reddito, derivando insieme dall’impiego del capitale e, dell’opera personale, resta dimezzato quando cessa o si attenua l’opera personale, che male viene sostituita da quella di commessi, impiegati, sovrastanti non interessati al buon andamento dell’impresa, forse interessati a rovinarla provvisoriamente per poterla acquistare a vil prezzo. La qual verità è manifesta pure dal fatto che, se un reddito di capitale puro si capitalizza al saggio di interesse del 4% (ossia moltiplicando 6000 lire di reddito per 25 volte ed ottenendo 150.000 lire che al 4% rendono appunto 6000 lire), un reddito misto si capitalizza al 10, 15, 20 e forse più per cento; il che vuol dire che 6000 lire di reddito annuo di una impresa industriale o commerciale valgono non 150.000, ma soltanto 60.000 o 40.000 o 30.000 lire. Se quindi il contribuente vuol formarsi un capitale di 150.000 lire, non avrà bisogno di prelevare dal suo reddito guadagnato annuo tutte le 150.000 lire, sì però la differenza fra le 60.000 o 40.000 o 30.000 lire che già vale la sua impresa e le 150.000 lire. Perciò il legislatore italiano ha reputato che il bisogno di risparmio di costui fosse intermedio tra quello nullo del capitalista e quello dei tre ottavi del lavoratore, concedendogli la detrazione dei due ottavi, e tassandolo sui rimanenti sei ottavi. Anche questa presunzione di risparmio, come le altre, può essere diversa dalla realtà e ci fa ancora una volta rimpiangere la vera imposta sul reddito consumato, a cui tali difetti sono estranei; ma è approssimazione bastevolmente vicina al vero.
Ancor più al vero ci si potrà approssimare, quando il legislatore si deciderà all’auspicata opera di perfezionamento, distinguendo nella categoria B dei redditi misti alcune delle sottocategorie in cui essa si divide e che per la prevalenza del capitale o del lavoro danno fondato motivo di presumere una quantità minore o maggiore di risparmio. È manifesto invero che una intrapresa industriale in cui l’elemento capitalistico sia di gran lunga predominante sull’elemento personale si capitalizzerà al 6%, perché la perdita dell’imprenditore potrà, con qualche sacrificio di stipendio e di cointeressenza ad un abile direttore, essere riparata; mentre una intrapresa commerciale, dove sia prevalente il fattore personale, si capitalizzerà al 20%, perché la morte del commerciante, che s’era procacciata la clientela colla sua abilità personale e la manteneva con lavoro assiduo, ne riduce grandemente il reddito. Il medesimo frutto annuo di 6000 lire varrà nell’un caso il capitale 100.000 lire e nell’altro caso appena 30.000 lire. Il primo imprenditore deve risparmiare la differenza fra 150.000 e 100.000 soltanto, se vuole conservare alla sua famiglia lo stesso reddito di capitale puro – e perciò al 4% – di 6000 lire; il secondo dovrà risparmiare la differenza tra 30.000 e 150.000 lire. Eppure il legislatore italiano li tratta amendue – e pei suoi tempi fece moltissimo – alla stessa stregua, esentando uniformemente i 2/8 del reddito.
Ma forse la principale e più semplice distinzione che ancor resta da fare nella categoria B è quella tra redditi misti proprii di individui e quelli ottenuti mercé l’intermediazione di strumenti economici speciali, chiamati società. La distinzione già sussiste nella pratica amministrativa, perché si pongono in gruppi differenti e si tassano con diversi metodi di accertamento i contribuenti privati e gli enti collettivi. Lasciando stare questa differenza, pure rilevantissima, ma qui irrilevante, nei mezzi d’accertamento, la ragion teorica di distinguere tra gli uni e gli altri contribuenti sta in ciò: che il reddito guadagnato dall’industriale e dal commerciante, che è imprenditore diretto, dirigente cioè personalmente la sua impresa, è reddito che deriva certamente, in misura notevole, sebbene più o meno grande, dal lavoro; e quindi devesi presumere che il suo bisogno di risparmio sia notevole. Mentre invece il reddito guadagnato dall’azionista di una società anonima industriale o commerciale è ottenuto sovratutto coll’impiego del capitale e in parte coll’impiego del lavoro. L’azionista delega quasi del tutto il lavoro inerente all’esercizio dell’impresa a direttori generali, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione, e questi remunera con stipendi fissi e con interessenze. Perciò egli compie un impiego che si può dire quasi intieramente di capitale; onde non vale la presunzione di un bisogno di risparmio per lui uguale a quello sentito dall’imprenditore diretto. La sua azione si capitalizza ad un saggio di interesse già depurato della spesa di stipendi ed interessenze ai dirigenti, epperciò il saggio corrente per la capitalizzazione sarà più basso di quello che si deve adottare per le imprese dirette, dove esso è al lordo delle spese stesse. Supponendo, come prima, un reddito di 6000 lire, di cui 3000 lire siano la rimunerazione dell’opera dei dirigenti, all’azionista rimarranno solo 3000 lire; ma queste si capitalizzeranno non al 6 o 20%, ma al 5 o 10%, a seconda della natura dell’impresa, e varranno in capitale 60.000 o 30.000 lire. Non sono ancora le 75.000 lire che egli dovrebbe possedere per avere, al 4%, da un impiego di capitale puro le stesse 3000 lire di reddito; ma la differenza risparmianda fra 75.000 e 60.000 o 30.000 lire è, proporzionatamente, minore che fra 150.000 e 100.000 o 30.000 lire. Dunque a lui deve essere concessa una detrazione minore per quota di risparmio. Andrebbe tuttavia nell’eccesso opposto colui che giudicasse non essere necessaria alcuna quota di risparmio, considerando questi redditi in tutto simili a quelli di capitale puro. Perché un certo lavoro è pure richiesto all’azionista, per cui s’intende, come deve il legislatore, l’azionista diligente pater familias, e non l’illuso predestinato a comprare ad alto prezzo carta straccia avente nome di «azione». L’azionista «normale» deve sapere leggere e leggere sul serio i bilanci e le relazioni del consiglio d’amministrazione, intervenire alle assemblee generali, muovere domande sui punti dubbi ed esigere spiegazioni «tempestive»; deve seguire i listini di borsa per conoscere l’opinione dei competenti intorno al valore della sua azienda, deve studiare l’andamento generale dell’industria, per entrare a tempo in un impiego ed uscirne del pari a tempo, per distribuire i suoi impieghi tra industrie diversamente soggette a crisi. Questo lavoro può essere compiuto dall’azionista mentre è sano e la sua intelligenza è lucida; onde non si consigliano siffatti impieghi ai pupilli, alle vedove, agli interdetti ed agli inabilitati, a cui invece i tribunali consentono l’impiego in terreni, case, mutui ipotecari, titoli di debito pubblico, obbligazioni di credito fondiario e obbligazioni industriali, ed altrettali investimenti di categoria A o di capitale puro. In Inghilterra il legislatore stesso ha designato, a tutela delle persone economicamente incapaci a seguire le vicende delle imprese industriali e commerciali, la linea di distinzione, vietando ai trustees o fiduciari del patrimonio altrui, a cui il testatore non abbia prefissato norme particolari di condotta, l’impiego in titoli non segnalati in apposita lista e non rispondenti a certi requisiti. Analoga linea di distinzione si potrebbe adottare per distinguere tra i titoli a reddito fisse (titoli di debito di stato e di enti pubblici, cartelle fondiarie, obbligazioni) e titoli a reddito variabile (azioni di preferenza, azioni ordinarie). Questi ultimi dovrebbero essere collocati in una sottocategoria della B; e dove alla B2 (redditi di imprese individuali) si continuasse ad assegnare la detrazione per risparmio presunto dei 2/8, alla B1 (redditi di azioni di società anonime o in accomandita per azioni) si potrebbe assegnare la minor detrazione di 1/8.[16]
Dopo il quale memorando esempio narrato ora della legislazione italiana non si dica più che il legislatore vuole sempre tassare il reddito guadagnato. Essendo la verità differentissima: che cioè il legislatore ha veduto chiaramente, con nitidezza perspicua, lo sconcio gravissimo di questa tassazione ed ha voluto evitarlo, approssimandosi quanto più poteva all’ideale della tassazione del reddito consumato, mercé le sue presunzioni di risparmio bisognevole alle varie categorie di contribuenti. Compito odierno della scienza e della legislazione dovrebb’essere quello di perfezionare vieppiù queste presunzioni, in guisa da approssimarle meglio alla realtà. Qualche via di perfezionamento fu qui in breve tracciata; ma l’opera potrebbe probabilmente essere grandemente perfezionata ove gli studi si rivolgessero, invece che a vani discorsi di giustizia sociale, ad approfondire i fatti della tecnica tributaria, giovando per tal modo efficacemente, anzi nella sola maniera efficace, all’avvento della «giustizia».
PROVA SECONDA: l’esenzione automatica del risparmio e l’imposta complementare sul patrimonio.
Altri legislatori preferirono battere diversa via per giungere in sostanza al medesimo risultato: istituendo cioè in aggiunta alle imposte sul reddito guadagnato le imposte sul patrimonio o sul capitale. È manifesto che tassare il reddito di lavoro, per cui si presume la necessità di un maggiore risparmio, sui 5/8 soltanto ed il reddito del capitale, per cui si presume inesistente quella necessità, su tutti gli 8/8, equivale a tassare, supponendo dell’8% l’aliquota dell’imposta, col 5% tutto il reddito del lavoro e coll’8% del pari tutto il reddito del capitale. Dal che si deduce che il sistema dell’esenzione del risparmio presunto può attuarsi sia col metodo italiano di adottare l’aliquota unica d’imposta e le variabili quote tassate del reddito guadagnato, come col metodo inglese della tassazione intiera del reddito guadagnato e delle aliquote variabili d’imposta. Come pure può attuarsi con un terzo sistema, che diremo prussiano o svizzero olandese, prendendo norma dai paesi che l’hanno prescelto; e consiste nel tassare con la stessa aliquota tutto il reddito guadagnato, senza distinzione di specie; ed aggiungere all’imposta sul reddito un’imposta sul patrimonio. Se tutte le specie di reddito guadagnato sono tassate coll’imposta del 5% ed inoltre il patrimonio è gravato con una imposta del 0,15% sul capitale, è evidente che, supponendo un saggio di frutto del 5%, si ottiene lo stesso risultato tributario dei metodi precedenti. Infatti il reddito di lavoro, non usando esso capitalizzarsi nelle società dove è ignota la schiavitù personale, sarà tassato colla sola imposta del 5%; mentre i redditi di capitale sono tassati col 5% sul reddito e poi ancora col 0.15% sul capitale; ossia, poiché il capitale 100, secondo l’ipotesi fatta, dà il reddito 5, con un’altra imposta del 3% sul reddito del capitale e in tutto coll’8% sul reddito.
L’imposta complementare sul patrimonio non altro dunque è in sostanza che un metodo, tecnicamente consigliabile in certi paesi che non hanno i precedenti italiani della tassazione dei redditi per categorie, per attuare il teorema milliano della esenzione dei risparmi. È un metodo, inoltre, che può essere consigliabile per evitare talune delle difficoltà sopra vedute che s’incontrano nella determinazione delle diverse quote presunte di risparmio a seconda delle diverse categorie di reddito. Provvede a tale determinazione spontaneamente il mercato col mirabile strumento del saggio d’interesse. Come ciò accada, è facile spiegare. Supponiamo un legislatore che abbia d’uopo di ricavare il 10% d’imposta dal reddito consumato dai cittadini; e supponiamo ancora che, per presunzione sua, confortata da indagini statistiche, i lavoratori o professionisti abbiano bisogno ed in media usino di risparmiare (risparmio capitalistico e risparmio personale) metà del loro reddito guadagnato; e che sia minore la quota proporzionale di risparmio di tutti gli altri contribuenti. Di quanto sia minore non è precisamente noto; onde si spiegano le approssimate e forse erronee presunzioni dei legislatori italiano ed inglese. Il legislatore, che voglia evitare il pericolo di errori, opera come segue. Colpisce tutto il reddito guadagnato di tutti i contribuenti con un’imposta del 5%; talché il contribuente lavoratore privo di qualsiasi patrimonio, pagando 5 lire sulle 100 che guadagna, paga in realtà 5 lire sulle 50 che consuma, e l’imposta è per lui precisamente perciò del 10% sul reddito consumato. Colle altre 50 lire risparmiate egli, al 5% d’interesse posticipato, alla fine della sua probabile vita produttiva, che fissiamo per ipotesi in quasi 23 anni, avrà accumulato un patrimonio di 2000 lire. S’intende che ove il guadagno sia maggiore delle lire 100, il capitale risparmiato alla fine dei 23 anni sarà maggiore di L. 2000. Basta, per calcolarlo, moltiplicare le lire 2000 per il multiplo del guadagno effettivo in confronto alle supposte lire 100 annue. Gli altri contribuenti oltre l’imposta del 5% sul reddito, pagano il 0.25% sul patrimonio, colla quale automaticamente la loro parte è adeguata a quella del lavoratore puro. Infatti l’industriale che ha reddito di 100, il quale viene capitalizzato dal mercato, per l’incertezza delle sorti dell’impresa, per la connessione della sua produttività colla vita dell’imprenditore, al saggio di interesse del 20%, possiede già un patrimonio di 500 lire. Forte di tal possesso, egli ha bisogno di prelevare dal suo reddito di 100 solo una quota annua di risparmio di L. 37,50; perché con questa quota egli accumula in quasi 23 anni – si suppone per lui la stessa vita attiva probabile per uniformità di calcolo – il capitale di L. 1500, le quali unite alle L. 500 già possedute formano lo stesso patrimonio che il lavoratore accumula col risparmio di 50 lire all’anno. Il suo reddito consumato si riduce perciò a L. 62,50; e su queste egli paga L. 5 per imposta del 5 sul reddito guadagnato di L. 100 e L. 1.25 per imposta al 0.25% sul capitale posseduto di L. 500, in tutto L. 6.25, che sono precisamente il 10% delle L. 62.50 di suo reddito consumato.
Supponiamo ora l’azionista, che ha lo stesso reddito di L. 100, capitalizzato però al 6.66%, a norma della valutazione di mercato del reddito futuro probabile dell’impresa azionaria. Costui già possiede perciò un capitale di L. 1500; ed a lui basta risparmiare L. 12.50 all’anno, ottenendo dopo i soliti quasi 23 anni il capitale di L. 500, le quali aggiunte alle L. 1500 già possedute, formano il capitale totale bisognevole di L. 2000. Egli, pagando L. 5 a titolo di imposta sul reddito e L. 3.75 (0.25 su 1500) a titolo di imposta sul patrimonio, paga L. 8.75 in tutto, ed anche qui precisamente il 10% delle L. 87.50 di reddito che gli rimangono da consumare, dopo detratta la quota presunta di risparmio di L. 12.50.
Giungiamo finalmente al capitalista puro che ha reddito guadagnato di L. 100 ed un patrimonio di L. 2000, corrispondente alla capitalizzazione al saggio d’interesse del 5% del reddito di 100 lire. Costui nulla ha d’uopo di consumare, possedendo già il patrimonio che gli altri acquistano alla fine della loro vita produttiva. Ed egli pagando 5 lire a titolo di imposta del 5% sul reddito guadagnato e 5 altre lire a titolo di imposta del 0.25% sul patrimonio di L. 2000 ossia in tutto L. 10, paga il 10% del reddito da lui consumato, che è di L. 100.
Ecco come l’imposta complementare sul patrimonio attua automaticamente, con prontezza stupenda, l’esenzione del risparmio, ovvero, che è la stessa cosa, la tassazione costante del reddito consumato. Basta osservare due condizioni: 1) fare una presunzione corretta di risparmio per i lavoratori puri e ridurre in proporzione l’aliquota dell’imposta sul reddito guadagnato: se il risparmio presunto è del 50% e l’aliquota necessaria è del 10% sul consumato, bisogna ridurre al 5% l’aliquota sul guadagnato, mentre, se il risparmio presunto è del 25%, restando ferma l’aliquota necessaria o reale sul consumato al 10%, bisognerà ridurre l’aliquota figurativa sul reddito guadagnato al 7.50%, ecc. ecc.; 2) attenersi, s’intende per periodi lunghi e nelle medie, al saggio d’interesse realmente corrente sul mercato per gli impieghi capitalistici puri. Se il saggio è del 5% bisognerà fissare al 0.25% l’aliquota dell’imposta sul patrimonio; perché così il capitalista che ha reddito guadagnato di 100 e per conseguenza possiede un patrimonio del valore di L. 2 pagherà L. 5 per l’un titolo e L. 5 per l’altro; ed in tutto le L. 10 necessarie sulle 100 di reddito consumato. Che se il saggio d’interesse per gli impieghi capitalistici puri si riduce al 4%, l’aliquota dell’imposta sul patrimonio deve essere del pari ridotta al 0.20%; perché così il contribuente capitalista pagherà L. 5 d’imposta sul reddito e L. 5 (0.20% su 2500 lire valore nuovo capitalizzato di L. 100 di reddito all’interesse del 4%) per imposta sul patrimonio, ossia sempre le solite 10 lire sul totale reddito consumato o presunto consumato dal capitalista. Quando questi dati primi siano correttamente determinati, si può lasciare al mercato la fissazione della imposta da pagarsi dai contribuenti intermedi tra il capitalista puro e il lavoratore puro. A parità di reddito guadagnato il mercato darà una valutazione più o meno alta al valore capitale corrispondente; e il contribuente pagherà più o meno d’imposta in somma assoluta, in corrispondenza al suo minore o maggior bisogno di risparmiare e al maggiore o minor reddito suo consumato.
Il problema delicatissimo che tanto angustia o dovrebbe angustiare il legislatore italiano od inglese è risolto in modo spontaneo dal sistema dell’imposta complementare sul patrimonio, affidando alle valutazioni del mercato la determinazione della quantità di imposta da pagare. Vero è che lo stupendo risultato è ottenuto a condizione che si presuma correttamente il risparmio dei lavoratori puri e che si faccia variare l’aliquota dell’imposta sul patrimonio sincronicamente e nello stesso senso delle variazioni del saggio d’interesse sul mercato per gli impieghi capitalistici puri. Vero è che molti errori si possono commettere mentre si tenta di osservare queste condizioni; e che ben può darsi che il mercato abbia dato una corretta valutazione patrimoniale dei redditi ed il fisco non la conosca, per imperfezione dei suoi strumenti tecnici di accertamento, talché si può forse concludere che praticamente il sistema italiano della esenzione diretta di quote di risparmio presunte dal legislatore e il sistema dell’imposta complementare patrimoniale finiscano per equivalersi: essendo più grezzo il primo ma più agevole ad attuarsi; più perfetto il secondo, bensì anche più delicato.[17] La diffusione crescente dell’imposta patrimoniale, qualunque siano i motivi apparenti che furono addotti a giustificarla, prova come mai s’appongano al vero coloro che hanno in ispregio le imposte sul reddito consumato e stanno attaccati ai tributi sul guadagno; essendo invece l’imposta patrimoniale, sebbene diversissima nella forma, uno strumento tecnico foggiato per raggiungere il medesimo intento che le imposte sui consumi e le imposte suntuarie si propongono: ossia l’esenzione del risparmio.
PROVA TERZA: l’esenzione di una quota variabile del reddito secondo il numero dei componenti la famiglia.
Al qual fine tendono pure le disposizioni con le quali nelle imposte sul reddito o di famiglia si esenta da tributo una quota variabile secondo il numero delle persone a carico del capo famiglia: p. es., 400 lire a testa compreso il capo nella milanese imposta di famiglia, sino alle 70.000 lire di reddito. La presunzione qui fatta è manifestamente quella che cresca il bisogno di risparmio d’ogni specie quanto più cresce la famiglia ed aumentano i doveri del capo; sicché il reddito disponibile per godimenti presenti scemi d’altrettanto. Trattasi di presunzione soggetta, come ogni altra, a fallire nei casi singoli, sebbene valida nella media dei casi, per la qual media sono fatte le presunzioni. Di cui altri esempi si potrebbero discorrere, oltre quello milanese, tratti dalle legislazioni forestiere; dai quali, per non dilungarci inutilmente, deliberatamente ci asterremo.
PROVA QUARTA: l’esenzione dei premi di assicurazione.
Non più presunzioni di risparmio; ed invece risparmi effettivi si hanno di mira in un’altra serie di immunità: quella relativa alle quote di assicurazione. Citerò soltanto l’esempio dell’Inghilterra che esenta dall’imposta sul reddito i premi di assicurazione sulla vita pagati dal contribuente fino ad un 1/6 del reddito; e quello della Prussia che li esenta fino al massimo di 600 marchi l’anno. Più largo e logico di tutti il progetto Sonnino del 1910 di avocazione allo stato dell’imposta di famiglia esentava da tributo qualunque somma pagata a titolo di premio di assicurazione a nome del capo di famiglia.[18] Sono norme che testimoniano della ripugnanza diffusa a considerare come reddito una ricchezza che attualmente non si gode; parziali ammissioni del teorema fondamentale. Il quale vedemmo sopra non potersi attuare direttamente per la possibilità di frodi: mentre, se questa possibilità viene a mancare ed è assurdo supporre che il contribuente risparmi o finga di risparmiare durante un esercizio finanziario per ottenere l’immunità tributaria, salvo consumare il risparmiato nell’esercizio successivo, rivive in tutta la sua interezza il principio e l’esenzione deve essere concessa. Questo è manifestamente il caso dei premi d’assicurazione sulla vita, essendoché nessuno vuole obbligarsi a rinunciare per tutta la vita o per lunghi anni alla sua ricchezza soltanto per evitare un tributo, se all’opera del risparmio non sia deliberato. Ai premi di assicurazione sulla vita in caso di morte o per capitali differiti devono essere ragguagliati e talora lo sono i premi pagati per le assicurazioni contro gli infortuni, le malattie, la vecchiaia, la invalidità, la sepoltura; ed eziandio le quote, pagate ad ogni maniera di società di mutuo soccorso e di resistenza, quando si possa constatare che il contribuente rinuncia ad una ricchezza presente in cambio di una promessa di prestazione futura. Quando in futuro si avrà la prestazione dalla società di assicurazione, di mutuo soccorso o di resistenza, la ricchezza ricevuta sarà o non sarà reddito a seconda dell’uso che se ne farà, ben potendo darsi che sia nuovamente investita capitalisticamente o rivolta a scopi di risparmio personale; nel qual caso converrà vedere se l’imposta sia foggiata a tipo di imposta sul guadagnato ed allora saranno esenti solo le quote presunte di risparmio; o sul consumato, ed allora invece automaticamente tutto l’investito sarà esente.
La teoria qui svolta torna massimamente a beneficio – se beneficio si può chiamare l’immunità dall’imposta non dovuta – delle classi medie e lavoratrici; essendo queste soltanto che s’assicurano sulla vita (in Italia la somma media assicurata batte sulle 6000 lire) o che s’inscrivono alle società di mutuo soccorso, alle casse pei vecchi, alle società di resistenza. Nuova conferma che il teorema fondamentale non è, come falsamente si assevera, benigno ai ricchi ed ostile ai poveri. Anzi a questi è benignissimo e verso quelli severissimo esentandoli soltanto quando rinuncino a godere la propria ricchezza. Sulla quale considerazione, che in sé stessa sarebbe turpe in una memoria scientifica, è d’uopo insistere, essendoché gli uomini si lasciano guidare dalle parole vane, della quale la più vanissima è la «scienza democratica», alla quale guai a non rendere omaggio!
PROVA QUINTA: L’esenzione delle foreste nel periodo del rimboschimento.
Molte legislazioni estere e negli ultimi anni anche la legislazione italiana concedono l’esenzione dall’imposta alle foreste nei primi 10 o 20 o 30 anni di loro vita. Mossero queste immunità dal contemplare i dannosi effetti del disboscamento e dal proposito di incoraggiare il rimboschimento mercé l’immunità dell’imposta. In realtà questa logicamente procede dal canone che vuole la tassazione del reddito consumato invece di quello guadagnato. Infatti la creazione di una foresta può considerarsi come un riporre annualmente una somma a frutto in una cassa di risparmio, alla quale i depositi con gli interessi composti non si possono richiedere se non dopo un certo periodo di tempo variabile dai 15 anni per i boschi cedui o i pioppeti canadensi, sino ai 65-70 anni per le abetaie ed ai 100 anni per i querceti. Il frutto o guadagno annuo che danno le selve consiste nell’incremento legnoso, che è diverso da essenza ad essenza. Fu calcolato, ad esempio, per le querce che se il loro volume in metri cubi è di 0.05 tra gli anni 1-25, diventa di 0,25 tra gli anni 25-50, di 0.62 tra gli anni 50-75, di 1.47 tra gli anni 75-100, di 2.73 negli anni 100-125, di 4.60 negli anni 125-150, di 5.43 negli anni 150-175, di 5.96 negli anni 175-200. Veggasi come i valori assoluti aumentino col crescere degli anni; ma gli incrementi proporzionali diminuiscano di anno in anno; talché nelle varie tabelle che si conoscono al riguardo si hanno per le querce valori d’incremento relativo del 10% circa per i buoni boschi ordinari a 20 anni, del 6-7% a 30 anni, del 5 a 40 anni, del 4 a 50 anni, del 3 a 60 anni e via decrescendo.[19] Vuol dire, che gli alberi si sviluppano rapidamente dapprima e poi, dato lo sviluppo precedente già avvenuto, al quale si paragonano gli incrementi susseguenti, via via più lentamente, finché ad un certo punto l’incremento diventa irrilevante e poi cessa convertendosi in un deterioramento fisico, per cui l’albero alla fine, ove l’uomo non se ne occupasse, finirebbe per rovinare affatto e dissolversi. Questa vicenda determina, insieme al dato fisso del saggio d’interesse corrente per gli impieghi capitalistici forestali, l’epoca del taglio a rendita massima. Gli scrittori di scienza forestale hanno dato di ciò assai eleganti dimostrazioni. Qui basti accennare come quell’epoca tanto più si allontana, quanto più il coltivatore di foreste può contentarsi di un interesse minore. Infatti si supponga un incremento legnoso (intendendo per incremento legnoso il rapporto del prodotto che si ricaverebbe tagliando l’albero in un anno col prodotto che si ricaverebbe eseguendo il taglio nell’anno precedente) che nei successivi anni sia:
|
al
|
10°
|
20°
|
30°
|
40°
|
50°
|
60°
|
70°
|
80°
|
anno
|
|
del
|
12
|
10
|
6-7
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
per cento
|
Se il saggio d’interesse è del 10% il taglio deve essere eseguito al 20esimo anno, perché altrimenti, vivendo l’albero, il coltivatore guadagnerebbe in seguito un incremento legnoso (interesse) minore del 10% e volgente via via verso il 6-7%; mentre se l’albero è tagliato ed il ricavo è investito in altra maniera dà il frutto del 10 per cento. Se l’interesse è del 6-7% la vita dell’albero può durare convenientemente sino a 30 anni; e così via via, a mano a mano che l’interesse diminuisce, cresce la vita economica dell’albero, finché, essendo sul mercato ribassato l’interesse all’1%, è conveniente lasciar vivere sino all’80esimo anno di età quello stesso albero che, dato un saggio d’interesse del 10%, bisogna tagliare al 20mo anno. Nuova dimostrazione dell’influenza del saggio d’interesse sulla lunghezza d’investimento dei capitali, la bassezza del saggio favorendo le opere grandi a lunga scadenza, fra cui sono principalissimi nella vita di una nazione i rimboschimenti, e l’altezza del saggio esagitando gli uomini colla brama dei subiti e lauti guadagni.
Su questo fondamento di fatti si innestano due principali maniere di esigere l’imposta. L’una che si potrebbe chiamare della tassazione del reddito guadagnato considera l’incremento legnoso come il guadagno che ogni anno il coltivatore della foresta ricava dalla medesima. Poiché reddito è la massa nuova di ricchezza che s’acquista durante il periodo di tempo considerato e che si può consumare senza intaccare quella che s’aveva al principio del periodo, nel decimo anno si reputa reddito della foresta l’incremento del 12% in quell’anno verificatosi, nel ventesimo l’incremento legnoso del 10%, ecc. ecc., ed il valore degli incrementi stessi si tassa ogni anno coll’imposta. Giunti al momento del taglio, che supponiamo avvenga al cinquantesimo anno di età, il contribuente nell’anno stesso paga l’imposta sull’incremento legnoso del 4% avuto in quell’anno e nulla più. Egli incasserà il valore del taglio intiero senza più pagare su di esso alcuna imposta, avendola già pagata negli anni precedenti quando l’albero a mano a mano cresceva. Una variazione di questo metodo è quello per cui invece di tassare negli anni successivi una serie variabile decrescente di incrementi legnosi, del 12, 10, 6, 5, 4%, il che importerebbe molta complicazione di calcoli per l’amministrazione fiscale, si trasforma la serie variabile decrescente in una serie costante di incrementi, poniamo del 6% e si suppone che la foresta dia dal primo fino al cinquantesimo anno di età un reddito costante, quello tassando per semplicità. Volendo operare con tutta esattezza, occorrerebbe modificare ancora le fatte ipotesi tenendo conto di altri fattori, sui quali trascorro, essendo materia estranea al presente discorso, al quale importa soltanto di mettere in luce l’essenziale diversità dal primo al secondo metodo. Il quale ultimo consiste nel non tassare affatto la foresta, mentre essa matura e si avvicina al momento in che il taglio darà la rendita massima; e nel tassarla precisamente in questo momento del taglio, quando il reddito, accumulato nel frattempo, quasi come pel gioco degli interessi composti una somma iniziale s’ingrossa su un libretto di cassa di risparmio, viene realizzato e reso effettivamente consumabile dal Coltivatore.
Volendo considerare i diversi effetti delle due maniere d’imposta, l’una delle quali tassa gli incrementi legnosi anno per anno e l’altra il taglio quando s’effettuerà al quarantesimo, cinquantesimo o sessantesimo anno di età, variabilmente a norma del dominante saggio d’interesse, si deve notare anzitutto che la scelta tra i due metodi è in un lungo periodo di tempo indifferente per l’erario: inquantochè è chiaramente uguale tassare anno per anno gli incrementi ovvero tassare alla fine del periodo l’albero in cui tutti quegli incrementi si sono insieme fusi. Nulla può perdere l’erario col secondo metodo rispetto al primo, perché ogni incremento legnoso va ad arricchire il valore dell’albero che dovrà poi essere tassato; e può desso star sicuro che l’albero non vivrà più a lungo di quanto economicamente sia utile, essendo stato dimostrato sopra come l’interesse del coltivatore forestale lo spinga ad effettuare il taglio appena l’incremento legnoso sia divenuto inferiore al saggio di interesse corrente. L’erario, scegliendo il secondo metodo, si costituisce un fondo occulto, risparmiato di materia imponibile, che ad una certa data necessariamente giungerà a scadenza e dovrà essere realizzato. Invece di consumare il grano in erba, come i contadini affamati in tempo di carestia e di siccità o come le bande di lanzichenecchi nei quartieri d’inverno, aspetta a consumarlo quando è maturo.
Così facendo promuove, senza, e ciò è essenzialissimo, concedere veruna immunità tributaria, il crescere della materia imponibile, che col primo metodo invece neppure prende nascimento. Perché è vero che il contribuente piantatore di foreste «guadagna» ogni anno l’incremento legnoso che è del 12, 10, 6, 5, 4 nei successivi anni; ma è anche vero che egli quel guadagno non realizza, non gode se non al momento del taglio. Quindi è vero che il contribuente si turberà gravemente quando gli sia richiesto il pagamento di un tributo nel momento in che egli non solo nulla incassa, nulla gode, anzi tuttavia spende per le cure dell’impianto della foresta, rinunciando a godimenti presenti in cambio di un provento futuro. Qui si pare tutta la differenza esistente fra i due metodi di tassazione del reddito guadagnato e del reddito consumato. Negli impieghi ordinari il reddito guadagnato è una quantità quasi costante di anno in anno, la quale quindi può assumere per le persone d’indole conservatrice l’aspetto di quantità consumabile durante l’anno; onde la tassazione sua non scandalizza l’opinione comune. Nel caso delle foreste il fattore «tempo» acquistando un’importanza straordinariamente in luce chiarissima il distacco profondo che esiste fra l’un concetto e l’altro e la predilezione spontanea degli uomini per il secondo metodo di tassazione. Predilezione che si accresce pel fatto che gli uomini sono poco usi a ficcar lo sguardo in fondo al tempo e ad apprezzare le cose lontane. Amano i redditi grossi ed immediati, preferiscono il titolo di debito pubblico 4%, sebbene facilmente convertibile, sebbene emesso alla pari e perciò senza alcun premio al rimborso, al titolo 3%, sebbene difficilmente convertibile, sebbene emesso al disotto della pari, ad un prezzo variabile tra la parità di 75 ed il nominale di 100 e quindi con premio fino a 25 lire al rimborso, perché essi sono di corte vedute, perché amano il 4% invece del 3% perché è 4, ossia un quantità maggiore immediata, senz’altro impacciarsi di calcoli, perché ognuno teme di morire presto innanzi di godere i frutti dell’impianto e ben pochi rinunciano ai godimenti presenti a pro delle generazioni venture.
Già è grande la difficoltà di trovare tra gli agricoltori chi voglia piantar foreste; tutti preferendo il grano, che dopo otto o nove mesi giunge a maturazione, alla vigna che frutta dopo tre anni. Si diffondono soltanto i pioppi del Canadà, ognuno sperando di vivere i 15 anni necessari a fare il lucroso taglio. Ma tutti riluttano a rimboschire pendici denudate di alti colli e di montagne, dove occorrono lavori costosi di sistemazione idraulica e terriera e dove i tagli si fanno aspettare oltre il termine della vita del piantatore. Se alla riluttanza innata nell’uomo per gli impieghi a lunga scadenza aggiungiamo l’imposta sul guadagno annuo fornito dagli incrementi legnosi, vieppiù s’inviperisce l’animo del rustico contro le foreste, già odiate per l’ombra funesta e per il terreno tolto a culture più redditizie nei tempi prossimi. Non incassar nulla è già un malanno grosso, pagare in aggiunta tributo cresce lo scorno e l’ira. Il tributo sul reddito realizzato, ossia sul taglio effettivamente compiuto appare l’unica soluzione, poiché rinvia l’epoca del pagamento del tributo al momento in che il contribuente realizza il reddito ed ha agevolezza di assolvere il debito tributario, così come insegna la terza aurea regola di Adamo Smith.
L’inconveniente di rendere deserti di tributi gli anni tutti di vita dell’albero, accumulandoli alla fine, contrariamente all’interesse fiscale di avere redditi ogni anno costanti è tutt’affatto apparente e transitorio. Apparente, perché, se così non si opera, il tributo non s’incassa né prima, né poi, per la ripugnanza degli uomini a rimboschire e per il dilavarsi delle pendici, le quali diventano rocce improduttive e insofferenti di imposta. Transitorio, perché dura solo fino a quando la foresta sia giunta nel periodo detto dai foresticultori «di regime». Gli impianti invero si fanno in guisa che, passato il periodo iniziale, la foresta sia assestata, così che ogni anno in perpetuo si possa operare un taglio regolare per una zona che, di nuovo piantata, darà taglio nuovamente dopo 40 o 50 anni. Cosicché, supposta una superficie da rimboschire di 1 milione di ettari, e supponendo che ogni anno gradualmente si rimboschino 20 mila ettari, secondo un piano ragionato di assestamento, occorreranno 50 anni prima di giungere al rimboschimento completo di tutto il milione d’ettari. Supposto poi che il momento del taglio secondo la rendita massima sia di 50 anni, ogni anno, a partire dal 51mo anno, si farà il taglio su una zona di 20 mila ettari; e ciò durerà all’infinito, perché al 101mo anno, dopo aver tagliate tutte le 50 zone primamente rimboschite, si tornerà a tagliare la prima zona, già tagliata nel 51mo anno e subito rimboschita, che nel 101mo anno sarà divenuta per la seconda volta matura pel taglio; e così via di seguito per la seconda, terza, quarta, ecc., zona.
Volendo rappresentare in un quadro il comportarsi dell’imposta a seconda che si adotti l’uno o l’altro sistema di tassazione, diamo il risultato del numero delle zone tassate sulle 50 che compongono il territorio considerato:
|
Anno
|
Tassazione secondo il reddito realizzato (3)
|
|
Tassazione secondo il reddito guadagnato (1)
—
Zone tassate
|
Zone da rimboschire tassate (2)
|
Zone in rimboschimento esenti
|
Zone assestate a foresta
in regime normale
|
|
Zona tassata
|
Numero totale nell’anno
|
|
1°
|
50
|
49
|
1
|
–
|
–
|
|
2°
|
49
|
48
|
2
|
–
|
–
|
|
3°
|
48
|
47
|
3
|
–
|
–
|
|
4°
|
47
|
46
|
4
|
–
|
–
|
|
5°
|
46
|
45
|
5
|
–
|
–
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
46°
|
5
|
4
|
46
|
–
|
–
|
|
47°
|
4
|
3
|
47
|
–
|
–
|
|
48°
|
3
|
2
|
48
|
–
|
–
|
|
49°
|
2
|
1
|
49
|
–
|
–
|
|
50°
|
1
|
–
|
50
|
–
|
–
|
|
51°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
1a
|
|
52°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
2 a
|
|
53°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
3 a
|
|
54°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
4 a
|
|
55°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
5 a
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
96°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
46 a
|
|
97°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
47 a
|
|
98°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
48 a
|
|
99°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
49 a
|
|
100°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
50 a
|
|
101°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
1 a
|
|
102°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
2 a
|
|
103°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
3 a
|
|
104°
|
–
|
–
|
–
|
50
|
4 a
|
|
105
|
–
|
–
|
–
|
50
|
5 a
|
|
(1) Nel qual caso non avviene il rimboschimento
(2) Sul reddito delle altre culture
(3) Nel qual caso avviene il rimboschimento
Se il rimboschimento non si effettua, perché gli agricoltori sono atterriti dalla necessità di dover pagare subito l’imposta sul guadagno dato dagli incrementi legnosi, il fisco nel primo anno si rallegra, perché tassa tutte le 50 zone sul reddito che se ne può ricavare destinandole alla cerealicultura, alla pastorizia, alla vigna, ecc. Ma proseguendo gli elementi la loro opera distruggitrice sul lieve strato di terra feconda, al secondo anno una zona sarà divenuta improduttiva ed il fisco dovrà a malincuore esentarla per l’abbandono dei proprietari, riducendosi a tassare solo 49 zone; e così via, sinché al 50mo anno avanza un’unica zona tassabile; e poi per la troppa ingordigia iniziale, ogni materia imponibile è scomparsa per sempre. Se invece, grazie all’aver rimandato l’imposta al momento del taglio, il rimboschimento si inizia, durante i primi 50 anni il fisco avrà un danno, perché vedrà a poco a poco diminuire le zone coltivate e tassabili; e crescere le zone in corso di rimboschimento ed esenti. Il danno non sarà tuttavia sensibilmente maggiore di quanto si avrebbe senza l’esenzione, come dalla tabella è chiarito; con questo vantaggio che il rimboschimento delle zone più pericolose rinsalda le rimanenti e le rende atte ad una maggiore produzione. A partire dal 51mo anno tutto il milione di ettari, diviso in 50 zone di 20 mila ettari l’una, è entrato in regime; ed ogni anno si procede al taglio di una zona ed alla tassazione del taglio stesso, procedendo dalla prima alla 50ma e poi ricominciando dalla prima e così via in perpetuo. Perciò a partire dal51 mo anno, mentre col metodo della tassazione sul reddito guadagnato e colla conseguente distruzione della foresta[20] ogni materia imponibile è onninamente scomparsa, col metodo della imposta sul reddito realizzato (taglio) ogni anno si può tassare all’infinito una zona, produttiva sempre di un taglio approssimativamente uguale. Né si gridi che il metodo è dannoso al fisco, perché ogni anno tassa soltanto 20.000 ettari invece del milione che sarebbe tassato coll’altro sistema; perché, come già spiegammo, è perfettamente equivalente tassare l’intiero taglio di 20 mila ettari, ovvero l’incremento legnoso dell’anno su un milione di ettari.
Il solo rimprovero perciò che si possa fare alle moderne norme volute dal legislatore italiano è questo: che l’esenzione limitata ai primi 10 o 20 o 30 anni è troppo esigua cosa; essendo necessaria estenderla a quel periodo, lungo o breve a seconda delle varie essenze forestali, per cui dura il periodo iniziale del rimboschimento; ed essendo mestieri tassare nel periodo d’assestamento il valore medio del taglio dell’anno, dedotte le spese.
Si noti finalmente che questo metodo, che è il solo razionale, non traduce ancora perfettamente in atto il teorema dell’esenzione del risparmio, essendo questo un atto virtuoso del foresticultore e non della foresta. Il teorema richiederebbe che nel 51esimo anno e nei susseguenti si tassasse il prodotto del taglio se il foresticultore lo consuma di fatto; e lo si esentasse se viene risparmiato. Ma sapendosi oramai troppo bene quali sono le difficoltà di attuazione del teorema, il legislatore s’è contentato di farne una applicazione approssimata esentando il risparmio – ossia l’aggiungersi di sempre nuovi incrementi legnosi, non mai realizzati, ai precedenti fino al momento della rendita massima – finché va accumulandosi nell’albero, e facendo intervenire l’imposta quando il taglio si realizza, disperando di poter perseguire l’applicazione del teorema fino alle sue ultime conseguenze, come pur si dovrebbe in una società di contribuenti puri, non mai esistiti in passato e non prevedibili nell’avvenire.
PROVA SESTA: la tassazione dei redditi del lavoro e delle pensioni vitalizie.
Le considerazioni fatte sulla tassazione delle foreste ci aiutano a risolvere uno degli argomenti più vessati nella dottrina dei tributi: il trattamento fiscale dei redditi vitalizi o temporanei. Dei quali due sono le maniere principali: i redditi del lavoro che durano quanto la vita produttiva dell’uomo, e le pensioni (o censi) vitalizie che durano quanto la vecchiaia dell’uomo stesso. Le incertezze che in molti scrittori si osservano su questo punto derivano dall’avere considerate le due maniere di reddito temporaneo l’una disgiuntamente dall’altra, e dal non essere rimontati, con dirittura di logica, al postulato fondamentale dell’uguaglianza. Il legislatore italiano professa anch’egli un’opinione con sé stessa contrastante quando tassa i redditi del lavoro in categoria C dell’imposta di ricchezza mobile, esentandone i 22/40 reputati necessari pel risparmio e di nuovo le pensioni vitalizie nella medesima categoria C, esentando da tributo i medesimi 22/40 perché considerati come rimborso del capitale che il vitaliziato ha sborsato in passato ad una impresa di assicurazione per averne il vitalizio. I due motivi di esenzione sono contraddittori, perché nel primo caso si esenta il risparmio compiuto in previsione di eventi futuri, nel secondo la quota di risparmio fatto nel passato e che vi è ogni presunzione sia consumata nel presente. Là si vuole esentare il capitale che sta formandosi; qui il capitale già formato che va consumandosi. Ancora è illogica la maniera tenuta nell’esentare la quota di capitale contenuta nella rendita vitalizia. Si comprende che, in mancanza di qualsiasi dato positivo sulla quantità di risparmio compiuta di fatto dai lavoratori per provvedere ad avvenimenti futuri, il legislatore abbia, in via di approssimazione empirica, adottato la regola dell’esenzione dei 22/40; non altrettanto si comprende perché la stessa determinazione empirica siasi preferita quando si poteva ricorrere a perfette tavole di interessi composti e di mortalità, le quali ci dicono quanto, su 100 lire di rendita vitalizia, debba essere considerato, data l’età del vitaliziato e dato un certo saggio d’interesse, rimborso di capitale e quanto interesse, esentando, se così volevasi, il primo e tassando il secondo.
Passando ora dalla critica della legge vigente alla sposizione dei principii che dovrebbero regolare la materia, dobbiamo subito notare che la vita dell’uomo si divide in tre parti: la pre-produttiva, quella produttiva, che va dalla maggiore età economica alla età in cui l’uomo, stanco, si ritira dal lavoro, e la post produttiva. Della prima fase della vita dell’uomo, la finanza non ha bisogno di occuparsi, per le ragioni innanzi discorse (cap. 6, n. 3), ed anche perché, incastrandosi la vita d’una generazione nella vita d’ogni altra precedente e susseguente, bisogna, per non cagionare dei doppi d’imposta, considerare una sola delle due vite durante il periodo in cui esse si sovrappongono; e sembra opportuno considerare la vita del padre, il quale procaccia la ricchezza a sé e ai figli, quando essi sono da lui dipendenti. Durante l’età produttiva, che va dai 15-25 ai 55-65 anni, il lavoratore, guadagnando dall’esercizio del mestiere, o professione od arte 1000 lire all’anno, ne consuma una parte, suppongasi 800, e l’altra parte 200 investe. Suppongasi che, essendo durata la sua vita produttiva 41 anni circa, costui abbia accumulato all’interesse composto del 4% al 60esimo anno di età su un capitale di 20.000 lire. Essendo rimasto scapolo, ipotesi necessaria nel caso di susseguente vitalizio, e non avendo perciò famiglia a cui provvedere, egli dà le 20.000 lire ad un’impresa di assicurazione la quale, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, gli promette un annuo vitalizio di 2000 lire. Ecco posto il problema della tassazione. Come deve essere tassato costui nei due periodi produttivo e post produttivo della sua vita? Il problema viene risoluto diversamente dai due principii: quello «falso» della tassazione sul reddito guadagnato, e il «vero» della tassazione sul reddito consumato. Il primo principio tratta il guadagno del lavoratore come l’incremento legnoso dell’albero. Non solo tassa le 800 lire consumate, ma eziandio le 200 lire risparmiate, perché sono un guadagno che il lavoratore ha ottenuto durante l’anno e che potrebbe consumare se volesse, senza intaccare menomamente la sua fortuna originaria che era nulla. Egli preferisce aggiungere anno per anno le 200 lire le une alle altre sui conti del libretto della cassa di risparmio, ingrossando il suo credito, così come il foresticultore lascia che gli strati di incremento legnoso s’aggiungano l’uno all’altro ingrossando il tronco; ma poiché d’altrettanto cresce il patrimonio alla fine dell’anno in confronto al principio dell’anno, così l’imposta percuote tutte le lire. Nel periodo post produttivo l’imposta sul reddito guadagnato si fa apparentemente benigna: poiché il lavoratore aveva alla fine del 60esimo anno di età sua accumulato un patrimonio di 20.000 lire e l’ha permutato con una pensione vitalizia di 2000 lire, durabile, secondo i calcoli dell’impresa assicurativa, per 13 anni di sua vita probabile, l’imposta distingue in questa ciò che è interesse da ciò che è rimborso del capitale, quello tassando e questo esentando. Infatti all’inizio del 61esimo anno, dopo l’acquisto del vitalizio, il pensionando ha ancora il patrimonio di L. 20.000 sotto forma di credito scalare rimborsabile a rate durante i 13 anni residui della sua vita; ed in quell’anno 61esimo, se egli non vuole diminuire il capitale originario, deve delle 2000 lire di pensione vitalizia consumare solo le 800 lire che al tasso del 4% sono il frutto del capitale; e le altre 1200 lire deve accantonare; perché alla fine dello stesso anno egli avrà soltanto più un credito di 13–1=12 annualità, del valore di L. 18.800, essendogli 1200 già state rimborsate. Poiché reddito guadagnato è ciò che il contribuente può consumare senza intaccare il capitale originario, egli può consumare solo 800 e deve mettere da parte 1200 lire. Nell’anno susseguente, 62esimo dell’età sua, egli nuovamente riceva una annualità di 2000 lire; delle quali soltanto L. 752 sono interesse del capitale di L. 18.800 al 4% e 1248 sono rimborso del capitale. L’imposta tassa le L. 752 di interesse, che sono una ricchezza nuova, che il contribuente potrebbe consumare senza intaccare il capitale originario di L. 18.800 (delle 1200 lire già rimborsate più non ci occupiamo, ché quelle seguiranno la sorte dei capitali messi a frutto, se lo saranno veramente, e saranno tassate sui frutti; ovvero spariranno dalla scena tributaria, se, come è probabilissimo, anzi ammesso per ipotesi, saranno consumate); mentre le L. 1248 non potranno essere evidentemente tassate, in quanto siano rimborso di capitale e non guadagno dell’anno. Così l’imposta andrà via via tassando una parte decrescente dell’annualità vitalizia e precisamente quella che corrisponde all’interesse guadagnato sul capitale ancora da rimborsare. Se invece si parte dal principio «vero» della tassazione del reddito consumato, l’imposta nel primo periodo produttivo percuote soltanto le 800 lire consumate esentando le 200 risparmiate, insieme con i relativi interessi composti scalari, che pure si suppongono risparmiati; mentre nel secondo periodo post produttivo percuote tutte le 2000 lire, perché tutte sono consumate, avendo voluto il lavoratore procacciarsi nella ultima parte della vita alquanta maggiore agiatezza di quella che era possibile col godere soltanto i frutti dei suoi risparmi.
Ben diversamente si comportano i due principii nei due periodi della vita del lavoratore: il principio «falso» tassandolo su tutte le 1000 lire di reddito guadagnato nel periodo produttivo e su 800, 752, 702, ecc., lire soltanto di interesse guadagnato sulle 2000 di pensione nel periodo post produttivo; mentre il principio «vero» lo tassa sulle 800 consumate nel periodo produttivo, esentando le 200 lire risparmiate; e su tutte le 2000 lire di pensione consumate nel periodo post produttivo. Il primo metodo è colpevole di doppia tassazione, poiché, fatta ragione al tempo diverso ed agli interessi decorsi nel frattempo, sarebbe chiaramente equivalente tassare 1000 lire durante 41 anni e poi più nulla nei 13 anni residui, ovvero 800 lire durante 41 anni e poi 2000 lire costanti negli ultimi 13 anni. Il fisco accogliendo il secondo metodo, posponendo cioè il momento dell’esazione dell’imposta perduta nel periodo produttivo al periodo post produttivo così come il contribuente pospone il godimento della sua ricchezza, opera saggissimamente in quanto, senza concedere nessun favore, senza danneggiare sé stesso, anzi preparandosi un’opima messe di tributi col trascorrere del tempo, non pone un ostacolo alla formazione del risparmio. Mentre invece col primo metodo tassa le 800 consumate e le 200 risparmiate nel primo periodo e poi di nuovo, illogicamente, una parte di queste ultime e cioè gli interessi scalarmente decrescenti in L. 800, 752, 702, ecc., nel secondo periodo. Apparentemente il fisco lucra con questa prima maniera di tassazione; in realtà perde alla lunga, perché scoraggia dalla formazione del risparmio con la iniquità della doppia tassazione.
Se il contribuente lavoratore non sia scapolo, ma abbia prole e nel periodo produttivo della sua vita abbia prelevato dalle 1000 lire di suo reddito 200 lire all’anno per l’allevamento, istruzione ed educazione dei suoi figli, il problema, sebbene in apparenza alquanto più complesso, viene alle stesse soluzioni. Anzi il principio «falso» della tassazione del reddito guadagnato può riuscire a peggior meta; poiché, considerando come reddito imponibile tutta la ricchezza consumabile senza intaccare il capitale originario, tassa il padre, Tizio, sulle 1000 lire di suo guadagno, e di nuovo i figli per tutto il guadagno che essi otterranno nella loro vita produttiva sia che essi lo rivolgano a soddisfacimento di bisogni proprii od al sostentamento del loro vecchio genitore. Né il genitore, né i figli posseggono alcun capitale, che essi debbano conservare e per la cui ricostituzione debbano prelevare una quota del reddito guadagnato. Che se anche si opinasse doversi conservare il capitale personale di qualità acquisite il prelievo dovrebbe cominciare solo alla seconda generazione; poiché il padre Tizio che ha cominciato a destinare 200 lire all’anno allo scopo di innalzare i figli suoi nella scala sociale e di metterli in grado di guadagnare un salario maggiore delle sue 1000 lire annue, non era stato, per così dire, capitalizzato dai suoi genitori o lo era stato in misura ben minore. Quindi, non essendo egli un capitale, non può pretendere di dedurre dalle 1000 lire alcuna quota di reintegrazione di un capitale personale inesistente. Ben potranno pretendere tal deduzione i suoi figli, che sono divenuti operai abili e qualificati, mentre il padre era un semplice manovale; ed usi dai loro salari di 1500 o 1600 lire dedurranno le 200 o 300 lire necessarie a ricostituire il capitale investito dal genitore sulla loro testa, e che essi non possono considerare come «guadagno» dovendolo destinare a rimborso di capitale.
Il principio «vero» dell’imposta sul reddito consumato opera diversamente; poiché esenta il padre Tizio sulle 200 lire di risparmio personale investito a pro della seconda generazione, tassando solo le 800 lire da lui consumate; ed i figli tratterà con asprezza, tassandoli su tutte le 1500 o 1600 lire da essi poi guadagnate se tutte le consumeranno a propria gratificazione, rimanendo scapoli o trascurando la figliuolanza e lasciandola di nuovo decadere alla condizione di manovalanza da cui essi erano stati tratti; ovvero li guarderà benignamente, esentandoli sulle 300 o 400 o magari 600 lire che avessero voluto destinare allo scopo di far vieppiù ascendere i loro figli nell’ordine delle dignità sociali.
Sempre dunque i due principii si comportano con grande diversità di effetti economici; perché il principio della tassazione del reddito guadagnato tassa duramente la prima generazione, che si affatica e si sacrifica a pro delle generazioni successive; e con mitezza queste ultime, che godono i frutti dell’opera altrui; mentre il principio della tassazione del reddito consumato risparmia il genitore fecondo e altruista, e tassa i figli egoisti e consumatori, esentandoli solo ove anch’essi imitino o superino le virtù del padre. A parità di risultati finanziari, il principio «falso» inferocisce contro i contribuenti quando piantano foreste, si sacrificano per provvedere alla vecchiaia od ai figli, ed è pieno di dolcezza per quelli che godono i tagli della foresta, consumano passivamente nell’ultima parte della vita le ricchezze accumulate nella prima o traggono vantaggio dall’opera altruista del genitore; il principio «vero» riconosce la convenienza di essere mite quando gli uomini compiono l’opera di rinuncia o di edificazione, ben sicuro di ripigliare il perduto quando gli uomini godranno i frutti dell’opera passata. Solo «contabilmente» i due principii, talvolta, come nel caso della foresta, si equivalgono. L’equivalenza è scritta sulla carta e risulta dal prontuario dei conti fatti. Nel mondo delle realtà, l’uomo si annoia di essere vessato quando intende con sacrificio alle opere dell’avvenire; risente con ira l’imposta che si aggiunge ai suoi sacrifici attuali di lavoro e di capitale per crescerne il costo che non si sa se potrà essere compensato in futuro. Di mala voglia paga i balzelli quando pianta gli arbusti che non sa se diventeranno alberi robusti, o spende per educare figli che non si sa se risponderanno alle sue cure ed alle sue brame, o forma un risparmio che non sa se la morte gli impedirà di godere. L’imposta agisce dunque in questo primo periodo come freno al risparmio, come impedimento alla piantagione delle foreste, come remora alla creazione di nuove giovani genti più colte, più educate. La ricchezza non si forma; e nei periodi della raccolta, quando la materia imponibile dovrebbe essersi fatta ricca e copiosa, la messe è rada e brutta, onde da sé si punisce l’ingordigia del fisco.
PROVA SETTIMA: l’imposta sul reddito dei fabbricati e quella sulle aree fabbricabili.
Le stesse riflessioni fatte sopra inducono a lodare la sapienza dei nostri padri che erano rimasti contenti a colpire di imposta i fabbricati, dopo che questi erano stati costrutti ed erano divenuti fecondi di fitti ai proprietari,[21] ed a biasimare la cortezza di vedute dei moderni legislatori i quali, impazienti di attendere la maturazione degli eventi, si affrettano a tassare le aree fabbricabili quando, tuttora immature, aspettano il momento della loro più economicamente conveniente utilizzazione. La fabbricazione è un’industria la quale procede, scegliendo nel gran novero di aree le quali sono fisicamente fabbricabili quelle economicamente mature alla fabbricazione. Ai limiti estremi dove giungono gli ultimi tentacoli della città moderna, le aree hanno valore puramente determinato dagli usi agricoli possibili in quella regione, supponiamo 1 lira al metro quadrato. A mano a mano che andiamo verso il centro o verso i diversi centri cittadini, operai, industriali, commerciali, bancari, signorili, burocratici, ecc. ecc., il valore dell’area fabbricabile aumenta a 5, 10, 50, 100 persino 1000 o 10.000 lire al metro quadrato, a seconda della possibilità di moltiplicare gli scopi per cui il terreno può essere utilizzato. Un’area che, per la sua situazione lontana dal centro e scomoda per le vie ordinarie di accesso, per la mancanza di fognatura e marciapiedi e la insufficienza di illuminazione, sebbene vicina ad una linea ferroviaria a cui si possa raccordare, può essere utilizzata soltanto per usi agricoli o per stabilimento industriale, potrà valere 5 lire. Se le strade esistono ed esiste anche la illuminazione notturna, potrà sorgere un nucleo di case operaie ed il terreno potrà innalzarsi sino al prezzo di 10 lire; e così via via il prezzo aumenta mentre si moltiplicano i possibili usi concorrenti. Spostandosi questi, si spostano i prezzi continuamente; poiché i prezzi sono l’indice delle variazioni attuali e previste negli usi dell’area. Lo speculatore prevede che fra 14 anni e 1/5 circa una data area situata su un corso già tracciato sul piano regolatore e non ancora costruito potrà essere destinata ad uso di palazzina signorile e varrà allora 100 lire al metro quadrato; ed egli calcola perciò che all’interesse del 5%, compresi gli oneri inerenti all’industria della speculazione edilizia, gli convenga comprare l’area al prezzo attuale di 50 lire e tenerla inutilizzata per 14 anni e 1/5. Facendo così egli lucra l’interesse del 5% corrente, per ipotesi, per quella sorta di impieghi. Se la costruisse prima egli perderebbe, perché l’area, prima dei 14 anni e 1/5, non è ancora diventata matura per la fabbricazione a palazzina, bensì soltanto per un uso inferiore, il quale non consente il pagamento di un prezzo di L. 100. Supponiamo che dopo 10 anni l’area sufficientemente provvista di comodità per abitazioni del ceto medio borghese possa essere venduta a 60 lire per costruirvi sopra una casa di quattro piani. Lo speculatore che ha comprato a 50 lire, – e comprare a minor prezzo gli era impossibile, data la concorrenza di altri speculatori, i quali intuivano la convenienza di aspettare 14 anni e 1/5, – perderebbe, perché dopo 10 anni, l’area gli costa, cogli interessi composti, 81 lire circa. Neppure gli conviene protrarre la costruzione oltre i 14 anni e 1/5, perché dopo 25 anni l’area potrà valere 125 lire ed essere destinata ad uso misto di abitazioni signorili e botteghe, ma a lui sarà costata invece 168.30 lire cogl’interessi composti. Quindi la convenienza di ottenere il lucro massimo consiglia lo speculatore a non anticipare né ritardare oltre i 14 anni e 1/5 la fabbricazione dell’area; perché soltanto in quel caso egli ottiene adeguato guiderdone, il massimo possibile, dalla sua speculazione. Col suo coincide l’interesse della società; essendo chiaramente interesse della società che la fabbricazione delle aree avvenga nel momento in che è massimo il lucro dello speculatore. Che cosa vuol dire infatti che in quel momento, valendo l’area 100 lire, lo speculatore guadagna il massimo? Vuol dire che lo speculatore è riuscito ad indovinare l’uso più adatto per quell’area ed il momento più conveniente della fabbricazione. Le città seguono una logica nella loro espansione; e la città più bella, più attraente, fonte di maggiori godimenti estetici e di maggiori comodità personali è quella in cui si è operata la più sapiente distribuzione dei quartieri destinati ai diversi usi e dove sulla stessa via, nello stesso rione non si toccano villini con giardino, palazzi maestosi, case operaie e stabilimenti fumiganti; e dove invece la varietà architettonica innalza il pregio delle costruzioni simili sapientemente avvicinate. Questa sapienza è in notevole parte opera dei dirigenti la politica municipale dei piani regolatori; ed è altresì opera del meccanismo dei prezzi. E il meccanismo dei prezzi che innalzando il valore di talune aree, deprimendo quello di altre, destina le prime a costruzioni eleganti e signorili e le altre a nere costruzioni industriali; e allontanando le une dalle altre innalza il pregio delle prime e crea comodità di raccordi ferroviari, di stazioni, di transiti rumorosi per i quartieri industriali. Ogni sbaglio nel calcolare le vicende future dei prezzi produce conseguenze perniciose. Ad ognuno di noi è toccato vedere con disgusto su corsi stupendi di costruzioni d’alto valore elevarsi una casetta modesta, che dal trascorrere dal tempo fatta è vieppiù turpe, od i camini di un opificio. Lo sconcio è dovuto alla fretta di chi, non essendo nato speculatore, costrusse troppo presto su un’area che, se era matura per quegli usi inferiori, stava ancora maturando per usi più perfezionati. Lo sconcio dura talvolta per decenni, finché il rialzo del prezzo dell’area non consenta di demolire la vecchia costruzione; e talvolta dura per secoli quando l’incremento di valore non è bastevole a compensare le spese della demolizione e ricostruzione. Se si fosse tardato qualche anno, l’area sarebbe stata utilizzata nella maniera più conveniente e definitiva; definitiva, s’intende, per quel lungo periodo di tempo che la mente umana può concepire.
Già aveva osservato il Fisher (Capital and income, pag. 221) che «talvolta i due usi a cui un terreno può essere destinato differiscono non soltanto nel loro ammontare, ma anche nel tempo del loro cominciare o finire. In una città, per esempio, un’area può essere destinata sia per uso presente d’abitazione o per uso futuro commerciale ed è spesso dubitabile quale dei due usi sia il più pregevole. Nel caso che la città cresca rapidamente può accadere che in certi rioni, quantunque l’uso presente per abitazione sia il più importante, in pochi anni la località cessi di essere desiderabile come residenza e l’area diventi appetibile per affari. In tal caso può “rendere” a tenere l’area del tutto libera da usi presenti, conservandola in disparte finché la città sia cresciuta sino a rendere conveniente la costruzione di un caseggiato commerciale. Se l’area fosse ora coperta da una casa di abitazione, forse la possibilità del suo susseguente uso commerciale sarebbe tolta, o fors’anche il profitto derivante dalla sua conversione a questi usi verrebbe diminuito dal costo della demolizione e dalla perdita del valore della casa d’abitazione. In siffatte circostanze lo speculatore compra e tiene vuota l’area. Il guadagno è previsto da lui sotto l’aspetto di un aumento futuro di valore derivante dall’ampliarsi della città; epperciò compra aree per rivenderle più tardi ad un prezzo superiore. Comunemente si reputa che questo speculatore mantenga le aree fuori d’uso. Egli, tuttavia, pospone solamente il momento dell’uso; e, se egli ha capacità di previsione, non deve essere condannato più del saggio speculatore alla borsa del grano, la cui opera, come è ben noto, tende a conservare la provvista di grano. Lo speculatore tende a fare utilizzare le aree nel miglior modo possibile, scegliendo tra le varie correnti alternative di reddito, che l’area può dare, precisamente quella che possiede il massimo valore presente».
Vediamo ora quale sia l’efficacia dell’imposta. Se essa, come è uso nella maggior parte dei sistemi tributari, colpisce il reddito dell’area quando essa sia stata costrutta, e cioè quando al 14esimo e 1/5 anno frutterà 5 lire nette all’ anno (il metro quadrato all’anno 14esimo e 1/5 varrà appunto 100 lire perché si stimerà fecondo di un reddito annuo di lire 5), essa ridurrà nella stessa sua proporzione il valore dell’area in quel momento futuro e per ripercussione nel momento attuale. L’area fabbricata rendendo, per ogni metro quadrato, L. 5–0,50=L. 4,50 in perpetuo a partire dal 14esimo e 1/5 anno in poi, varrà in quel momento 90 lire, e quindi varrà adesso 45 lire.[22] Lo speculatore, comprando l’area a 45 lire ha sempre convenienza di attendere il momento della maturazione, utilizzando l’area nel miglior modo possibile. Egli non ha interesse per causa dell’imposta ad anticipare la fabbricazione, perché anticipa contemporaneamente l’imposta; né ha interesse a posticipare la fabbricazione per ritardare l’inizio della percussione dell’imposta, perché ritarderebbe, in modo non conveniente per lui, altresì l’inizio della percezione dell’interesse. L’avvento dell’imposta sul reddito realizzato in seguito alla costruzione dell’area lascia lo speculatore perfettamente indifferente, libero di seguire quella via che avrebbe altrimenti scelto ove l’imposta fosse stata assente. Oggi l’area vale, al lordo da imposta, 50 lire perché avrà un valore di 100 lire fra 14 anni e 1/5. Se egli costruisce ora ne ricaverà al massimo[23] un reddito di L. 2.50 annue in perpetuo, su cui l’imposta cadrà pel valsente annuo (all’aliquota del 10%) di 25 centesimi equivalenti alla perdita attuale di 5 lire; se egli attende a costruire al 14mo anno e 1/5, egli avrà un reddito di lire 5 all’anno, e pagherà d’imposta 50 centesimi annui in perpetuo, equivalenti a 10 lire di valore attuale al 14esimo anno e 1/5. Ma poiché 10 lire fra 14 anni e 1/5 equivalgono al saggio del 5% a 5 lire ora, rimane dimostrato che lo speculatore, sia che costruisca ora o tardi a costruire al 14esimo anno e 1/5, paga sempre la medesima imposta e da questa non è indotto a preferire più l’una che l’altra soluzione.
Supponiamo ora che l’imposta sia sul reddito guadagnato e colpisca col 10% l’incremento di valore che l’area ottiene di anno in anno pel progredire della città. Supponiamo, come nel caso precedente, che si preveda possa l’area valere fra 14 anni e 1/5 100 lire al metro quadrato e valga per conseguenza 50 lire al momento iniziale. Supponiamo che sia indifferente costruire oggi ovvero fra 14 anni e 1/5; perché oggi il reddito del metro quadrato di area costrutta[24] è di L. 2.50 e fra 14 anni e 1/5 si prevede di L. 5. Sono le ipotesi fatte prima e sono tutte necessarie per evitare che la decisione di costruire o di ritardare l’edificazione si attribuisca all’imposta mentre è dovuta ad altri elementi. Supponiamo ancora, per semplicità di calcolo, che il valore dell’area cresca regolarmente come cresce la perdita dell’interesse composto al 5%, cosicché in ogni successivo momento sia indifferente, astrazione fatta dall’imposta, costruire o non costruire.
Nel caso che la fabbricazione sia immediata, supponiamo che il valore dell’area più non aumenti; come è ragionevole supporre, poiché per un lunghissimo spazio di tempo, quale la mente umana può concepire, il fitto netto del metro quadrato rimane fisso in lire 2.50; e quindi non si può immaginare un incremento di valore dell’area. In questo caso il «guadagno» sarà eguale al «realizzo» e sarà dato unicamente dall’ammontare dei fitti netti. Possono darsi casi di costruzioni temporanee: tettoie, stabilimenti industriali, ecc.; ed in tal caso la soluzione sarà la risultante della sovrapposizione delle due soluzioni di fabbricazione immediata e posposta.
Veggasi ora come si comporta l’imposta sul reddito guadagnato; e per converso riguardinsi gli effetti già narrati dell’imposta sul reddito realizzato:
|
ANNO |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Imposta sul reddito guadagnato |
|
1) Fabbricazione posposta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valore lordo area |
50 |
52.50 |
55.10 |
57.80 |
60.80 |
63.80 |
67 |
|
Incremento valore |
– |
2.50 |
2.60 |
2.70 |
3 |
3 |
3.20 |
|
Fitti netti |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Imp. 10% su incremento |
– |
0.25 |
0.26 |
0.27 |
0.30 |
0.30 |
0.32 |
|
Imp. 10% su fitti netti |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
2) Fabbricazione immediata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Valore lordo area |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Reddito in fitti netti |
– |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
Imp. 10% su fitti netti |
– |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
Imposta sul reddito realizzato di fitti netti |
|
1) Fabbricazione posposta |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fitti netti |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Imposta 10% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
2) Fabbricazione immediata |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fitti netti |
– |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
Imposta 10% |
– |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|
ANNO
|
Dopo in perpetuo ogni anno
|
Valore attuale delle annualità future d’imposta
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
14
|
|
70.40
|
73.80
|
77.60
|
81.60
|
85.60
|
89.70
|
94.30
|
99
|
100
|
100
|
|
|
3.40
|
3.40
|
3.80
|
4
|
4.10
|
4.10
|
4.60
|
4.70
|
1
|
–
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
5
|
|
|
0.34
|
0.34
|
0.38
|
0.40
|
0.40
|
0.41
|
0.46
|
0.47
|
0.10
|
–
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
–
|
2.50
|
|
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
–
|
0.25
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
5
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
0.50
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
2.50
|
–
|
2.50
|
|
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
0.25
|
–
|
0.25
|
5
|
Mentre l’imposta sul reddito realizzato non perturba il giudizio dello speculatore; perché sia che egli si decida alla fabbricazione immediata, sia che preferisca posporla, sempre paga un tributo equivalente ad un valore attuale di 5 lire; ben diversamente accade se l’imposta percuote il reddito guadagnato. In questo caso, se egli si decide alla fabbricazione immediata, il valore dell’area rimane costante per tutto il periodo, il guadagno è limitato perciò ai fitti netti di 2.50 lire all’anno e l’imposta è uguale ad una serie annua in perpetuo di L. 0.25, equivalente ad un valore attuale di 5 lire. Se egli si decide alla fabbricazione fra 14 anni e 1/5 dovrà pagare: 1) L. 0.50 all’anno in perpetuo sul fitto netto di 5 lire che pure in perpetuo percepirà a partire dal 14esimo anno e 1/5 in poi; le quali L. 0.50 avranno il valore di 10 lire al 14esimo anno e 1/5 e per conseguenza il valore attuale di 5 lire; 2) L. 0.25 nel primo anno di imposta sull’incremento di valore di L. 2.50 verificatosi nello stesso anno, L. 0.16 nel secondo anno, L. 0.27 nel terzo anno e così via, sino a pagare L. 0.10 nel primo quinto del 15esimo anno sull’ultima lira di aumento verificatosi in quei pochi mesi innanzi alla maturazione definitiva dell’area, come si legge nella tabella. Questa serie crescente di imposte equivale, alla tassa di sconto del 5%, ad una somma attuale di L. 3.60, che aggiunte alle altre 5 lire, compongono il peso totale dell’imposta, in caso di fabbricazione posposta, di L. 80.60. Vedesi dunque che il sistema dell’imposta sul reddito realizzato lascia lo speculatore, a parità di altre circostanze, indifferente rispetto al fabbricare presto o tardi, perché con ambedue i metodi paga lire 5 di tributo. Invece il sistema della imposta sul reddito guadagnato gli fa pagare 5 lire soltanto se egli costruisce immediatamente e L. 8.60 se egli ritarda la costruzione, ed agisce perciò come un premio alle fabbricazioni più vicine, ed è causa di tutti i danni che sopra furono descritti e sono visibili ad ogni osservatore. Il mercato immediatamente tien conto di questa opzione lasciata allo speculatore; in questo senso, che costui vede che la stessa area, la quale al momento attuale iniziale ha il medesimo valore lordo (lordo cioè dalla perdita capitalizzata delle imposte future) di 50 lire, ha due possibili valori netti di 50–5=45 lire in caso di fabbricazione immediata e di 50–8,60=41,40 lire in caso di fabbricazione posposta. E cioè il mercato, con la variazione spontanea dei prezzi, addita allo speculatore la convenienza di preferire l’uso per il quale l’area viene al netto maggiormente valorizzata, ossia la fabbricazione immediata.
Peggio accade se, come usa l’imposta italiana sulle aree fabbricabili, il balzello colpisce, con l’aliquota dell’1,2 ovvero 3%, il valore invariabile dichiarato al principio del periodo. Nel caso nostro, supponendo l’imposta dell’1% ed il valore iniziale, dichiarato conformemente al vero, di 50 lire, nel caso di fabbricazione immediata nulla si paga a questo titolo e si paga solo l’imposta sul reddito di fitti netti del fabbricato, il cui equivalente attuale vedemmo essere di 5 lire;[25] mentre nel caso di fabbricazione posposta, oltre alle sovradette 5 lire, si pagherebbero supposta la aliquota anche solo dell’1%, 50 centesimi all’anno per 14 anni e 1/5, equivalenti ad un valore attuale di 5 lire. E cioè 10 lire in tutto, che diventerebbero 15.020, ove l’aliquota dell’imposta sulle aree fabbricabili fosse del 2 o del 3%; ossia il doppio, il triplo od il quadruplo di ciò che si pagherebbe in caso di fabbricazione immediata. Perciò l’imposta italiana sulle aree fabbricabili, che, percuotendo un guadagno presunto ed uniforme per tutte le aree, è un campione peggiorato del tipo d’imposta sul reddito guadagnato, produce l’inconveniente di accelerare la fabbricazione.
Intendasi ancora meglio che cosa s’intende per questo effetto di accelerazione. In parte si accelera il processo complessivo delle costruzioni edilizie di una città, perturbando i rapporti di investimento dei capitali a vantaggio dell’industria edilizia ed a danno delle altre industrie. Il quale effetto, sebbene non ci sia possibile discorrerlo oltre, devesi reputare per sé stesso già dannosissimo. Inoltre si accelera il processo di costruzione delle aree più care in confronto a quelle meno care. Laddove, nell’assenza dell’imposta o con un’imposta sul reddito realizzato, lo speculatore avrebbe avuto interesse ad offrire ogni anno, per la fabbricazione della quantità di case necessaria al consumo le aree economicamente più mature alla fabbricazione, e così le aree centrali per usi di negozio o di uffici, le aree più ridenti per palazzine o case signorili, le aree meno suscettibili di valorizzazione per case operaie, e le aree più scadenti per uso di stabilimento industriale; esistendo invece un’imposta sul reddito guadagnato – ossia sugli incrementi effettivi o presunti di valore delle aree – nasce la convenienza ad offrire, per la fabbricazione dell’identica quantità di case, quelle aree che, lasciate vuote, di anno in anno di valore di una maggiore quantità assoluta, provocando la perdita differenziale di una maggior somma di imposte. Tra due aree, l’una del valore di 50 lire al metro quadrato, che aumenta di valore di L. 2.50 nel primo anno e l’altra di 5 lire che aumenta di valore di L. 0.25, conviene di più, data l’imposta del 10% sul reddito guadagnato, costruire la prima che la seconda. Invero l’imposta del 10% su lire 2.50, riduce il reddito netto a L. 2.25 ossia al 4.50% appena del capitale di 50 lire, che è un reddito minore del saggio corrente d’interesse, onde si perde a non costruire subito. Mentre la stessa imposta su L. 0.25, riduce il reddito netto a L. 0.225, che è ugualmente il 4.50% del capitale di L. 5; cagionando del pari una perdita a non costruire. Siccome però la perdita è nel primo caso di 25 e nell’altro solo di 2.5 centesimi per metro quadrato, siccome nell’un caso la perdita è su un capitale di 50 lire e nell’altro di 5 lire, lo speculatore è indotto a preferire la perdita minore ed a costruire le aree più care. L’effetto dell’imposta non è dunque soltanto di accelerare le costruzioni nel loro complesso; bensì anche di spostarle da luogo a luogo, mutando la maniera con cui le città si formano. Alle città disseminate su vasta zona di terreno, con ampi spazi vuoti intermedi, con divisioni di rioni a seconda degli usi diversi, l’imposta sul reddito guadagnato tende a sostituire le città concentrate su breve spazio, ipertrofiche, senza spazi verdi, senza prati di libero percorso per le genti festanti, porgenti spettacolo orrendo di mistura di case adibite ad usi diversissimi. Il primo tipo di città è la città moderna, la città giardino, la città bella, estetica ed apparentemente di costosa amministrazione. La seconda è la città a cui non più le mura medievali, ma l’imposta modernissima tolgono aria e luce e sole, la città rumorosa, folta di uomini doloranti, e in sostanza costosissima per opere di risanamento, di abbellimento, di sventramento alle venture generazioni. La prima è la città dei veggenti risparmiatori, la seconda è la dimora degli avari sordidi e ciechi.
PROVA OTTAVA: spiegazione della progressività dell’imposta.
Matteo Pescatore, esponendo a carte diciotto e seguenti della sua aurea Logica delle imposte una dottrina della imposta progressiva, alla quale dà fondamento tripartendo i redditi in spesa, risparmio – che sarebbero quote decrescenti del reddito – e potere contributivo – che sarebbe perciò quota crescente del reddito -, chiarisce quale sia la vera ragione della imposta progressiva. A ciò non è mestieri accettare la sua dottrina, la quale afferma doversi destinare al soddisfacimento dei bisogni pubblici tutta quella parte del reddito «guadagnato» che non sia destinato né a spesa privata né a risparmio. Tesi manifestamente male dichiarata, perché condurrebbe lo stato a vivere delle ricchezze abbandonate, quasi res nullius, per essere state giudicate inutili dai proprietari privati; ovvero costringerebbe lo stato a giudicare dell’altezza dei bisogni assoluti e relativi della vita dell’individuo e della famiglia, i quali danno origine alla spesa presente ed al risparmio per future occorrenze; talché l’imposta sarebbe fatta uguale alla quantità di ricchezza residua dopo che un giudizio morale e perciò arbitrario del legislatore abbia ad ognuno fissata la quantità lecita di spesa e di risparmio.
La ragione vera dell’imposta progressiva egli la dà manifestando il pensiero suo intorno all’indole del risparmio, di cui «il bisogno ragionevole» a sua detta,
«non cresce in proporzione uniforme al reddito: la proporzione decresce col progressivo aumento del reddito stesso. Uno possiede la rendita di mille lire: ne avanza ogni anno il quinto (duecento lire), e non ha di che troppo rallegrarsi: un altro gode dell’amplissima rendita di lire cinquantamila, ne avanza ogni anno per titolo di aumento del capitale il solo decimo a rendere sempre più doviziosa e splendida la condizione della famiglia e può di questo progresso annuale pienamente appagarsi».
Or dicasi quando sia corretta questa particolare osservazione (non la complessa dottrina che già respingemmo) del Pescatore e quali siano le illazioni che se ne possano trarre. Essa non dice che di fatto la proporzione del risparmio decresca col crescere del reddito «guadagnato» che è la specie del reddito a cui poneva mente il Pescatore. Direbbe, così asseverando, cosa contraria al vero; essendo probabile che di fatto i piccolissimi e piccoli redditieri poco contributo diano al risparmio capitalistico, sebbene lo diano più grande al risparmio personale; mentre i redditieri medi (operai organizzati, artigiani scelti, commercianti, industriali, professionisti ossia borghesi minuti e medi) assaissimo risparmino in amendue le maniere; e finalmente i grossi redditieri scarsamente aumentino il proprio patrimonio e per lo più soltanto nella generazione da sé assunta a grande ricchezza e in quella immediatamente susseguente. Non però qui si discorre del fatto del risparmio nelle diverse classi sociali, quale potrebbe statisticamente essere determinato; bensì del bisogno ragionevole del risparmio. Del fatto è inutile discorrere, perché come già dicemmo ripetute volte, dei fatti tengono spontaneamente conto i tributi sul reddito consumato e questi soltanto; e, rispetto a cotali eccellentissimi balzelli, è inutile teorizzare di progressività o di proporzionalità; perché essi superano la vessata disputa adeguandosi volta a volta all’uso che ognuno degli uomini contribuenti fa della propria ricchezza a fini pubblici e privati, presenti e futuri. Non fa d’uopo cioè, rispetto ai tributi sul reddito consumato, vanamente disputare se l’imposta debba essere una proporzione costante o variabile del reddito «guadagnato»; poiché supponendola una proporzione costante del «consumato» una brevissima riflessione basta a dimostrare che essa è una variabilissima proporzione del «guadagnato»; né la variazione dipende dall’arbitrio del legislatore, da una sua farneticata legge dell’utilità decrescente della ricchezza o da suoi cervellotici ricettari morali o politici intorno all’impiego del denaro, ma è determinata per ogni individuo da un volontario giudizio di valutazione dei beni presenti e futuri.
L’osservazione del Pescatore risponde invece ad un’esigenza logica del sistema delle imposte sul reddito guadagnato. Queste, che sono turpi teoricamente, debbono cercare di far dimenticare i loro vizi intrinseci appropriandosi, per via di presunzioni, le virtù delle imposte sul reddito consumato. Le quali virtù riassumendosi nella esenzione spontanea di tutte le maniere di risparmio, uopo è che le imposte sul reddito guadagnato quelle eccellentissime scimmiottino cercando di esentare, non potendo il «vero», il risparmio «presunto»; e, fra le altre presunzioni, facendo altresì quella del risparmio in funzione dell’altezza dei redditi. Qui viene in acconcio l’osservazione del Pescatore, la quale dà la legge non del risparmio di fatto, sibbene del risparmio che gli uomini dovrebbero fare se ragionevolmente sapessero valutare i propri bisogni presenti e futuri. Manifestissimo essendo allora che il povero dovrebbe potere risparmiare di più per assicurare la propria vita contro gli infortuni futuri e per migliorare le sorti della figliuolanza; mentre al ricco, il quale già possiede doviziose entrate ed è sicuro di goderle in vecchiaia e trasmetterle ai figli, l’intiero reddito guadagnato appare consumabile nel momento presente. L’imposta progressiva sul reddito guadagnato si può ritenere corretta, non perché sia progressiva, ma perché una parte del reddito guadagnato in verità è «non reddito» che deve essere immune da imposta, in ubbidienza al postulato dell’uguaglianza; sicché, volendo percuotere proporzionatamente l’altra parte ossia il «vero» reddito, è d’uopo colpire progressivamente tutto il reddito guadagnato.
La progressività dell’imposta, dalla dignità di principio teorico, alla quale da taluno si volle farla assurgere, vien fatta decadere all’ufficio modesto di canone tecnico con cui, nel sistema delle imposte sul reddito guadagnato, si tenta imperfettamente di obbedire al postulato dell’uguaglianza e di scansare i doppi d’imposta inerenti alla tassazione del risparmio. «Imperfettamente» si disse; poiché se l’ipotesi che il «ragionevole bisogno» di risparmio diminuisce proporzionalmente col crescere del reddito è l’ottima fra le presunzioni, il «fatto» del risparmio realmente avvenuto eccelle sovra ogni presunzione; sicché l’imposta sul reddito consumato, quale fu sopra delineata, è più perfetta di ogni imposta, sia pure progressiva, sul reddito guadagnato.
Essendo un puro canone tecnico consigliabile per raggiungere lo intento della esenzione del risparmio presunto, è chiarissimo che la progressività del tributo è strettamente limitata dal fine a cui tende; e non potrà la scala della progressione diventare siffattamente rapida da scoraggiare gli agiati ed i ricchi dal compiere opera di risparmio. La differenza tra la proporzione pagata da chi ha reddito piccolo o mediocre e quella soluta da chi ha reddito vistoso non potrà superare la differenza nel rispettivo «ragionevole bisogno» di risparmiare. Il qual bisogno può essere dal legislatore valutato sulla scorta di eventuali dati statistici che potrebbero essere raccolti, tenendo presente che qui non si vuol valutare il fatto, sibbene il dovere del risparmio. Onde opportuna riuscirebbe una ricerca statistica la quale cercasse di rispondere alla domanda: quale risparmio deve essere fatto da ognuno degli appartenenti ad una classe sociale, il quale volesse salire egli medesimo o far salire i propri figli alla classe di reddito immediatamente superiore? Poiché gli uomini vogliono sovratutto emulare i vicini, che stanno su un gradino più elevato della scala sociale e pochissimi dall’imo fondo elevano lo sguardo fino alla sommità degli ordini umani, una ricerca siffatta riuscirebbe statisticamente assai interessante ed utilissima per la finanza, la quale vi troverebbe una base oggettiva per la formulazione di una scala progressiva d’imposta. È probabile che l’imposta così empiricamente trovata sarebbe del tipo di quelle che si dicono proporzionali con detrazione di una quota costante o variabile di reddito; come l’imposta inglese sul reddito che deduce dal reddito, fino alle 700 lire sterline, 160, 150, 120 e 70 lire sterline o l’italiana sui redditi di ricchezza mobile che, tra le 400 e le 800 lire imponibili, deduce 250, 200, 150 e 100 lire. Queste somme sono quelle che, con indagine grossolana, il legislatore ha considerato uguali al risparmio in più che i redditieri piccoli e medi debbono fare rispetto ai redditieri maggiori. Della grossolanità della quale presunzione nessuno dubitò mai; onde si impongono indagini statistiche più raffinate per giungere a più corrette stime.
PROVA NONA: l’imposta sui trasferimenti in generale.
Il concetto dell’esenzione del risparmio giova altresì, chi ben guardi, a spiegare la ragion d’essere delle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito ed oneroso. Suppongasi invero un incremento di 100 milioni nel fabbisogno dello stato; e suppongasi un reddito guadagnato di 10 miliardi di lire all’ anno, di cui 2 destinati a risparmio capitalistico e personale, un capitale nazionale privato di 100 miliardi ed una ricchezza ogni anno trasmessa per causa di morte ed inter vivos di 5 miliardi di lire. I cento milioni bisognevoli possono ugualmente ottenersi sia aumentando dell’1.25% l’aliquota dell’imposta sui 10 miliardi di reddito guadagnato meno i due risparmiati, sia, ove già tutto il reddito guadagnato sia esuberantemente tassato ed il sistema complessivo dei tributi appaia squilibrato ai danni dei redditi di lavoro, decretando un’imposta complementare sul patrimonio dell’1%., sia istituendo un tributo sui trasferimenti, gratuiti ed onerosi, del 2%. Perché la prima imposta, dell’1.25% sul reddito guadagnato, possa essere reputata corretta, occorre, come è dimostrato nella prova prima, classificare i redditi diffalcando dal reddito guadagnato una varia quota di risparmio presunto. La seconda imposta, dell’1 per mille sul patrimonio, esenta automaticamente il risparmio, come è dimostrato nella prova seconda, purché si faccia una presunzione corretta di risparmio per i lavoratori puri e purché si accerti il saggio realmente corrente di interesse per gli impieghi capitalistici puri. La terza maniera d’imposte, del 2% sui trasferimenti, altro non è che una trasformazione della seconda. È evidente invero come sia indifferente tassare coll’1 per mille ogni anno tutti i 100 miliardi che compongono il patrimonio nazionale privato o con il 2 per cento (che è un’aliquota 20 volte superiore a quella dell’1 per mille) la ventesima parte del patrimonio medesimo ossia i 5 miliardi che ogni anno a qualunque titolo si trasferiscono. La preferenza da darsi all’uno od all’altro metodo è puramente accidentale, ossia dipende da circostanze tecniche, come la facilità di esazione, la opportunità di distribuire la pressione tributaria su punti e in momenti diversi, la convenienza di mutar nome alle imposte per renderle più accette ai popoli. La correttezza delle imposte sui trasferimenti, ossia di quelle che in pratica hanno nome di imposte sulle successioni, sulle donazioni, di bollo, di registro di negoziazione di manomorta, ecc., dipende da due condizioni: 1) dall’avere previamente calcolato in modo corretto l’imposta complementare sul patrimonio ossia nel modo che fu dimostrato nella prova seconda. Ove l’imposta patrimoniale non esista, sarà d’uopo calcolare quale ne dovrebbe essere l’aliquota se con essa si dovesse coprire il fabbisogno richiesto. Questa aliquota chiameremo di conto, nella stessa maniera come si chiamavano «di conto» certe monete ideali inesistenti di fatto ed immaginate allo scopo di poter fare i necessari ragguagli tra le monete reali; 2) dall’avere compiuto sufficienti osservazioni statistiche intorno alla frequenza dei trasferimenti delle varie specie di ricchezza e per le varie maniere di titoli per cui la ricchezza si trasferisce. Nell’esempio schematico fatto sopra si suppose che il patrimonio privato totale fosse di 100 miliardi e la ricchezza ogni anno trasferita a qualunque titolo di 5 miliardi; epperciò si dedusse che se l’aliquota dell’imposta annua sul patrimonio era dell’1%, doveva essere del 2% l’imposta, che la surroga, sui trasferimenti. Ma questa è solo una media, la quale praticamente dovrà essere variata a seconda della varietà dei periodi devolutivi. Così, ferma sempre rimanendo l’aliquota «di conto» nell’1%., e supponendo che una data maniera di ricchezza, per esempio i beni immobili rurali, si trasferisca dai genitori ai figli in linea retta ad ogni 30 anni per causa di morte e inoltre ad ogni 50 anni per compra vendita inter vivos, l’imposta di successione in linea retta dovrà essere dell’1.50% e cioè 15 volte l’aliquota di conto, e quella sui trasferimenti a titolo oneroso del 2.50% e cioè 25 volte maggiore dell’aliquota di conto, con ognuna delle quali due imposte si fa così pagare una somma uguale al 0.50 per mille ogni anno; e perciò dell’1 per mille in complesso, eguagliando per tal modo l’aliquota di conto. Se per i beni mobili in generale la frequenza dei trasferimenti a titolo oneroso si accerti statisticamente uguale al giro dei dieci anni, l’aliquota dell’imposta relativa basterà sia 10 volte l’aliquota di conto, ossia dell’1%, se non esista imposta sui trasferimenti a titolo gratuito, o del 0.50% se questa esista.
A regole somiglianti si attengono in generale i legislatori; s’intende con scarti or maggiori or minori dalla norma corretta, imposti dalle urgenze fiscali e dalle insufficienti od erronee osservazioni statistiche. Talvolta riesce fastidioso o impossibile tecnicamente istituire imposte periodiche sui trasferimenti realmente avvenuti; come pei beni posseduti dagli enti di manomorta, per i titoli mobiliari, al portatore o nominativi; e per questi si torna a trasformare l’imposta sui trasferimenti in una imposta patrimoniale, limitata a certi beni, creando le imposte di «surrogazione» dette di manomorta o di negoziazione dei titoli. È un processo a rovescio, durante il quale spesso si commettono nuovi errori, quasi sempre in eccesso, dai legislatori. Tutte queste «commutazioni» però non possono nascondere la ragion d’essere, che è semplicissima delle imposte sui trasferimenti: le quali sono cioè un mezzo tecnico per sovrimporre i redditi provenienti da capitale o da capitale misto a lavoro, nello intento di esentare, come fu dimostrato nella prova seconda, il risparmio. Perché l’intento venga esattamente raggiunto, occorre costruire una vera e propria tabella delle commutazioni, di cui gli elementi sono: il saggio corrente di interesse per gli impieghi capitalistici puri, la quantità probabile di risparmio dei lavoratori puri e la frequenza dei trasferimenti a titolo gratuito dai genitori ai figli in linea retta od a titolo oneroso per le varie maniere di beni. I quali dati primi debbono essere forniti dall’osservazione statistica, alla quale soltanto la finanza andrà debitrice di una corretta applicazione delle imposte sui trasferimenti.
PROVA DECIMA: l’imposta successoria in ispecie.
Dopo la teoria generale dell’imposta sui trasferimenti, è d’uopo esporre le teorie particolari che delle peculiarità di ognuna di esse danno ragione. E prima dell’imposta di successione. Della quale ognuno sa come dessa varii crescendone il peso in funzione del crescere della quota ereditaria e del rallentarsi dei vincoli di parentela epperciò è d’uopo spiegare queste variazioni al disopra dell’aliquota che già chiarimmo dovuta per le successioni in linea retta dai genitori ai figli. A fissare l’aliquota minima dell’imposta successoria provvede la teoria generale svolta nella prova nona; talché necessita soltanto più la spiegazione degli incrementi d’imposta, al disopra di questo minimo, sulle successioni fra collaterali ed estranei. Possiamo quindi distinguere l’imposta successoria in due parti: l’una fissa, la quale grava nella medesima proporzione tutte le successioni, di qualunque somma e in qualsiasi grado; l’altra variabile in funzione della parentela e dell’ammontare della quota ereditaria. Di questa quota variabile si vuole ora cercare la ragion d’essere.
Suppongasi innanzitutto un risparmiatore scapolo, il quale abbia accumulato durante la sua vita un patrimonio di 100.000 lire, su cui non fu mai percosso d’imposta, perché le imposte sul reddito consumato esentarono automaticamente e quelle sul reddito guadagnato seppero con adatte presunzioni rendere immune il suo risparmio annuo. Costui, non avendo figli da sostentare ed educare, può, a parità di altre circostanze, più agevolmente accumulare ricchezze e per necessità deve abbandonarle a parenti più lontani di quanto non facciano i risparmiatori prolifici.[26] Questa è la prima spiegazione della maggior gravezza dell’imposta sui patrimoni vistosi e sulle successioni tra parenti lontani e tra estranei. Gli scapoli invero, vivendo spesso a dozzina in osterie, si sottrassero in vita al debito d’imposta che avrebbero dovuto solvere sulla spesa che pur facevano di casa, di mobilio, di servidorame. Poiché le imposte suntuarie sulle abitazioni, sul mobilio, sulle vetture, sui domestici (capo settimo) lasciano immuni costoro, che consumano in prevalenza frazioni non tassate dei servizi forniti dai grandi alberghi e dalle osterie; e neppure li colpiscono le imposte sul reddito globale guadagnato, le quali in pratica sono commisurate alla spesa che dai contribuenti viene ostentata; talché gli uomini «soli» correttamente debbono pagare in punto di morte quel che in vita riuscirono a non pagare mercé l’astuzia di far loro consumi in maniera invisibili al fisco.[27]
Ma non a questo solo intento giova l’imposta di successione. Come di ogni altro balzello, l’ufficio suo principale è di guardare innanzi: non ai defunti che più non sentono, ma agli eredi che ricevono la ricchezza. Vedemmo (nel capo secondo) come il postulato dell’uguaglianza e il teorema milliano richieggano l’esenzione della ricchezza mentre viene risparmiata e la sua tassazione quando sia consumata, tuttoché in questo istante del consumo abbia nome di capitale e non di reddito. A ciò riescono le imposte sul reddito consumato, perché lo stato percuote la ricchezza destinata all’acquisto di tabacco o di casa o di vetture o di servizi personali senza impacciarsi a cercare se l’acquisto sia fatto col reddito o col capitale. Nelle più imperfette imposte sul reddito guadagnato la immunità del capitale esistente all’inizio del periodo finanziario si impone invece allo scopo di evitare se non le doppie almeno le triple o quadruple tassazioni; e soltanto la logica del teorema milliano può consigliare al legislatore di fare uno strappo alla logica del sistema della tassazione del reddito guadagnato quando si possa «presumere» che il cosidetto «capitale» il quale, come tale, è intangibile dalle imposte sul reddito guadagnato, è destinato ad essere consumato o dilapidato. Qui è la ragion d’essere vera delle variazioni nell’aliquota dell’imposta successoria. L’esperienza insegna che ben difficilmente la sostanza formata coll’assiduo risparmio dal fondatore di una dinastia famigliare si conserva intatta attraverso le successive generazioni. Rarissime sono, nel novero delle famiglie ricche, quelle la cui ricchezza rimonta ad un secolo; e sono eccezioni stravaganti quelle famiglie che da più secoli conservano le ricchezze avite. Ciò che il padre ha accumulato, il figlio sa forse conservare ed i nipoti probabilmente dilapidano; questa è verità universale che i proverbi popolari in lor sapienza insegnano e che di indagini statistiche abbisogna non per essere provata, ma unicamente perché se ne arricchisca la esemplificazione.[28] Su questa verità poggia l’edificio variabile dell’imposta successoria; la quale in taluni paesi esenta e dappertutto tassa mitemente le eredità in linea retta, perché il legislatore correttamente prevede che i figli di solito conserveranno la sostanza paterna, e via via più fortemente tassa gli eredi a mano a mano che si rallenta il vincolo della parentela, perché prevede che le sostanze, inopinatamente e gratuitamente ricevute, sempre più di frequente andranno disperse. Onde il fisco, il quale non sa accertare direttamente il fatto del consumo della ricchezza formata in periodi finanziarii trascorsi (capo terzo), si affretta ad esigere la parte sua innanzi che la sostanza venga in possesso dei probabili dilapidatori.
Non osa in verità il legislatore apertamente dichiarare cotal suo giudizio poco benigno verso gli eredi; e va cianciando di giustizia tributaria la quale esige che, se il lavoratore viene tassato col 10% sul frutto del suo lavoro, anche l’erede neghittoso venga d’altrettanto percosso sul frutto gratuito della eredità. Noi però sappiamo che questi son discorsi vani; e che il postulato dell’uguaglianza esige che il lavoratore venga tassato solo sulla parte del frutto del suo lavoro che egli consuma, esentandone la parte destinata a risparmio capitalistico e personale; ed esige pure – sempre, s’intende, per la sola quota variabile dell’imposta successoria, ché per la quota fissa l’uguaglianza tributaria esige la tassazione su tutto l’ammontare della quota ereditaria, sia che l’erede la consumi o la risparmi, e ciò, come si discorse nella prova nona, appunto allo scopo di esentare il risparmio che si presume contemporaneamente compiuto dai redditi provenienti da lavoro e, in minor grado, da lavoro misto a capitale – che l’erede venga tassato sulla quota dell’eredità ricevuta che per avventura egli consumi ed esentato su quella che egli conserva, poiché la tassazione di quest’ultima farebbe per lui doppio con la tassazione dei frutti che egli ne ricaverà negli anni avvenire. Dire, altrimenti, che anche la quota «conservata» dell’eredità deve essere tassata per evitare una esenzione scorretta a suo favore, equivale a sostenere l’assurda tesi che l’erede, ricevendo 100.000 lire in eredità e limitandosi a consumarne il frutto annuo di 5.000 lire, abbia ricevuto due cose; dapprima le 100.000 lire e in secondo luogo una serie infinita di annualità di 5.000 lire l’una, sicché tassando queste ultime, non si tassino le prime 100.000 lire; il che ancora equivale a dire che ogni eredità di 100.000 lire in realtà è uguale a 200.000 lire ed ognuna di 1 milione può essere reputata uguale a 2 milioni: grottesca illusione, sebbene utilissima a persuadere i popoli a pagar balzelli.
Cianciano altresì i sicofanti della giustizia tributaria di certa ripugnanza maggiore che avrebbero i figli a pagare il tributo, perché essi si consideravano già quasi padroni della sostanza paterna; mentre agli eredi lontani l’eredità giunge inaspettata ed affatto gratuita onde sopportano più agevolmente le pretese del fisco. La quale osservazione è praticamente importante ed il legislatore ne deve tener conto, essendo ufficio suo, dopo aver soddisfatto al postulato dell’uguaglianza, di congegnare siffattamente le imposte da suscitare la minor repugnanza morale, sebbene sia utilissima la reazione attiva, tra i contribuenti. Ma non è la ragion delle variazioni dell’imposta. La quale vuolsi, come sovra si disse, cercare per l’appunto nel consueto bisogno, imposto dall’imperfezione dei tributi sul reddito guadagnato, di sostituire all’accertamento dei fatti veri – consumo di ricchezze precedentemente risparmiate – la presunzione di fatti probabili: ed essendo più probabile la dilapidazione della ricchezza ereditata da parte degli eredi lontani che dei prossimi viene senz’altro chiarita la mitezza dell’imposta successoria rispetto a quest’ultimi e la gravezza rispetto ai primi. La varia probabilità della dilapidazione giova altresì a spiegare l’ilarità maggiore dei parenti lontani e la loro più ostentata indifferenza ai colpi del fisco. Poiché il figlio o parente prossimo, il quale vuol conservare la ricchezza paterna, che già considerava quasi sua propria, è fatto iracondo dall’imposta, la quale lo colpisce in un momento in che egli è addolorato per la morte dell’autore dei suoi giorni ed è astretto a gravi spese di ultima malattia e di funerali; mentre il parente lontano, che già s’appresta a dar fondo all’improvvisa fortuna, guarda con più benigno occhio lo stato e, reputandolo sozio nell’auspicata distruzione, quasi gli è grato di avere pure a lui lasciato qualcosa da distruggere.
Tutte quante codeste considerazioni, non è inutile ripeterlo, sebbene l’avvertenza sia oramai stata fatta le infinite volte, valgono per le classi di contribuenti e non per gli individui singoli; ben potendo darsi figli dilapidatori e cugini lontani conservatori della eredità ricevuta. Ma è proprio della ria natura delle imposte sul reddito guadagnato di dover procedere per via di larghe e spesso erronee approssimazioni; ed a tale esigenza non può sottrarsi neppure l’imposta successoria. Prima di interromperne il discorso, vuolsi aggiungere che la spiegazione ora profferita chiarisce ancora altri punti; e cioè:
1) la maggiore tassazione, in taluni paesi consentita, degli eredi giovani in confronto ai vecchi, essendo a costoro, per la debolezza dell’età e la brevità del tempo, negato di potere consumare il patrimonio ereditato così come lo possono gli eredi più giovani. Non al godimento dei frutti pose mente il legislatore, ché questi sono già colpiti ogni anno, finché dura la vita, con le vane maniere di imposte sul reddito; ma allo scialacquo del patrimonio medesimo, a cui i vecchi, fatti dalla grave età austeri, sono impotenti, mentre ché ne sono capacissimi i giovani; 2) la minorazione d’imposta talvolta concessa quando lo stesso patrimonio successivamente passa, in breve lasso di tempo, per parecchie mani. La brevità del tempo decorso consente al fisco di persuadersi, senza possibilità di artefatte prove, che egli aveva avuto torto nel presumere nel primo erede una capacità di dilapidazione, che, seppure esisteva, non ebbe tempo a manifestarsi; talché, avendo già esatto sul primo erede pochi mesi innanzi l’imposta sul consumo presunto, più non ha il fisco coraggio a pretenderla una seconda volta; e, quasi supponendo che la precedente trasmissione non abbia avuto luogo, dà credito al secondo erede pel balzello dianzi pagato; 3) l’aumento d’imposta onde alcuni legislatori moderni gravano i figli unici in confronto della prole numerosa; essendo manifesto, nota il Gini a carte 44 del già mentovato studio, che «una numerosa famiglia educa potentemente e genitori e figli ad un elevato spirito di solidarietà, di laboriosità e di disciplina» ed essendo noto «che i padri di numerosa prole sono, nella generalità dei casi, gli operai più attivi e tranquilli e che i figli unici molto spesso scialacquano nell’ozio e nel vizio i patrimoni ereditati».
Finalmente la teoria ora esposta pone i limiti al di là dei quali non potrà andare l’imposta successoria, ove si voglia osservare il postulato dell’uguaglianza. Suppongasi invero che la dilapidazione sia massima da parte dei parenti oltre il sesto grado e degli estranei quando abbiano ricevuto un’eredità superiore al milione di lire,[29] giungendo, per ipotesi abbondante, fino al totale della somma ereditata. Quale dovrà essere in questo caso l’aliquota della parte variabile dell’imposta successoria? Evidentemente dovrà essere uguale all’aliquota che grava la parte che si presume consumata di ogni altro reddito guadagnato. Se le imposte sulla parte imponibile, supposta consumata, dei redditi fondiari, edilizi, mobiliari sono del 20%, similmente dovrà essere del 20% l’aliquota della parte variabile dell’imposta successoria su questi eredi lontani e massimi; e dovrà calare al 10 o salire al 30% se ugualmente s’abbassano o rialzano le imposte sul reddito. Operare altrimenti vorrebbe dire tassare nell’un caso con 20 centesimi e nell’altro con 30 centesimi la lira consumata; alla quale disuguaglianza nessun fondamento plausibile è consentito dare. Al disotto di questo massimo, che la esperienza insegna a variare in ogni paese, l’aliquota della parte variabile della imposta successoria deve scendere o, rimanendo immutata l’aliquota, deve ridursi la quota imponibile del patrimonio ereditato, a mano a mano che diminuisce, collo stringersi dei legami di parentela e col diminuire della somma ereditata, la probabilità di dilapidazione, fino a ridursi a zero o quasi per le successioni minime in linea retta tra genitori e figli, per cui la dilapidazione si può supporre nulla o quasi nulla. Per queste minime successioni in linea retta sussisterà soltanto la parte fissa dell’imposta successoria; mentre per le successioni più vistose, pure in linea retta, e per quelle tra collaterali od estranei alla parte fissa si aggiungerà la parte variabile dell’imposta.
Ben si sa che a cosiffatti infrangibili e non arbitrari limiti della imposta successoria e dei suoi varii gradi non s’attengono spesso i legislatori; i quali spingono talvolta l’imposta, medesimamente per le parentele vicine e lontane, ad altezze distruttrici d’ogni spinta alla formazione ed alla conservazione del capitale. Ma si sa anche che l’opera dei legislatori frenetici di età e smaniosi di favore popolare appartiene non alla teoria pura dell’imposta; bensì a quelle impure della illusione tributaria e della pubblica espropriazione, senza indennità, della fortuna privata.
PROVA UNDICESIMA: l’imposta sui trasferimenti a titolo oneroso pure in ispecie.
Le variazioni delle imposte di bollo e registro sui trasferimenti a titolo oneroso al disopra del minimo fisso che, per ogni categoria di beni trasferiti, dovrebbe essere dal legislatore determinato in funzione del periodo di tempo intercedente in media tra l’un trasferimento ed il successivo – onde la parte fissa dell’imposta qui diventa variabile, il periodo devolutivo non dipendendo più dalla morte, che è involontaria, ma dalla volontà di vendere dei possessori, la quale muta per ogni specie di beni – sono ribelli ad ogni norma logica, dipendendo dal capriccio del legislatore, il quale si è sbizzarrito, forse più che in ogni altra maniera di tributi, a mutare all’infinito le aliquote, frenato unicamente dalla paura di esasperare troppo i contribuenti e guidato soltanto dalla norma cara ad ogni monopolista, la quale insegna a gravar la mano sovratutto su coloro che paiono meno recalcitranti o più capaci a sopportare il peso dell’imposta.
Ma fra le circostanze che agevolano il compito del fisco, ve ne è una, la quale fu messa in luce dal Puviani e merita di essere ricordata, come quella che aggiunge nuovo rinforzo alla teoria qui sostenuta, secondo la quale le imposte sui trasferimenti mirano a tassare i consumi e ad esentare i risparmi e unicamente sono tollerabili in quanto raggiungano questo intento, diventando intollerabili quando, come purtroppo di fatto spesso accade, ottengono, per la mala loro conformazione, l’effetto opposto. Nota invero il Puviani che le imposte sui trasferimenti percuotono il contribuente nel momento in che, per la contentezza del conchiuso contratto, egli è più propenso a spendere:
«Molti subordinano il procurarsi certi piaceri, il fare certi regali alla conchiusione di certi contratti. Per modo che il guadagno [del contratto] in senso stretto può essere più o meno intaccato dagli effetti della spinta dispendiativa, che s’accompagna alla gioia, derivante dal buon affare conchiuso e che si estrinseca spesso in banchetti, gozzoviglie tra contraenti e sensali. Anzi quel guadagno talora viene distrutto intieramente o non basta neppure per le nuove spese, che esso provoca» (Puviani, Teoria della illusione finanziaria, pag. 145).
Ed altrove, amaramente, commentando l’incidenza delle imposte di trasferimento sui venditori invece che sui compratori:
«Una moltitudine di vittime sul terreno economico, che non avrebbe mai potuto essere colpita d’imposta in ragione dei suoi lucri, dell’importanza del suo avere, fu taglieggiata nei momenti delle sue maggiori strettezze, dei suoi maggiori sacrifizi. Si colpì senza riguardo la ricchezza che si trasferiva, il poderetto, la casupola, la vendita dell’ultimo residuo della propria sostanza, fosse pure determinata dal bisogno di mantenere un infermo, i beni strappati dal creditore all’asta pubblica per un prezzo vile. Tutta una classe di deboli proprietari in dissoluzione si rassegna alle feroci esigenze fiscali, non tanto per la cosciente impossibilità di resistere ad esse, quanto perché, nello sfacelo delle sue sostanze, nell’impeto della sua rovina, considera la frazione di ricchezza strappatale
dall’imposta come un amminicolo, un accessorio, i pochi stecchi aggiunti al
pesante fardello» (Puviani, op. cit., pag. 194).
Osservazioni suggestive, come tutte quelle di questo scrittore, a torto negletto; le quali provano che le imposte sui trasferimenti onerosi sono aiutate nella loro pratica applicazione da circostanze favorevoli allo spendere, qualunque siano i motivi, lieti o dolorosi, dello spendere. Da ciò non si deduca leggermente che queste siano le ottime tra le imposte; essendo ferma opinione di chi scrive che esse siano, di questo gruppo dei balzelli sui trasferimenti, le pessime, appena comparabili alle imposte sui consumi risparmio, di che si discorse al capo settimo, per i loro dannosi effetti sulla circolazione della ricchezza e specialmente per gli ostacoli frapposti al trapasso dei beni a pro’ delle persone meglio adatte a trarne vantaggio. Se invero dal punto di vista contabile è indifferente, come si dimostrò nella prova nona, pagare l’1 per mille ogni anno su tutto il patrimonio privato esistente ovvero il 2% della ricchezza ogni anno trasferita a titolo oneroso, ove si supponga che per tal modo si trasferisca annualmente la ventesima parte della ricchezza esistente, non è indifferente dal punto di vista economico. Poiché l’imposta «annua» dell’1 per mille dovendo essere ad ogni modo pagata, sia che si verifichino oppure no i trasferimenti della ricchezza colpita, non ostacola la circolazione dei beni; mentre l’imposta del 2%, percetta «se» e «quando» i trasferimenti di fatto avvengano, ha per effetto di allontanare il momento dei trasferimenti. Ora tutto ciò che rallenta la circolazione della ricchezza ed impedisce che questa passi dai meno capaci ai più capaci di utilizzarla è dannoso economicamente. Qui si vede la differenza grande tra le imposte di successione e quelle sui trasferimenti a titolo oneroso; le prime, tuttoché periodiche, non ostacolando la circolazione della ricchezza, perché la morte, nonostante la minaccia incombente dell’imposta, resta tuttavia indeprecabile; mentre le seconde, potendosi rinviare o non compiere la vendita, sono un freno alle vendite medesime. Perciò ben fanno i legislatori i quali hanno abolito le imposte percette in occasione dei trasferimenti trasformandole in imposte annue di surrogazione sulle azioni ed obbligazioni; lieve ed apparentemente insignificante mutazione, la quale invece ha contribuito assaissimo alla facile negoziabilità ed alla popolarità dei titoli mobiliari, sottraendo capitali all’agricoltura ed all’industria edilizia e spingendoli verso le industrie manifatturiere e commerciali, che più facilmente si giovano delle azioni e delle obbligazioni a raccogliere il capitale ad esse bisognevole. Questo non vide il Puviani: che cioè il biasimo, di cui son meritevoli le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso, non attiene alla sostanza loro, che è favorevole alla esenzione del risparmio ma alla loro forma tecnica consueta, che è nimicissima all’accorrere del risparmio verso gli impieghi più produttivi.
PROVA DODICESIMA: il consolidamento dell’imposta.
Un’altra maniera di esentare il risparmio è il consolidamento dell’imposta pagata dal contribuente. Chiamasi per noi consolidamento quel fatto per cui, crescendo i redditi del contribuente col trascorrere del tempo da 1000, a 1100, a 1200, a 1300, a 1400 ed a 1500 lire, l’imposta tuttora percuote le originarie 1000 lire, non ponendo mente agli incrementi ulteriori. Il fatto talvolta è voluto dal legislatore; e più spesso accade in spregio della sua volontà. È voluto quando si dichiarano esenti i redditi dei miglioramenti agricoli dall’imposta fondiaria per tutto il tempo che ancor rimane da trascorrere fino alla nuova censuazione catastale, che la legge comanda abbia luogo al compiersi dei trent’anni dalla prima attivazione del catasto e la storia insegna avvenire a secoli di distanza; o quando espressamente si dichiarano esenti per 5 o 10 anni dall’imposta sui fabbricati o di ricchezza mobile i redditi dei nuovi opifici o degli ampliamenti dei vecchi opifici sorti in provincie prima sfornite o scarsamente dotate di industrie. Più spesso il consolidamento avviene contro la volontà del legislatore, il quale vorrebbe che i redditi delle industrie, dei commerci e delle professioni fossero riveduti ad ogni quattro anni, in guisa che ognora gli accertamenti rispondano a verità; mentre invece le relazioni annue dei direttori generali delle imposte dirette son piene di querimonie intorno alla difficoltà, statisticamente provata, di mutare la cifra originariamente convenuta quando per la prima volta il contribuente fu assoggettato al balzello mobiliare. È invero provato dall’esperienza che i contribuenti singoli, non i collettivi tassati sulla base dei bilanci resi di pubblica ragione, con ogni lor possa riluttano ad un aumento del reddito imponibile, più che alla prima loro imposizione; sembrando ad essi che la cifra d’imposta, una volta fissata per concordato o per sentenza della magistratura competente, debba essere intangibile, comunque cresca il reddito. Né le variazioni, in aumento sono convenute in rapporto ai redditi cresciuti, sibbene all’ammontare originario del tributo: di un decimo, di un quarto, di una metà di questo, che si assume a regola della futura condotta tributaria. Talché il gettito dell’imposta in talune categorie si irrigidisce, si consolida, crescendo soltanto per l’aggiungersi di nuove imprese, e non per l’incremento delle vecchie. Il fatto è visibilissimo pure nella imposta sui fabbricati, per la quale in Italia, dopo il 1889, non fu più possibile alcuna revisione generale; ed il provento dell’imposta crebbe quasi soltanto per il sorgere di nuovi e per la ricostruzione o per l’ampliamento dei vecchi fabbricati, non per una nuova migliore valutazione del reddito dei vecchi fabbricati, il quale rimase immutato. A questo consolidamento eslege si acconcia alfine, dopo avervi riluttato a lungo, l’amministrazione fiscale, paurosa di commovimenti popolari; tenendosi paga di rompere qua e là le resistenze opposte dai contribuenti in quei luoghi dove l’assalto possa essere condotto alla spicciolata contro gli individui, senza suscitare l’ira della intera loro classe.
Questo il fatto del consolidamento od irrigidimento dell’imposta. Di cui le spiegazioni sono parecchie: le difficoltà tecniche di ripetere ad ogni anno gli accertamenti, il desiderio del legislatore di promuovere il sorgere di industrie in paesi di esse deserti, la strapotenza di talune classi sociali, ecc. Ma un effetto di quel fatto è chiarissimo in molti casi, sebbene non sia generale: l’esenzione dei frutti del risparmio investito nei miglioramenti agricoli, nella creazione di imprese nuove, nello ampliamento delle imprese esistenti. Notammo già nel capo secondo che il teorema milliano può attuarsi in due modi: o coll’esenzione del risparmio o con quello dei suoi frutti. Sebbene si sia osservato allora essere più conveniente, per motivi inutili a discorrere in questa memoria, la prima maniera d’esenzione, talvolta accade che il legislatore prescelga la seconda via, esentando i frutti del risparmio. L’esenzione teoricamente dovrebbe durare finché durano i frutti medesimi; in via di approssimazione si concede per dichiarazione legislativa o di fatto, mercé il consolidamento dell’imposta, l’esenzione solo per un «lungo» periodo di tempo. A noi basti d’aver constatato il fatto, che assai bene s’inquadra nel novero delle prove con cui si volle dimostrare che le imposte sul reddito guadagnato «tendono», sel sappia oppur no il legislatore, a diventare imposte sul reddito consumato.
PROVA TREDICESIMA: l’esenzione dell’aumento di valore non realizzato dei titoli di portafoglio e degli utili mandati a riserva.
Giurisprudenza e dottrina concordi ritengono in Italia che l’aumento di valore verificatosi durante un esercizio finanziario nei titoli posseduti da società anonime ed in accomandita e da altri istituti, come casse di risparmio, monti di pietà, ecc., non debba essere sottoposto a tassazione, finché esso non sia realizzato con la vendita dei titoli. E la dottrina prevalente consiglia in Italia al legislatore di mutare la legge in guisa da rendere immuni da imposta gli utili mandati a riserva, finché le riserve non siano ripartite tra gli azionisti.
Amendue queste immunità ripugnano profondamente al principio informatore delle imposte sul reddito guadagnato, – di cui la nostra imposta di ricchezza mobile per mille segni dovrebbe essere, quando il reddito sia stato ridotto al dovuto numero di quarantesimi consumabili, il campione immacolato, – volendo quel principio che sia imponibile la massa netta di ricchezza acquistata da una persona fisica in un determinato esercizio finanziario e consumabile senza variare la massa di ricchezza posseduta all’inizio dell’anno (capo primo, in fine). Sia una società anonima, dal capitale versato di 1.000.000 di lire, diviso in 1000 azioni da 1000 lire ciascuna. Durante il primo anno finanziario d’esercizio i titoli, in che tutto o parte del capitale sociale era stato investito, aumentano di valore di 50.000 lire in confronto al prezzo d’acquisto scritto in bilancio; e durante il medesimo anno dal guadagno d’esercizio vengono prelevate 10.000 lire, le quali sono collocate a riserva. La giurisprudenza ammette che le prime 50.000 lire siano immuni da imposta, finché i titoli non siano venduti e la dottrina invoca dal legislatore che anche le altre 10.000 lire siano fatte salve dalla percossa tributaria. Amendue queste pretese ripugnano al principio della tassazione del reddito guadagnato. Infatti l’azionista, possessore dell’azione, all’1 gennaio aveva un’azione del valore di 1000 lire e nulla più; mentre al 31 dicembre egli ha un’azione che sul mercato viene correntemente stimata e contrattata ad un prezzo uguale ad una millesima parte del milione di lire versate, ed insieme delle 50.000 lire di cui è cresciuto il valore dei titoli di portafoglio, e delle 10.000 lire mandate a riserva, ossia al prezzo di ossia di 1060 lire. Se l’azionista volesse potrebbe vendere la sua azione per 1.060 lire, il che vuol dire che egli, volendo, potrebbe consumare le 60 lire senza intaccare il capitale originario all’inizio dell’anno, che era di sole 1000 lire; il che ancora significa che le 60 lire sono reddito guadagnato imponibile.
L’averle dichiarate o il volerle dichiarare invece immuni da tassazione è una insigne vittoria del principio della tassazione del reddito consumato, che per tal modo si insinua nella rocca forte avversaria ed a pezzo a pezzo la smantella. Infatti, secondo quest’altro principio, le 60 lire non sono reddito, non essendo consumate dall’azionista; anzi sono risparmio a cui «espressamente» l’azionista rinunzia, consentendo che i titoli non siano venduti, come si dovrebbe fare per distribuire il guadagno sul prezzo di acquisto e che gli utili d’esercizio siano tenuti nella cassa sociale; epperciò debbono, per la virtù del postulato dell’eguaglianza e del teorema milliano essere immuni da imposta.
Vero è che lo smantellamento della fortezza avversaria non è compiuto; se il principio fosse logicamente accolto in tutte le sue conseguenze, non ci si dovrebbe contentare dell’esenzione dei risparmi «certi» operati collettivamente dall’azionista a mezzo dello strumento «società anonima»; ma si dovrebbe andare sino all’esenzione dei risparmi che singolarmente l’azionista operi inoltre sui dividendi distribuiti dalla società. Se nell’anno menzionato, la società non solo ha «guadagnato» le 50 lire di maggior valore dei titoli di portafoglio e le 10 lire di utili mandati a riserva, ma ha distribuito ancora 55 lire di dividendo agli azionisti, ragion vorrebbe che si esentassero dall’imposta, oltre le 50 e le 10 lire sovraricordate, anche quella parte delle 55 lire di dividendo che i singoli azionisti risparmiassero. Il che teoricamente è verità inoppugnabile; ma noi sappiamo già, per le considerazioni esposte nel capo terzo, come sia impossibile conoscere il risparmio effettivamente compiuto dai contribuenti e come, se si ammettesse l’esenzione «generica» del risparmio, le frodi fiscali diventerebbero incoercibili. E già sappiamo anche come, per queste potentissime ragioni di fatto, nel gruppo delle imposte sul reddito guadagnato sia d’uopo esentare il risparmio «presunto» e non l’«effettivo». Siffatta necessità ferrea di non esentare il risparmio «effettivo» vien meno però quando in modo «certo» si conosca il medesimo effettivo risparmio e sia esclusa la possibilità delle frodi; del che già demmo un esempio ricordando nella prova quarta l’esenzione concessa ai premi di assicurazione, nella prova quinta l’immunità invocata per le foreste nel periodo della loro formazione, nella prova settima la sapienza degli antichi legislatori ripugnanti a tassare l’incremento di valore delle aree fabbricabili. In tutti questi casi è esclusa la possibilità di frodi e perciò l’immunità al risparmio effettivo è scevra di pericoli. Poiché non si può immaginare che gli azionisti di una società anonima abbiano in animo di frodare il fisco rinunciando a realizzare il maggior valore dei titoli di portafoglio o mandando talune somme guadagnate nell’anno a riserva e poiché, se anche volessero, ogni frode sarebbe ad essi preclusa per la impossibilità di distribuire in avvenire quei risparmi agli azionisti senza solvere il debito tributario, così appare legittima la pretesa della dottrina di volere l’immunità dall’imposta nei casi ora discorsi. Certissimamente la logica pura imporrebbe di non contentarsi di così modesta conquista e di proclamare la immunità benanco del risparmio fatto dagli azionisti sul dividendo distribuito. Alla quale maggiore vittoria si giungerà nel giorno in che tutti i contribuenti siano fatti uomini economici perfetti e giusti estimatori dei servizi pubblici e sia scomparsa la trista gente dei frodatori da un lato e degli espropriatori pubblici dall’altro.[30]
PROVA QUATTORDICESIMA: prime linee di una teoria degli stati cuscinetto e della concorrenza tributaria tra gli stati.
Talvolta, pur ripugnandovi la lettera della legge inspirata al principio corrente della tassazione del reddito guadagnato, l’arte del contribuente ha scoperto una falla minima nel dettato del legislatore e si industria a farla diventare grandissima. Uno degli esempi più interessanti e più importanti in tema di esenzione del risparmio ha tratto alla territorialità dell’imposta. Talvolta l’imposta, avendo carattere o in tutto o prevalentemente reale, limita la sua azione al territorio dello stato; come la nostra imposta di ricchezza mobile la quale espressamente percuote soltanto i redditi che hanno origine da fonte nazionale. In questo caso il contribuente può scegliere all’estero impieghi capitalistici immuni da imposta e sui frutti di essi sarà medesimamente immune in Italia sia che quei frutti consumi o risparmi; onde l’esempio non potrebbe addursi a prova della teoria che vuole esente il risparmio. Ma, altrove, l’imposta nazionale colpisce anche i redditi provenienti da fonti straniere; come accade in Inghilterra per la imposta sul reddito. Con questa avvertenza però che quei redditi, per diventare tassabili, debbono essere, almeno formalmente, importati dall’estero o dalle colonie sul territorio britannico. Così si considerano tassabili il reddito di una miniera australiana o sud africana, che il proprietario esiga, per mezzo di una banca, nella Gran Bretagna; o i dividendi di una società anonima, avente sede in Londra, che la società paghi in Gran Bretagna, a sudditi inglesi od a stranieri residenti sul territorio britannico, tuttoché ottenuti all’estero o nelle colonie. Da questa affermazione positiva di tassabilità subito i contribuenti trassero la logica dedizione negativa di intassabilità nel caso che i redditi di fonti straniere o coloniali non siano importati nel territorio britannico. L’inglese che su parte dei suoi redditi non vuole pagare tributo al governo del suo paese può dunque agevolmente riuscirvi. Basta all’uopo che egli acquisti titoli esteri o coloniali, di cui i tagliandi di interessi o dividendi non siano pagati nella sua patria, o si interessi in terreni o case o miniere o foreste o stabilimenti industriali situati all’estero o nelle colonie e con cura somma eviti che glie ne siano inviati i redditi in Inghilterra. Le magistrature britanniche hanno giudicato che, non essendo i redditi introdotti sul territorio patrio, non sono imponibili. È sorta così la consuetudine del rolling up, ossia del lasciare accumulare altrove gli interessi degli impieghi fatti fuori della madrepatria, allo scopo di sfuggire all’imposta nazionale sul reddito. Gli interessi, i frutti si aggiungono al capitale per anni ed anni ingrossandolo a dismisura, né mai possono essere colpiti da imposta. Ad agevolare l’intento al contribuente inglese si adoprano appositi istituti bancari, i quali si incaricano di collocare capitali all’estero e nelle colonie, di amministrarli e di reimpiegare i frutti, secondo le norme direttive volute dal contribuente, senza che di ciò nella Gran Bretagna si abbia altrimenti notizia che per i fogli di conto periodicamente inviati all’interessato. Vero è che il fisco inglese non abbandona del tutto la preda, che per qualche tempo gli è sfuggita. Se un capitale di 100.000 lire è impiegato in una colonia al 5%, diventando in 14 anni e 1/5 uguale a 200.000 lire; e se alla fine di questo tempo il proprietario di esso lo vuole importare in Inghilterra, in quell’istante il fisco si risveglia e considera reddito tutta la differenza tra le 100.000 lire esportate e le 200.000 reimportate e questa differenza colpisce con l’imposta sul reddito. Dal che si vede quale sia il significato della «importazione» del reddito nella madrepatria: essendo essa fatta uguale al «consumo» o «consumabilità» del reddito. Finché il reddito è «rolled up» ossia è risparmiato od accumulato all’estero da un inglese o straniero residente nella Gran Bretagna, si ha la certezza che esso non può essere consumato e quindi non si giudica opportuno di tassarlo; appena viene introdotto sul suolo britannico, vien meno quella presunzione legale di risparmio, anzi si presume che il reddito, dianzi accumulato, sia destinato al consumo e quindi lo si tassa. I progressi moderni della tecnica bancaria e più la educazione dei risparmiatori, fatti per abitudine mentale nuova internazionalisti, tendono a moltiplicare siffatti casi di immunità del risparmio. Sorgono e si moltiplicano in appositi stati, che acconciamente chiamerei stati cuscinetto, a somiglianza di quelli che l’arte diplomatica suscitò o rafforzò per impedire i contatti bellici troppo frequenti od estesi tra, maggiori stati vicini, istituzioni bancarie il cui ufficio è di amministrare le fortune private dei contribuenti di stati troppo propensi all’imposta. La Svizzera, il Belgio e la Olanda in Europa, il New Jersey negli Stati Uniti d’America sono i principalissimi di questi stati. Ivi han sede banche, le quali aprono botteghe a Ginevra, a Lugano, a Bruxelles, vicinissime all’Italia ed alla Francia, o subito varcato il fiume Hudson per i cittadini newyorkesi; e queste banche hanno reparti appositamente creati per l’amministrazione della fortuna privata degli stranieri. I governanti di questi stati cuscinetto, anche quando siano sozii delle bande spogliatrici radico socialiste od anche quando in patria propugnino armamenti e fortezze in combutta con gli industriali fornitori di armi, di cannoni e di corazze, ben s’accorgono che la neutralità finanziaria dello stato cuscinetto è economicamente altrettanto conveniente come la neutralità dal punto di vista bellico; e quindi soli larghi di immunità agli stranieri che, vivendo all’estero, affidino l’amministrazione del proprio patrimonio alle banche locali. Illustri magistrati di supreme corti di giustizia svizzere condiscendono a dar ragionati pareri in cui dimostrano a chiare note come i capitalisti stranieri possano dormir sonni tranquilli sotto l’egida della benigna legislazione fiscale dello stato cuscinetto. Le banche di questi stati pubblicano accorti annunci sui giornali a grande tiratura degli stati vicini tassatori; e moltiplicano gli annunci ogni volta che si paventi una legge d’imposta specialmente fastidiosa ai risparmiatori. Accorti commessi viaggiatori percorrono le città della Francia e già si introdussero nelle principali città italiane; ed, essendosi procacciate liste confidenziali di capitalisti facoltosi, si recano alle loro case e li persuadono della convenienza di sfuggire ai colpi del fisco, profferendo all’uopo l’opera delle banche loro mandanti. Donano opuscoli abilmente redatti e copie dei pareri dei magistrati illustri sovra menzionati. Alla lunga la seminagione è feconda; dicesi che, quanto più si moltiplicavano le minacce radico socialiste di nuova imposta globale sul reddito in Francia, tanto più i banchieri ginevrini dovessero moltiplicare le lor cantine blindate a prova di fuoco e di rapina, per renderle capaci a dar ricetto alla mole di titoli e di carte traenti in pellegrinaggio verso il franco ospizio elvetico. Negli Stati Uniti d’America, dove sono ignoti pudori ipocriti della vecchia Europa, le banche degli stati cuscinetto non si contentano di timidi annunci inoffensivi sui giornali e dell’opera discreta dei nuovissimi commessi viaggiatori del risparmio internazionale. Ricorrono invece senz’altro alla più aperta arte richiamatrice: nel 1911, avendo lo Stato di New York commesso l’anno prima l’errore di aumentare oltre misura la imposta successoria, subito le banche degli stati rimasti più miti ne profittarono; e New York apparve inondata di grandi annunci delle banche dello Stato dell’Alabama i quali gridavano ai passanti: No inheritance taxes in Alabama. Forbidden by Constitution of the State, ossia: Nessuna imposta successoria nell’Alabama. Proibita dalla costituzione dello stato. L’effetto sui legislatori newyorkesi fu mirabile e pronto. Impauriti dal vedere sfuggire la materia imponibile, per la facilità grandissima di farsi riconoscere cittadini degli stati concorrenti, nel luglio 1911 ridussero, soppressero, modificarono le esorbitanti imposte dianzi votate, in guisa da rendere il proprio stato nuovamente grato ai risparmiatori.
Queste prime linee di una teorica finanziaria degli stati cuscinetto non si vollero inserire a conclusione di questo capo nono per lodare o biasimare i contribuenti, i quali cercano di sfuggire alle leggi d’imposta della patria loro. La scienza non conosce lodi o biasimi, essendo suo compito stabilire le leggi regolatrici dei fatti. L’esistenza degli stati cuscinetto, la pratica del rolling-up e simiglianti fatti destinati a crescere col tempo di numero e di importanza provano che esiste una concorrenza tributaria fra gli stati produttori di servizi pubblici, così come esiste la concorrenza tra i produttori degli altri servigi; ed appena uno stato supera un certo punto nella pressione tributaria, subito si fa sentire la concorrenza degli altri stati, che offrono gli stessi pubblici servizi ad un prezzo minore. Il che è vero per tutti i generi d’imposta; ma è vero massimamente per quella scorrettissima maniera di imposta che è il tributo sul risparmio. Poiché la ricchezza che si vuol consumare, occorre goderla dove di fatto si vive; e lo stato, ove ha residenza il contribuente, ha mille modi di non lasciarsi sfuggire la materia imponibile. Mentre se una data ricchezza si vuol risparmiare, al risparmiatore deliberato alla rinuncia dei godimenti attuali, riesce già ora e diventerà sempre meglio indifferente il luogo del risparmio; onde egli, a parità di altre condizioni, si deciderà a scegliere quel paese i cui governanti, dall’esperienza e dalla dottrina fatti sapienti, profferiscono al risparmio libero ostello ed immunità da imposta.
Se ben si guarda, gli stati seguaci della corretta teoria che qui si tentò di delineare hanno ben presto ragione di rallegrarsi di aver prescelto la via dell’esenzione; mentre gli stati pervicaci nell’errore devono soggiacere ad una doppia ragione di mestizia. Questi, per la ostinazione posta nel pretendere tributi scorretti, a poco a poco vedono diminuire o non crescere, come dovrebbe, il risparmio impiegato nel paese; epperciò non soltanto non riescono a raggiungere il desiderato reddito risparmiato, ma perdono benanco altri redditi di lavoro e di capitale che sarebbero destinati in futuro ad essere consumati e che non son più creati dal risparmio posto in fuga. Al contrario gli stati cuscinetto e in genere gli stati che di fatto meglio seguono il postulato della uguaglianza tributaria vedono moltiplicarsi le industrie sorte mercé il risparmio forestiero; onde nuova materia imponibile si appresta al loro fisco. Non solo; ma gli stessi risparmiatori, per quanto legati alla patria, alla famiglia, alla lingua natia finiscono per disamorarsi dello stato che scorrettamente li tassa e fanno visite sempre più frequenti allo stato che al loro risparmio riconosce la dovuta immunità; e durante queste visite consumano ricchezze e sono correttamente tassati. Né di ciò si dolgono, essendo l’imposta sul reddito consumato consona al postulato dell’uguaglianza.
Con questa dimostrazione delle tendenze che la concorrenza fra gli stati e la esistenza degli stati cuscinetto impongono alla legislazione finanziaria han termine le prove, che in questa memoria si vollero addurre a mettere in chiaro come i legislatori pur mentre affermano il principio della tassazione del reddito guadagnato, sono a viva forza costretti dalla logica dei fatti a rendere omaggio al teorema milliano dell’esenzione del risparmio. Sarebbe sommamente desiderabile che altri moltiplicasse queste prove, cosicché l’edificio teorico dell’imposta sul reddito possa elevarsi armonico e perfetto in tutte le sue parti.
X
Nel quale si conclude con una esortazione ai critici
Giunto alla fine del mio discorso, debbo professarmi in anticipazione riconoscente a quanti vorranno criticarlo. La qual critica potrà essere di tre specie: quella che, giovandosi di talune maniere abituali in chi scrive di esprimere il proprio pensiero dottrinale, facendo di esso soventi immediate applicazioni pratiche, dichiarerà la sua dottrina turpe e antiscientifica, quasi fosse un panegirico delle imposte sui consumi, a pro’ delle classi ricche; l’altra, che dirà erroneo il ragionamento e sbagliate le conclusioni, perché reputerà errate le premesse dalle quali si partì: il postulato della uguaglianza ed il conseguente teorema della esenzione del risparmio, ed errate sia in se stesse sia perché altre sono, secondo i critici, le premesse del discorso tributario; e la terza che ammette, non foss’altro in via d’ipotesi, che le premesse siano corrette e studia se il ragionamento conseguente sia logico, e se siano tra di loro concordanti le conclusioni e se le premesse fatte prima e ragionate poi giovino a spiegare i fatti addotti. La qual terza specie di critica io reputo massimamente feconda, essendo chiaro che troppo comodo sarebbe respingere una dottrina corretta solo perché sembra, e non è, favorevole ai ricchi risparmiatori, e dannosa ai poveri, di cui i saltimbanchi affermano l’incapacità a risparmiare; ed essendo stato mio proposito deliberato di usare di quando in quando modi di dire che, dichiarando false, empie, facinorose, invereconde, crudeli, scellerate e turpi le imposte sul reddito guadagnato, fossero una innocua legittima ritorsione verbale contro le accuse di iniquità e di ingiustizia rivolte senza riflessione ad ogni piè sospinto contro le imposte sul reddito consumato e valessero a scernermi dalla turba di coloro che pretendono costruire una scienza economica e finanziaria imparziale mentre di fatto la vogliono parzialissima; ed essendo persuaso che compito della scienza e bensì quello di esporre le leggi astratte che regolano le relazioni tra i fatti, ma è insieme dovere dello studioso di chiarire e biasimare i sofismi con cui gli altri vogliono coonestare le loro pretese leggi. Ciò quanto alla prima specie di critica; quanto alla seconda mi professo incapace a scorgere quale sia il valore della critica che, negando le premesse si dispensa dall’obbligo di indagare se quelle, meglio delle altre che si potrebbero adottare, servano a spiegare i fatti. Perché il valore delle premesse – delle quali se ne possono enunciare a iosa, a seconda dei gusti di ognuno – si giudica dal numero dei fatti che spiegano e coordinano sotto un unico principio; essendo preferibile quella che maggior copia di fatti raccoglie e chiarisce. Onde si ricava che i critici della seconda specie in un modo possono efficacemente dimostrare la infondatezza della presente costruzione: costruendo un altro edificio su altre fondamenta. Allora si vedrà quale dei due sia più ampio ed armonico; e sarà gioioso il momento in che per me al nuovo sistema logico ed unificatore si possa rendere il doveroso omaggio.
Fino a che quel momento non sia giunto, ascolterò di preferenza i critici della terza specie, perché, come dice Francesco Acri (in Le Cose migliori, a cura di Luigi Ambrosini, Lanciano, R. Carabba editore, 1910, pag. 65), «il criterio secondo il quale conviene dar giudizio su i ragionamenti che si propongono di sciogliere alcuna questione, è quello dell’attrazione e dell’assimilazione. Ogni scioglimento di questione si opera per mezzo di una proporzione la quale da prima pare suppositiva; ma se poi le vien fatto di tirare a sé tutte le altre proposizioni che a quella questione si riferiscono, e, per la sua virtù assimilativa, conformarle e affigurarle secondo la sembianza sua propria, allora ella viene in dignità di regola, di ragione esempiativa, di principio. E per giovarmi d’una immagine, la nuova proposizione che faccia aperta la natura di alcuna cosa, per esempio quella delle idee, perché sia vera ed appaia non opinione ma scienza, fa mestieri che nel grandissimo numero delle altre proposizioni sciolte, disordinate, difformi, riferentesi alle parvenze delle idee, operi ciò che pietra gettata nell’acqua d’un lago, cioè una seguenza di cerchi paralleli che misuratamente incedono e s’allargano».
[1] Qui e in tutte le successive argomentazioni si fa astrazione dalle variazioni di valore della moneta e dalle variazioni del saggio dell’interesse. Di queste variazioni si dovrebbe tener conto a parte.
[2] Naturalmente a questa evidenza non credono coloro i quali sentono il bisogno dei ragionamenti «profondi» e si stupiscono che altri osi fondare tutto l’edificio tributario su massime dettate semplicemente dal buon senso e sui principii fondamentali ed universalmente accetti della legislazione civile. Parrà a costoro atto scortese il voler vietate ai finanzieri l’innocente sollazzo di escogitare cabale «originali» di utilità assolute o relative, di sacrifizi psicologici crescenti o decrescenti, di incrementi guadagnati o non guadagnati, di capacità contributive, di controprestazioni e simiglianti complicazioni. Chi invece rimase scettico intorno all’importanza degli acrobatismi dilettevoli che si susseguono con nomi diversi ad ogni venticinque anni nella scienza economica e finanziaria, vedrà forse con benigno occhio il tentativo che qui si fa di giungere alla meta, a cui oggi si arriva con esercizi svariati di eleganze logiche, con i metodi antichi e riposanti del ragionamento semplice, a base di lire, soldi e denari, che sono accessibili ad ogni uomo sennato.
[3] Per conformarci all’uso corrente e senza voler risolvere le questioni sottilissime che a questo punto si connettono intenderemo per «beni materiali» i servizi ovverosia i godimenti che all’uomo dà il consumo dei beni materiali che si consumano in una volta sola (pane, vino, ecc.), e anche il consumo graduale ripetuto dei beni materiali durevoli (casa, vestito, automobile, ecc.); e per «servizi personali» i godimenti che l’uomo ritrae dall’opera di altre persone fisiche (domestici, camerieri di albergo o di caffè, cantanti, attori, ballerine, avvocati, professori, medici, cortigiane, ecc.). I servizi dei beni materiali di consumo immediato o di consumo ripetuto e i servizi delle persone esauriscono, sembra, il campo di acquisto, a scopo di consumo, del numerario posseduto dall’individuo.
[4] È quasi superfluo notare che qui non si accenna alle tasse scolastiche le quali corrispondono ad un servizio particolare reso dallo stato; bensì all’esigenza di non colpire con imposte la spesa fatta per pagare le tasse scolastiche, somiglianti a quelle che si pagano sulla spesa fatta per alcool, tabacco, giornali, ecc.
[5] Ulisse Gobbi, Un preteso difetto delle imposte sui consumi, in «Giornale degli economisti», aprile 1914 e M. Pantaleoni, L’identità della pressione teorica di qualunque imposta a parità di ammontare e la sua semeiotica, in «Giornale degli economisti», marzo 1910.
[6] Perciò non si dica che qui si sono volute difendere le imposte sui consumi, quali sono oggi in Italia. Anzi le cose discorse nel testo adducono nuove prove a dimostrare la scorrettezza dell’odierno ordinamento nostrano delle gabelle sui consumi. Essendochè queste, insieme al vizio della loro indole rabbiosamente protezionista, sono afflitte da una iniquissima propensione a tassare di soverchio i consumi risparmio (sale, pane, petrolio, vestiti di cotone, ferro ed acciaio); e per tale duplice errore si palesano spesso indegne del nome di imposte sul reddito consumato.
[7] Per una esposizione delle idee del Giulio e dei suoi contemporanei, veggasi Alberto Geisser, Della tassa domestici e di alcuni minori tributi locali, in «La Riforma Sociale», luglio-settembre 1912, dove son fatte proposte di ritorno ad alcune imposte suntuarie a pro dei comuni italiani. Il Giulio, contrariamente al Cavour, riteneva però sufficiente l’imposta progressiva sui valori locativi, senza che fosse d’uopo aver ricorso alle altre imposte suntuarie. Degli scritti del Giulio parlerà forse, come a lui conviene, Giuseppe Prato, del quale intanto voglio dare il titolo di una memoria di prossima pubblicazione: Di alcune recenti teorie sulla nozione di capitale e di reddito e delle loro conseguenze tributarie, nella quale si darà, secondo la notizia che ho del suo concetto informatore, nuovo contributo alla dottrina che anche in questa memoria si vuol propugnare.
[8] Una legge del 26 luglio 1879 fu decretata – fatto unico nella storia finanziaria – non per impedire le dichiarazioni di valori locativi inferiori alla realtà, ma per porre termine alle così dette «esagerazioni» dei contribuenti i quali stanchi di pagare poco volevano denunciare un fitto che più si avvicinasse alla realtà! Vero è che i contribuenti erano presi da siffatto stravagantissimo zelo fiscale non per la voglia di pagare il tributo legalmente dovuto, sibbene per acquistare il diritto elettorale, che nel periodo censitario dipendeva dal pagamento di una certa somma d’imposta; onde, acquistato quel diritto, subito ritornavano ad ubbidire alla loro indole frodo lenta.
[9] Jules Ingenbleek, Impóts directs et indirects sur le revenu. La contribution personnelle en Belgique, l’Einkommensteuer en Prusse, l’Income tax en Angleterre, in «travaux de l’Institut de Sociologie des Instituts Solvay», Bruxelles, Ed. Misch et Thron, 1908. All’autore, che è grande fautore delle imposte suntuarie sul reddito consumato in confronto alle imposte sul reddito guadagnato per ragioni sovrattutto pratiche di accertamento, ragioni che da sé sole hanno del resto già un peso grandissimo, manca soltanto di aver veduto che le imposte da lui caldeggiate hanno un fondamento teorico ben più incrollabile delle sedicenti imposte sul reddito od imposte sul reddito guadagnato. Difetto che ha torto fa sembrare vergognosa la sua tesi, quasi fosse una difesa di istituti vigenti, venerabili per antichità, comodi praticamente ma dottrinalmente insostenibili.
[10] Per le basi precedenti l’A. apporta delle modificazioni al sistema vigente, conservandolo però intatto nelle sue grandi linee.
[11] Rivisse però ipocritamente nel ben peggiore dazio doganale sul frumento e sulle farine. È inutile notare che il sistema di imposte sul reddito consumato è costruito nell’ipotesi che esso giovi solo a fini fiscali, non mai ad intenti protettivi. Nel qual caso l’istituto ottimo diventa pessimo; e la lode si muta in acerba condanna.
[12] Cfr. per una documentazione esilarante lo studio che «La Riforma Sociale» pubblicò nel fascicolo di febbraio-marzo 1912 col titolo: L’imposta di ricchezza mobile ed i nostri parlamentari.
[13] La cui teoria cercai di delineare in altra memoria su Le premesse dottrinali della riforma del regime fiscale delle società per azioni, in «Rivista delle società commerciali», 1911, pag. 417 e segg.
[14] Vedi, a proposito di un’opinione ottimista di Enrico Barone sulla attitudine dei legislatori del tempo in che la presente memoria fu scritta (1912), una annotazione qui omessa e rinviata alla Nota bibliografica in fine del volume.
[15] Intorno ai lavori del comitato del 1861 ed alle ragioni, esclusivamente fiscali, per cui, in seguito all’apposizione vivacissima e continua per lunghi anni dal Gladstone, le proposte dell’Hubbard non furono accolte, veggasi SELIGMAN, The Income tax, pag. 61 e segg.
[16] Come si vede, nel testo per non complicare la trattazione ho fatto astrazione dalle novità introdotte dalla legge 23 giugno 1877, n. 3903 (serie seconda), la quale distinse la C in C (reddito di lavoro puro prestato a privati) e D (redditi di lavoro puro prestato ad enti pubblici) e dalla legge del 22 luglio 1894, n. 339, che distinse la A in A1 (redditi di capitale puro mutuato ad enti pubblici ed a società sovvenzionate da enti pubblici) ed A2 (redditi di capitale puro mutuato a privati), ed elevando l’aliquotà al 20%, mutò le detrazioni espresse in ottavi in queste altre espresse in quarantesimi: nulla per la A1, 10-40 per la A2, 20-40 per la B, 22-40 per la C e 25-40 per la D. Coteste mutazioni furono compiute in ubbidienza a momentanea necessità del tesoro. Semplici espedienti fiscali non rispondono a verun concetto teorico, difficilmente potendosi menar per buona la teoria che i redditi di A1 siano più sicuri dei redditi di A2, dopo ché in Italia lo stato ebbe una volta, e precisamente nel 1894 a ridurre forzatamente gl’interessi del debito pubblico, sotto colore di aumento generale (che tale non era, essendo specialissimo) dell’imposta di ricchezza mobile, e dopoché non rari furono gli esempi di comuni e provincie ridotti in stato di fallimento e costretti a ricorrere all’opera di speciale commissione governativa per venire a concordato coi creditori. Neppure ha valore teorico il motivo pur praticamente notabilissimo, che consigliò la divisione della C in C e D, con trattamento più benigno alla D. Esentando i 4-8 invece dei 3-8 ed ora i 25-40 invece dei 22-40 per i contribuenti della D in confronto della C, il legislatore non ha voluto riconoscere un maggior loro bisogno di risparmio; ché anzi lo hanno minore, essendo gl’impiegati pubblici provveduti di lunghi congedi di malattia, di pensioni di riposo e di pensioni riversibili alla vedova ad ai figli minori; sibbene ha voluto tener conto della loro minor attitudine frodolenta in confronto ai professionisti e lavoratori privati. Non si può impedire che in un sistema d’imposte sul primitivo concetto semplice e puro si innestino concetti estranei e pratici; né questi ci devono vietare di scorgere, attraverso al groviglio dei fatti nuovi e disparati il nucleo fondamentale d’idee che ha ispirato l’opera del legislatore.
[17] Passo sopra a molte peculiarità dell’imposta sul patrimonio, che lo rendono uno strumento fiscale poco maneggevole, ma che non hanno una relazione strettissima col problema in discorso.
[18] Di questo felice proposito, poi non attuato, del legislatore italiano, discorsi in un articolo Contribuente e reddito nei progetti di riforma tributaria nel numero dell’11 maggio 1910 del «Corriere della Sera», dove misi in rilievo l’importanza grandissima dell’esenzione dei premi di assicurazione chiamandola un’idea forza destinata ad iniziare l’abolizione dello sconcio diffusissimo nelle nostre e nelle estere legislazioni dei doppi d’imposta.
[19] Cfr. fra gli altri il libro di uno dei classici dell’economia delle stime, Giuseppe Borio, Primi elementi di economia e stima dei fondi agrari e forestali. Quarta edizione per cura del prof. C. Tommasina, Torino, Unione tip. ed. torinese, 1910, pag. 118 e segg.
[20] S’intende agevolmente che quando si dice essere la distruzione della foresta una conseguenza del sistema d’imposte, non si vuole asseverare essere questa l’unica causa del fatto dannoso; bensì una delle cause concomitanti, forse quella che dà l’ultimo tratto alla bilancia. Ed anche s’intende che non in ogni luogo il sistema della tassazione sul reddito guadagnato dà luogo alla distruzione della terra, bensì soltanto in quei territori dove la cultura forestale è il mezzo esclusivo per conservare la terra. E vuolsi ancora avvertire, benché sarebbe superfluo, che la religione della foresta non deve diventare una monomania e spingere a piantare alberi laddove può durare il pascolo o dove può ottenersi un conveniente equilibrio tra le varie culture.
[21] L’imposta sul reddito netto dei fabbricati costrutti chiamasi imposta sul reddito realizzato non perché sia veramente tale – dovrebbe invero percuotere solo quella parte di fitti netti che è effettivamente consumata dai proprietari -, ma perché essa colpisce il reddito quando oggettivamente si distacca dalla fonte ed è «pronto al consumo». Il reddito guadagnato, giunto a questo punto, è assai più vicino al consumo di quanto non fosse quando consisteva in un semplice incremento della fonte. A spiegare il concetto valgono del resto le ragioni esposte nel capo primo intorno alla differenza dei due concetti di reddito guadagnato e di reddito realizzato rispetto alle cose feconde di reddito e rispetto alla persona del contribuente.
[22] Una lunga annotazione, avente indole generale, inserita qui nel testo originale a chiarire le ragioni per le quali si suppose vera la tesi del ribasso di valore dell’area, in conseguenza dell’imposta, da 100 a 90 lire nel momento della maturazione, è stata, in questa ristampa, rinviata alla Nota bibliografica posta alla fine del volume.
[23] Si dice al massimo perché se rendesse di più, l’area non varrebbe 50 lire, 55 o 60, e non sarebbe più conveniente, astrazion fatta dall’imposta, ritardare il momento della fabbricazione per avere fra 15 anni e un valore di sole 100 lire; laddove, mettendo a frutto le 60 lire, dopo 14 anni e se ne sarebbero avute 120. Quindi non l’imposta, ma la perdita degli interessi avrebbe indotto ad anticipare la costruzione; come nel caso inverso a posticiparla. Per vedere l’effetto dell’imposta bisogna supporre che al momento dato, iniziale, sia indifferente costruire o non costruire, per vedere se l’avvento dell’imposta faccia pencolare la bilancia in favore dell’una o dell’altra alternativa.
[24] Naturalmente qui non si tiene calcolo, per non complicare il discorso del reddito della costruzione sorta su quel metro quadrato, ma soltanto del reddito derivante dall’uso dell’area edilizia, e cioè della rendita edilizia propriamente detta.
[25] In realtà l’imposta in Italia è assai più elevata; ma ciò non monta ai fini della dimostrazione, perché sarebbe anche più elevata nel caso di fabbricazione posposta.
[26] Che le successioni maggiori di preferenza vadano a favore di parenti lontani e si possono quindi supporre cumulate in vita da scapoli o da coniugati senza prole è dimostrato nel libro di Corrado Gini, I fattori demografici dell’evoluzione delle nazioni (Torino, Bocca, 1912, pag. 19 e segg.), dove si recano statistiche italiane le quali provano come, a mano a mano che cresce l’ammontare della successione, diminuisce la percentuale di essa devoluta ai figli, ai coniugi, ai fratelli e sorelle e cresce la quota spettante a zii, nipoti, pronipoti, coniugi germani ed altri parenti; e dove si prova altresì una decrescenza nell’ammontare medio delle eredità a mano a mano che i figli si moltiplicano.
[27] Un calcolo singolare dell’ufficio compiuto dall’imposta di successione ad uguagliare i carichi tributari dei «prolifici» e dei «soli» leggesi in Ingenbleek, op. cit., pag. 404.
[28] Una indiretta dimostrazione della verità della sapienza popolare si legge a carte 26 del citato libro del Gini, dove si reca l’esempio della Svezia del secolo XIX in cui, di 153 patrimoni superanti il milione, solo 63 erano stati acquisiti per eredità o mediante matrimoni e 90 erano di nuova formazione: di questi, 67 erano dovuti a svedesi, 9 a israeliti, 14 a stranieri; fra i 67 dovuti a svedesi, ben 23 erano dovuti a persone appartenenti al ceto operaio o a classi sociali equivalenti. Dal che sembra legittimamente dedursi, sebbene le cifre addotte per sé sole non lo affermino, che dei grossi patrimoni dianzi costituiti una buona parte si era andata dissolvendo per via; il che dovrebbe indagarsi meglio, seguendo nell’avvenire le vicende dei 90 patrimoni di nuova formazione. Utili e finanziariamente feconde indagini, che io mi limito ad additare ai valorosi cultori della statistica, di cui si allieta l’Italia.
[29] Per le cose discorse nella prova ottava già si sa che il bisogno di risparmio è minimo e quindi la spinta dispendiativa – così acconciamente chiamava il Puviani la propensione a spendere – è massima tra i più ricchi; onde si reputò inutile ripetere nel testo quei concetti che spiegano la progressività per ogni imposta sul reddito guadagnato e quindi anche per l’imposta successoria. Del resto la spiegazione della progressività dell’imposta successoria in ragione dell’ammontare non più della quota ereditata – per cui valgono le medesime ragioni già dette nella prova ottava – ma dell’asse ereditario, che è il sistema vigente in Inghilterra, discende da quella medesima già data della progressività in funzione dell’allentarsi del grado di parentela; poiché, crescendo, come si disse in nota precedente di questa medesima prova, l’ammontare della successione a mano a mano che una proporzione maggiore di essa è assorbita dai parenti lontani, basta in parte la progressività dell’imposta in ragione della parentela per percuotere quasi automaticamente in misura maggiore le successioni più vistose di quelle più modiche; e viceversa è sufficiente la progressività in ragione dell’ammontare dell’asse ereditario per colpire in parte di più i parenti lontani di quelli prossimi. Combinandosi le due progressioni insieme, il carico sugli eredi lontani e sulle successioni maggiori diventa viemmeglio pesante.
[30] Ciò è a dire mai, se ascoltiamo l’esperienza storica.