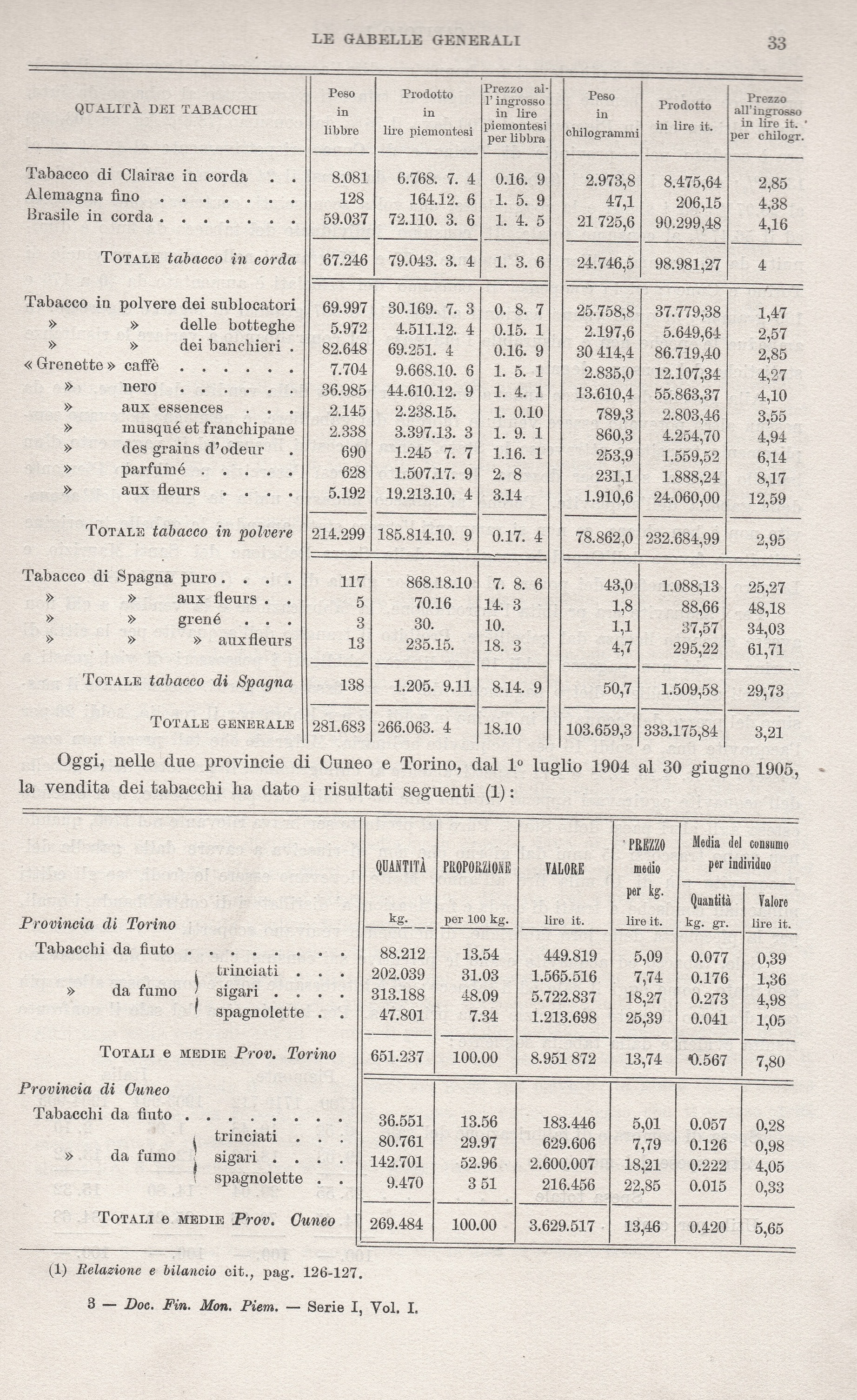Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte I: Le gabelle generali
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908
Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte I: Le gabelle generali
La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola,Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, pp. 1-44
1. In questo primo capitolo del presente volume si discorre della finanza degli Stati Sabaudi al principio dei secolo XVIII, prima cioè che si iniziasse quella varia e complessa opera riformatrice negli ordini tributari e contabili che prende data dal 1717. Per bene valutare l’importanza delle riforme che vennero dappoi, d’uopo conoscere quale fosse la finanza dalla quale si partì, e quanta fosse la sua virtù nel fronteggiare i bisogni dello Stato e quali sacrifici, e come distribuiti sulle varie classi sociali, imponesse ai popoli. Il periodo del primo Settecento, che possiamo chiamare pre-riformistico, si presta in singolar modo a saggiare il sistema tributario sabaudo; poiché esso può chiudersi tutto in quegli anni dal 1701 al 1713 che videro una delle più ostinate e dure guerre che mai si siano scatenate sud Piemonte.
Se in quei tristi frangenti rifulsero virtù militari di popolo e di principe, poté ammirarsi anche lo spirito di sacrificio che porta tutte le classi sociali a concorrere nell’opera, meno chiara, ma non meno necessaria, di apprestare ai combattenti il nerbo della guerra. Perciò amammo prendere il periodo storico dal 1701 al 1713 come soggetta materia del primo volume di questa collana di illustrazioni e documenti finanziari sul secolo VIII; poiché esso efficacemente ci aiuta a comprendere che cosa fosse e come operasse quella finanza sabauda, le cui vicende narreremo ed i cui nitidi documenti – principalissimi i bilanci e gli spogli – pubblicheremo nei volumi seguenti. Il volume si divide in due parti; nella prima (Capitolo I) diremo quali fossero gli ordini tributari sabaudi quando comincia il secolo XVIII; nella seconda (Capitoli II a VI) narreremo come quegli ordini operassero e fossero rafforzati in quegli anni del primo settecento quando furono posti a così dura prova da una guerra che mise in forse l’esistenza della monarchia e l’indipendenza della patria.
I
Le gabelle generali
2. – Fondamento precipuo della finanza piemontese del 1700 erano le “gabelle generali”, che noi ora chiameremo “tributi sui consumi”. Veniamo in testa ai bilanci; né per esse distinguevasi tra i paesi dello Stato, come per i tributi prediali, le entrate del demanio e le minori gabelle. Davansi in appalto a società di capitalisti, che promettessero al fisco larghe anticipazioni sulle entrate ancora da esigersi e dessero secura garanzia di lor solvenza. Dall’1 gennaio 1698 al 31 dicembre 1703 erasi appaltato l’esercizio delle gabelle ad una società di francesi, i cui soci principali erano Carlo Nicolao Richer, il signor De Rhodes, tesoriere dei gendarmi del Re di Francia, e Stefano Paissilier. Vi erano aggregati il signor Chamberlain, consigliere delle finanze in Francia e ricevitore generale del Poitou, i signori Pietro e Francesco Orfeau, interessati nelle accense del Re cristianissimo, e altri ancora: Fiorenzo Robilard, Stefano Richer, il signor Deshayes e Giorgio Blaisot.[1] Già pratici di simili maneggi e in grado; per le buone intelligenze coi fermieri generali delle gabelle francesi, di reprimere il contrabbando dal lato di Francia, eransi indotti costoro a promettere al Duca di Savoia il pagamento di 3 milioni e 600 mila lire all’anno, oltre L. 7000 per lo stipendio del conservatore delle gabelle e L. 7500 per il quarto delle multe e confische provenienti dalle contravvenzioni. Aveano poi fatta al fisco un’”anticipata” di L. 787.159.16. 8, per la quale ritenevano a proprio profitto l’interesse del 7% sul prodotto dello gabelle. L’anticipata doveva essere, ma non fa, restituita alla fine dell’appalto.
Subito da ambe le parti si muovevano alte querimonie sui risultati dell’appalto; che troppo grandi erano gli interessi in giogo e troppo vicina l’epoca del rinnovamento del l’appalto perché il Duca non pretendesse di ricevere troppo poco e gli appaltatori non cercassero di farsi credere ridotti alla rovina o, per lo meno, non volessero far credere ad fin lucro assai più piccolo del vero. Di questi diversi giudizi sul prodotto delle gabelle trovasi memoria nelle carte che ci rimangono intorno alle trattative per la rinnovazione dell’appalto.[2] Già dal principio del 1701 discutevasi di ciò; ed il Duca pare avesse inviato a Parigi un quadro assai roseo dei lucri ricavati dai gabellieri francesi durante i primi anni di lor contratto. Appariva da esso che nel 1698, 1699 e 1700 i gabellieri aveano lucrato di netto 127.200 lire all’anno in media, oltre all’interesse del 7% sulla loro anticipata, al G 010 sui fondi di commercio per lo provviste di sale, tabacco, carta bollata, ecc., 10 mila lire di diritto di presenza in Parigi e 40 mila lire come stipendio e spese di tavola dei soci dimoranti in Piemonte, Savoia e Nizza.
Sembra che il Duca volesse trattare sulla base di un canone annuo tra L. 3.800.000 e L. 3.900.000, e di ciò avesse dato il carico ad un faccendiere di Parigi, che nelle lettere conservate nell’Archivio di Stato si firma “Duclaireau” o “M. de Cadenet”. A costui era parso che sarebbe stato utile formare una nuova compagnia che avesse l’appalto delle gabelle degli Stati del Duca ed insieme del Milanese, sia per impedire con un’unica amministrazione il contrabbando fiorentissimo ai confini del Ducato di Milano, sia per far cosa gradita ai Re di Francia e di Spagna, che avrebbero stretto in una morsa di ferro il Piemonte anche sotto il rispetto finanziario. Dell’idea doveva avere avuto sentore il Chamillart, ministro della guerra di Francia, il quale avea messo avanti uno dei suoi favoriti, certo Poulletior, ricevitore generale delle finanze od impiegato nella ferma generale francese. Essendo mestieri però, poi conchiudere il negozio, avere notizie precise sul reddito delle gabello milanesi, il nostro mediatore si offeriva a lavorare in qualità di commesso nella segreteria de’ dispacci e lettere dei Duca durante la permanenza di Vittorio Amedeo nel Milanese a capo dell’esercito alleato. Sembra che il Duca abbia subodorato in tutto ciò qualcosa di poco chiaro perché, malgrado la speranza fattagli luccicare di un grosso aumento di canone per l’unione delle gabelle piemontesi e milanesi, non fu dato seguito ai negoziati.[3] I quali si riannodano, sempre a mezzo della stessa persona, nel 1703. Paissilier, preposto dalla società francese alla direzione dell’appalto, andava spargendo voci contraddittorie sulle sue intenzioni e su quelle dei Duca: ora negando ai soci la comunicazione dei conti allo scopo di avere di nuovo la direzione della compagnia, ora affermando che il Duca non volesse più fare un appalto unico tutte le sue gabelle, ma concederle repartitamente a diversi accensatori; cosa la quale tratteneva parecchi finanzieri esperti e ricchi dal fare loro offerte al Duca. Questi il 23 di febbraio aveva indirizzato al mediatore di Parigi una proposta di appalto della sola gabella del sale per L. 2.150.000 all’anno, corredandola di particolareggiate tabelle dalle quali risultava che la gabella del sale in Savoia, Piemonte, Nizza e Valle di Barcellona rendeva lorde L. 2.960.187, dalle quali deducendo L. 735.660 di spese d’ogni sorta, rimanevano di prodotto netto L. 2.224.527, con un margine discreto sul canone d’appalto. Offerivasi dai finanzieri francesi una somma di due milioni, negando l’esattezza delle cifre messe innanzi dal Duca, perché a quella stregua, dato un prodotto pel sale di L. 2.224.527, i fermieri francesi nel cui appalto il sale entrava solo per L. 1.984.666 avrebbero dovuto fare un guadagno di L. 239.861 all’anno, e in sei anni di L. 1.439.16G; mentre la verità si era che aveano lucrato in tutto appena 900 mila lire, la massima parte delle quali proveniva dal tabacco e dalle dogane e dal cambio delle monete piemontesi in monete francesi.[4]
In realtà il Duca voleva solo tenere a bada i finanzieri francesi e giovarsi delle loro offerte per ottenere patti migliori da una società italiana, composta del conte commendatore D. Silvestro Olivero, mastro auditore nella Camera dei Conti di Piemonte, e banchiere barone Marcello Gamba di Torino. Con una fretta insolita, senza chiedere cauzione e senza le formalità del pubblico incauto attribuivasi l’appalto ai signori Olivero e Gamba con contratto del 28 marzo 1703 per i sei anni dal 1704 al 1709 e per un canone annuo di L. 3.860.000. Non tutto era guadagno netto nelle 260 mila lire d’aumento sull’appalto precedente; perché alle vecchie gabelle si erano aggiunte la dogana di Savoia, che si supponeva fruttasse 30 mila lire all’anno, l’accensa del tabacco della città e del contado di Nizza, la gabella del vino di Nizza (45 mila lire), il dacito di Trino (10 mila lire) ed il dacito d’asti (8500 lire), prima appaltati a parte.
Se non fosse scoppiata la guerra a guastare i calcoli, il canone delle gabelle generali avrebbe formato pur sempre l’entrata più cospicua delle finanze piemontesi, circa i due quinti del bilancio normale, ond’è opportuno che da noi qui si dia un riassunto delle più interessanti disposizioni generali del contratto d’appalto, ad esempio de’ numerosi casi ne’ quali le entrate dello Stato erano appaltate, anzi che rette ad economia. La preferenza poi l’appalto era spiccatissima in quei tempi, tanto che un’entrata retta ad economia, ossia col mezzo di economi stipendiati dalle finanze, aveasi per sinonimo di un’entrata che nulla fruttava.[5]
Il contratto d’appalto, stipulato con molta solennità, obbligava gli appaltatori in solido a pagare il canone “in buone specie d’oro, d’argento od altre secondo il valore che quelle havranno in Torino al tempo di cadun pagamento (entro 15 giorni dopo spirato ogni quartiere repartitamente) nelle mani dei tesoriere generale a loro risigo, pericolo e fortuna, e senza alcuna scusa di qualsivoglia natura”, promettendo a sua volta il Duca “in fede e parola di Principe per sé e suoi successori alla Corona con giuramento, toccatosi il petto nella solita forma” di osservarlo e farlo religiosamente osservare senza veruna limitazione e restrizione o riserva, e senza punte violarlo sotto qualsivoglia pretesto né meno di accrescimento di monete. Nel qual caso le monete ribassate dovevano essere ricevute da’ tesorieri senza veruna perdita per gli appaltatori, anche se l’ordine della diminuzione delle monete fosse dato verbalmente.
Oltre al canone gli appaltatori erano obbligati a pagare al fisco le L. 7000 già prima fissate per lo stipendio del giudice conservatore il quale doveva giudicare, sia in civile che in criminale, di tutte le controversie gabellari, senza che vi fosse diritto di appello dalle sue sentenze; e L. 7600 per la quarta parte delle multe e confische a carico dei contravventori, le quali andavano tutte a profitto degli Olivero e Gamba. Dal canone essi avevano il diritto di far dedurre l’ammontare delle gabelle alienate a terzi, come i macelli di Torino alienati per L. 80.000 alla città di Torino, o soppresse come la tratta e foranea di Nizza (L. 25.000), o esatte in economia come il dritto di Villafranca per 70 mila lire, o vendute come i demani della Savoia;[6] e dell’adempimento ai loro obblighi doveano far constare al solo generale delle finanze, con un conto reso entro tre mesi dalla fine d’ogni anno per un breve stato solamente di debito o di credito “. Obbligavasi il fisco a rimborsare agli appaltatori alla fine del contratto il valore dei sali, tabacchi, candele, carta bollata e degli altri loro fondi di magazzino. Magazzini e case necessarie per l’esercizio delle gabelle fornivansi dallo Stato, rimanendo a carico degli appaltatori solo le piccole riparazioni.
Erano gli appaltatori soggetti alla sorveglianza dei controllori delle gabelle pagati dal fisco. I controllori nei primi cinque anni dell’appalto aveano diritto di visitare di giorno i magazzini delle gabelle insieme a commessi degli appaltatori. Nell’ultimo anno ai controllori era consegnata la chiave di una delle due serrature di ogni magazzino, all’insaputa l’uno dell’altro. Da ciò ad impedire che nell’ ultimo anno gli appaltatori vendessero a vil prezzo sale in guisa da minacciare il reddito della gabella nell’anno susseguente.
Larghi poteri venivano concessi agli appaltatori per difenderli dal contrabbando. Facoltà di nominare quanti commessi e guardie loro piacesse; con diritto del porto d’arme, esecuzione da obblighi di tutela, curatela, cariche pubbliche, alloggi di genti da guerra. Diritto agli appaltatori di visitare le case e i magazzini dei commercianti e spacciatori al minuto, salvo che vi si opponessero i proprietari, ché allora occorreva l’intervento del giudice conservatore o suoi delegati. Per le case private quest’intervento era sempre necessario, né mai potevasi far violenza alle persone. Diritto nei commessi e guardie giurate degli appaltatori di sequestrare le merci di contrabbando; e validità innanzi ai giudici conservatori dei loro processi verbali sino a che non fossero impugnati di falso. Diritto negli appaltatori di chiedere ai giudici conservatori l’arresto personale dei commessi e altri loro dipendenti i quali fossero in mora nel rendere i conti e pagare i debiti di gabella.
Se tutti i rischi normali erano accollati agli appaltatori, né potevano costoro lamentarsi delle perdite dovute a false previsioni, eranvi alcuni rischi straordinari, guerra, peste e carestia che davano diritto alla rescissione od alla modificazione del contratto. Riducevasi il canone, a detta di periti ed a norma di equità, quando dalla guerra o dagli altri flagelli fosse colpita una parte soltanto dello Stato; e rescindevasi il contratto senz’altro quando tutto lo Stato ne fosse percosso.[7]
Non era ancor cominciato il periodo d’appalto che i signori Olivero e Gamba, il 7 novembre 1703, subito dopo la rottura con Francia, protestavano di voler rescindere il contratto per i danni ed impedimenti recati al commercio dalla guerra; opponevasi il patrimoniale del Duca sostenendo non essere la guerra generale, ed esagerarsi troppo il documento al commercio; né avere gli appaltatori il diritto di rescindere il contratto poiché non aveano ancora iniziato l’esercizio delle gabelle. Ma ben presto, arbitro il conte Groppello,[8]statuivasi d’accordo che il contratto venisse sospeso sino all’1 gennaio dell’anno immediatamente successivo alla pace, dal qual giorno avrebbero dovuto decorrere i sei anni d’appalto agli antichi patti, salvo quelle modificazioni che uno o più arbitri eletti dal Duca ritenessero eque in rapporto alle variazioni eventuali del reddito delle gabelle. Durante la guerra i signor Olivero e Gamba avrebbero continuato a dirigere le gabelle, versando all’erario le somme incassate e rendendone un semplice conto di “cavata” ossia di entrata e di spesa. A compenso della loro opera e delle somme anticipate (sino al massimo di 500 mila lire) per la compra di sale, tabacco, ecc., era attribuito ai gabellieri un aggio del 4% sul prodotto netto delle gabelle, depurato dagli stipendi e dalle spese varie.[9]
Era il primo frutto della guerra: cambiare gli appaltatori in economi cointeressati e un canone certo di 3.860.000 lire in un reddito incerto, soggetto a mille cause di diminuzione e purtroppo assai minore delle speranze che s’erano concepite. La regia cointeressata dai signori Olivero e Gamba sembra non abbia soddisfatto guarì né il fisco né gli economi i quali si dimettono con scrittura del 13 marzo 1708. Rimproverava il Groppello ai due economi di lucrare troppo coll’aggio del 4% e di non dare alle gabelle tutta quell’attenzione che si richiede attorno il maneggio d’esse, mentre hanno affari particolari di conseguenza tale che gli occupano e lagnavansi gli economi di non aver impiegati a sufficienza per amministrare con efficacia.[10] Succedono nell’economia il tesoriere di Madama Reale, Francesco Antonio Colomba e il banchiere Giovanni Martino Calcino, associati a Giovanni Gerardi.[11] I nuovi economi hanno l’obbligo di amministrare a guisa di buoni padri di famiglia e di dare il solito conto di “cavata”. Ma non anticipano nulla per la compra dei generi di gabella e il loro aggio è ridotto all’1% del reddito gabellario purgato da tutte le spese.
Con questi e con altri, che loro succedono dopo pochi anni, il conte presidente Garagno nel 1711 ed il cav. Martini nel 1713, – semplici direttori questi ultimi, non cointeressati – le gabelle continuano ad essere condotte in economia per conto del fisco. Ma tanta è l’avversione che si avea contro questa forma di riscossione delle imposte, che a parecchie riprese si riannodano le trattative per nuovi appalti.
Nel 1711 uno spoglio dei prodotti gabellari dei tre anni precedenti metteva in chiaro come i prodotti fossero cresciuti di 455 mila lire nelle antiche provincie soggette al dominio sabaudo, e di 525 mila lire per le gabelle dei paesi di nuovo acquisto, senza calcolare il maggior prodotto che indubbiamente si avrebbe avuto appena conchiusa la pace. Il 17 settembre 1711 si pubblicano gli avvisi per invitare a presentare entro l’ottobre le offerte per l’appalto generale delle gabelle del Piemonte e delle provincie di nuovo acquisto, per tre anni dall’1 gennaio 1712; ma non si concluse nulla, probabilmente perché il giorno 15 novembre, fissato per il deliberamento, nessun concorrente giunse a soddisfare le pretese del fisco. Le trattative continuano; e, per essere ormai certa la conclusione della pace, nel 1713 le pretese crescono ancora. Un signor Leger erasi spinto ad offrire sino a L. 4.514.500, e per la sola Savoia si aveano gabellieri vogliosi di appaltarla pagando un canone di un milione di lire[12]. Il cavaliere Desmarets da Parigi mandava nel maggio dei 1713 al Groppello una lunga memoria per dimostrargli che le finanze piemontesi aveano interesse a separare le gabelle del Piemonte e dei paesi di nuovo acquisto da quelle della Savoia, concedendo queste in appalto ai fermiers generaux delle gabelle del Re di Francia. Diversi gli usi, le monete, i prezzi dei generi di gabella e specie dei sale, lontano il paese e separato da un’alta catena di montagne dagli altri paesi dello Stato; esservi quindi tutte le condizioni richieste per un appalto speciale delle gabelle della Savoia. Se concesso agli appaltatori generali delle gabelle francesi, questi avrebbero potuto impedire – come già avevano fatto durante la guerra, quando la Savoia obbediva al cristianissimo – il contrabbando del sale largamente esercitato dai savoiardi nel Delfinato e nel Bugey francese dove il sale vendevasi a più caro prezzo che in Savoia; né avrebbero avuto bisogno di un così gran numero di guardie di dogana alla frontiera, essendo i passi delle alpi assai più facili da custodire. Potere quindi gli appaltatori francesi offrire un canone superiore a qualunque altro, ed anche siffattamente elevato da non lasciare alcun margine di utile, essendo sicuri di rifarsi con le minori perdite di contrabbando nel Delfinato e nel Bugey. L’obbiezione che gli appaltatori francesi, togliendo il contrabbando, avrebbero fatto diminuire la vendita dei banchi di sale vicini alla frontiera di Francia, non avere alcun peso, perché allo scadere del contratto, le gabelle nostre potrebbero sempre ricominciare a vendere sale agli abitanti d’oltre frontiera, attratti dal minor prezzo. Queste ed altrettanti promesse di vantaggi pecuniari non valsero però a smuovere il Principe dalla sua riluttanza a mettere una sua principalissima entrata in mano a gente legata ai governanti di Francia. Gli sarebbe parsa una diminuzione della sua sovranità e della sua indipendenza fiscale.[13]
Tanto più gli rincresceva ridursi a tale estremo, in quanto le entrate gabellarie promettevano bene, senza ricorrere a spedienti nocivi. La guerra non avea scemato di troppo il consumo se i tre anni dal 1710 al 1712 accusavano un prodotto di L. 3.156.950 a cui aggiungendo L. 528.214 per le gabelle dei paesi di nuovo acquisto, 900 mila lire per la Savoia e 215 mila lire per Nizza, il calcolo del reddito netto delle gabelle poteva essere portato a L. 4.800.164, ossia, anche senza tener conto dei paesi di conquista, ad un punto d’assai superiore a quello che avea servito di base per gli appalti del 1698 e del 1703. Dava argomento a bene augurare del prodotto futuro delle gabelle il fatto che il prodotto del 1711 (L. 3.139.216) era superiore a quello del 1710 (L. 3.087.375) e il prodotto del 1712 (L. 3.244.268) maggiore di quello del 1711. Speravasi inoltre che la pace permettesse di reprimere più efficacemente il contrabbando in guisa da impedire l’entrata ad almeno la metà degli 80 mila rubbi di sale di sfroso consumato in paese, con un guadagno di 160 mila lire; che, cessando gl’impedimenti al commercio di transito e le proibizioni dell’esportazione di riso e cereali, la tratta e la dogana potessero fruttare un 50 mila lire di più; che 30 mila lire di maggior prodotto si potessero cavare dalla vendita di tabacco migliore, e che altre 50 mila lire dovessero ottenersi con certezza da una più oculata gestione nei paesi di nuovo acquisto. In complesso le pretese del fisco giungevano ai 5 milioni di lire; e non sembra che alcuno siasi trovato pronto a soddisfarle, se di nuovi contratti d’appalto non si sente più parlare. Obbiettavano infatti i concorrenti che eccessive erano le domande del fisco, il quale non avea voluto tener conto delle spese dei commessi e delle guardie a carico dei gabellieri, né dell’interesse sui capitali anticipati nella provvista dei generi gabellari; né dell’arresto probabile del commercio a causa della peste, che, appena cessati i mali della guerra, inseriva sulle dissanguate popolazioni. Aggiungevasi che il fisco avea potuto crescere il reddito del sale, provvedendolo di pessima qualità, ed ottenendo quindi un consumo maggiore; gli appaltatori essere obbligati, per contratto, a fornire sale buono di un costo superiore di forse due terzi al costo del sale provveduto dalla regia. Quindi spese maggiori e consumo minore perché di sale più sapido meno si compra per gli usi famigliari; e perdita certa per gli appaltatori non potendo il prezzo essere variato[14].
3. – È indubbio però che, nonostante la denuncia dell’appalto del 1703 e i non riusciti tentativi di nuovi appalti, le gabelle danno a partire dal 1708 un provento crescente alle finanze. Dal quadro generale delle entrate dello Stato, che pubblichiamo nell’ultimo capitolo di questo volume, vedesi che le gabelle generali dei paesi di antico dominio da un reddito netto di L. 3.561.709.19.4 nel 1700, anno di pace, erano cadute a L. 1.267.881.3.4 nel 1706, si erano risollevate nel 1708 a L. 3.267.933.17.2, e nel 1712 erano giunte a L. 3.620.551.12.5.7, per tornare nel 1713, anno in cui per 7 mesi si hanno di nuovo i redditi di Savoia e Nizza, L. 3.889.985.4.3.
Ma queste sono cifre complessive, in cui entrano anche i redditi presunti delle gabelle alienate alla città di Torino pel servizio degl’interessi di debiti pubblici; né da esse si trae la notizia delle singole gabelle che componevano quel grosso provento di circa 3 milioni e mezzo. Giova meglio a questo scopo riprodurre un quadro che potemmo costruire su quelli che le finanze compilavano per essere messi sotto gli occhi dei concorrenti agli appalti[15]. Le risultanze di questo conto non concordano in tutto con quelli che ora citammo e che son ricavati dai conti di tesoreria generale; vi mancano, fra l’altro, i prodotti delle gabelle alienate, che allora reputavansi come perdute per il fisco, malgrado i contribuenti le pagassero tuttavia ai creditori dello Stato. Ma il quadro, sia pur non desunto da conti arrestati in Camera e manchevole per qualche rispetto, è utile per far vedere ad un tratte quanti fossero i tributi sui consumi che dicevansi gabelle generali e quale fosse il costo d’esercizio delle privative di Stato.
| 1700 | Media 1710-1712 | |||||||||
| Prodotto lordo | SPESE | Prodotto netto | Prodotto lordo | SPESE | Prodotto netto | |||||
| Acquisto di generi gabellari | Stipendi e spese diverse | totale spese | Acquisto di generi gabellari | Stipendi e spese diverse | totale spese | |||||
| Savoia | ||||||||||
| Sale | 1.015.028 | 185.797.10 | 83.860. 5 | 269.657.15 | 745.370. 4 | — | — | — | — | — |
| Tabacco | 121.955 | 36.410.10 | 9.069. 4.1 | 45.479.14. 1 | 76.475. 5.11 | — | — | — | — | — |
| Carta bollata | 12.660 | 1.550.18.4 | 1.203. 9.1 | 2.754. 7. 5 | 9.905.12.7 | — | — | — | — | — |
| Tabellione | 26.417.17.10 | — | 1.028. 6.7 | 1.028. 6. 7 | 25.389.11. 3 | — | — | — | — | — |
| Demani | 23.698.10 | — | — | — | 23.698.10 | — | — | — | — | — |
| TOTALE Gabelle Savoia L. | 1.199.759. 7.10 | 223.758.18.4 | 95.161. 4.9 | 318.920. 3. 1 | 880.839. 4. 9 | — | — | — | — | — |
| Piemonte (e Nizza nel 1700) | ||||||||||
| Sale | 1.875.466.17.10 | 122.463. 4.3 | 356.870.12.9 | 479.333.17. 6 | 1.396.133. 0.10 | 2.096.288 | 219.730 | 389.0969 | 608.826 | 1.487.462 |
| Dogana e tratta | 844.641.10.9 | 111.167.11.9 | 111.167.11. 9 | 1.209.582.19. 0 | 896.208 | — | 88.975 | 88.975 | 807.232 | |
| Dacito di Susa | 82.749 | — | — | — | — | — | ||||
| Imbottato di Torino | 43.000 | — | — | — | — | — | ||||
| Balena | 4.800 | — | — | — | — | — | ||||
| Deliberamenti | 250 | — | — | — | — | — | ||||
| Sappone | 8.500 | 359.220 | — | 9.333 | 9.333 | 349.886 | ||||
| Carni, corame e foglietta | 368.810 | ³ 567.029 | 160.706 | 70.389 | 231.096 | 335.933 | ||||
| Tabacco, pipe ed acquavite | 402.499.14 | 106.769.15.1 | 61.269.13.8 | 168.039 8.9 | 234.460. 5. 3 | 64.365 | ||||
| Carta bollata | 56.462 | 3.034.12 | 7.367.16.9 | 10.402. 8. 9 | 71.059.11. 3 | 5.921 | 7.332 | 13.254 | 51.111 | |
| Carte, tarocchi e giuochi | 25.000 | 48.500 | — | 559 | 559 | 47.940 | ||||
| Candele bollate | 99.388 | 54.643. 2.1 | 18.647. 9.4 | 73.340.11. 5 | 26.047. 8. 7 | 107.145 | 65.565 | 12.051 | 77.617 | 29.528 |
| Posta | 46.300 | — | — | — | 46.300 | 80.840 | — | 37.426 | 37.426 | 43.413 |
| Diritto Villafranca | 70.000 | — | — | — | 70.000 | — | — | — | — | — |
| Contravenzioni | 30.730 | — | 14.438. 8.10 | 14.438. 8.10 | 16.291.11. 2 | 7.398 | — | 2.953 | 2.953 | 4.445 |
| TOTALE:Gabelle Piemonte | 3.269.597. 2.7 | 286.910.13.5 | 569.811.13.1 | 856.722. 6. 6 | 3.069.874.16. 1 | 4.226.993 | 451.922 | 618.114 | 1.070.043 | 3.156.950 |
4. – Era la gabella del sale di gran lunga la più produttiva fra i tributi sui consumi e, per la sua gravezza, la più odiata dai popoli. Pagavasi infatti il sale nella maggior parte degli Stati dei Duca quattro soldi la libbra, il che varrebbe quanto 68 centesimi al chilogrammo di moneta nostra. Fatta ragione al diverso valore della moneta due secoli fa, si arguisca quanto pesasse sulle popolazioni codesto tributo. Il sale costava qualche cosa più del prezzo comune nei paesi oltre noia, per le maggiori spese di trasporto, dei quali la finanza voleva essere indennizzata dai consumatori; sicché in Val d’Aosta il prezzo giungeva a 4 soldi e 3 denari la libbra (0,72 al kg.). In Nizza invece, per antichi privilegi ed anche per non annullare del tutto la vendita dei sali di gabella a causa del contrabbando dalla vicina Repubblica di Genova, il sale vendevasi a prezzo assai più mite; il quale, pur dopo l’editto del 4 gennaio 1697, che l’accresceva per sopperire alle spese derivate dalla guerra del 1690-96, non superava un soldo per libbra (D. XXIII. 1611).
La gravezza del prezzo del sale era tanta in rapporto alla povertà degli abitanti, che non si sarebbe certo riusciti a ricavare da questa gabella somma rilevante se, oltreché allo spediente del monopolio, lo Stato non avesse fatto ricorso ad una regola usitata in Europa ed odiatissima sovra tutte: la fissazione della quantità di sale che da ogni abitante si doveva comprare ogni anno. L’editto 9 agosto 1669 avea stabilito per ogni uomo, di età maggiore ai cinque anni, il consumo di otto libbre (circa kg. 2.9) all’anno, per ogni bestia bovina quattro libbre e per ogni bestia caprina e lanuta una libbra D. XXIII.1671). I subappaltatori comunali del sale e le comunità rispondevano verso lo Stato di questo consumo minimo, che dicevasi sale di levata o di fissazione; né alle comunità le quali in un anno “levavano” una quantità di sale minore di quella fissata, era concesso di ottenere un abbuono maggiore del puro costo e trasporto del sale, rimanendo debitrici sempre della parte del prezzo la quale costituiva tributo. Ordini minuziosi presiedevano alla consegna delle bocche umane ed alla inquisizione delle bestie possedute da agricoltori e trafficanti, delle stagioni di carni porcine, dei pecorari e margari soliti a risiedere o svernare né diversi luoghi, del concorso di uomini e bestie in occasione di mercati e fiere, ecc.[16].
La fissazione del minimo di sale da consumarsi era però in fatto regolata per modo da non esaurire in tutto la capacità di consumo delle popolazioni; del che erano causa sovratutto le frodi nelle consegne, per le quali il numero delle persone e delle bestie risultava di solito minore del vero. Ond’è che la gabella avrebbe potuto fare uno smercio non piccolo di sale in più della quantità minima di consumo obbligatorio, se alla vendita del sale di maggior smaltimento non si fossero opposti, con ogni forza, i contrabbandieri, allettati dall’alto margine lasciato dal prezzo di quattro soldi per libbra. Di qui le pene ferocissime contro i contrabbandieri, che quali nemici dello Stato ponevansi al bando della società. Confisca de’ beni e galera perpetua a chiunque introducesse e trasportasse o facesse transitare da tre a cinque rubli di sale forestiero; e confisca dei beni e pena di morte se il sale contrabbandato giungesse a cinque rubbi precisi o li superasse. Pene simiglianti erano comminate a’ ricettatori, compratori e commercianti che avessero avuto mano nello smercio di sale contrabbandato (D. XXIII.1607).
Scarso era il vantaggio di tanta ferocia, scritta forse soltanto negli editti; il contrabbando, specie ne’ tempi di torbidi e di rivolgimenti politici, fioriva e da tutte parli il sale forestiero nascostamente si introduceva nel Piemonte, sopratutto da Genova e da Nizza, meno dal Milanese, dove la gabella del sale era mantenuta alquanto più severamente. A rubbi 400 mila l’anno calcolavasi nel 1708 lo smercio del sale nel Piemonte antico e nel Ducato d’Aosta, ossia a circa 3 milioni e 700 mila chilogrammi, che, per un paese di circa 560/900 mila abitanti,[17] si ragguagliava a Kg. 4.10/4.30 per abitante. In Italia oggi il consumo medio di sale di tutte le qualità e per tutti gli usi si aggira sui 6,5 chilogrammi per abitante[18]. Il sale di “fissatione” o di “levata” era stabilito in 305 mila rubbi, a cui si aggiungevano per maggior smaltimento 95 mila rubbi, dei quali 25 mila erano certi, essendosi i subappaltatori locali per contratto assunto l’obbligo di smaltirli nella fiducia di venderli in conformità all’esperienza del passato e 70 mila tutt’affatto incerti, che i rivenditori s’industriavano a vendere per lucrare i 20-25 soldi per rubo (circa 1 soldo per libbra) che le gabelle loro concedevano per questa parte a titolo di aggio[19].
Della tenuità del consumo n’avea colpa anche la qualità deì sali, rossi la più parte e di qualità scadente; tanto che ne’ pochi luoghi del Contado di Nizza rimasti a dizione piemontese e nelle terre della Valle di Stura superiore, anticamente unite al Nizzardo, dove spacciavasi sale bianco ad 1 soldo la libbra, vendevansi nel 1708 ben 36 mila rubbi di sale, con un consumo medio che può valutarsi, per una popolazione presunta di 20.000 abitanti circa, a 45 libbre (16.56 kg.) a testa[20]. Che del resto il consumo del sale potesse crescere assai a prezzi più bassi rilevasi pure da ciò che nel Contado di Nizza, dopo il suo ricupero da Francia, nell’anno dall’1 giugno 1713 al 30 maggio 1714, la gabella del sale rese L. 64.360.19 nette da spese di compre, stipendi ed avarie. Supponendo che su ogni libbra di sale, venduta ad un soldo, le spese fossero di 6 denari, è manifesto che quel lucro corrisponde ad un consumo di 2.574.438 libbre, ossia, calcolando gli abitanti a 55 mila, a circa 46-47 libbre (kg. 17 circa) per abitante, il quadruplo del consumo in Piemonte[21].
Al contrabbando, calcolato in 80-100 mila rubbi all’anno, davasi da’ finanzieri tutta la colpa dello scarso consumo del sale; ed architettavansi rimedi per impedirlo: mettere, accanto ai 164 invigilatori delle gabelle, due compagnie di dragoni al Borgo di San Dalmazzo per andare in traccia de’ contrabandieri nizzardi, e due altre tra Cherasco, Bra e Pollenzo contro i contrabbandieri genovesi che, passando attraverso a’ feudi imperiali delle Langhe, penetravano in tutto il Piemonte; con ispettori e spie in aggiunta per star attenti ai movimenti dei frodatori ed avvisarne i dragoni. Ne poco giovamento si sperava da una compagnia di dragoni posta in Gattinara ad invigilare i contrabbandieri che venivano dal Milanese[22].
Ma già fin d’allora non facevano difetto alcuni spiriti più penetranti, i quali vedevano che non il contrabbando avea colpa dello scarso consumo del sale; ma l’alto prezzo del sale era la cagion prima del contrabbando. Qui non è mestieri dilungarci su la riforma tentata con ardimento grande da Maria Giovanna Battista con editto del 6 maggio 1680, in seguito a proposte e discussioni lunghe durate nei Consigli supremi della Corona. Non è inutile dire però come già fin d’allora si scorgesse la vanità della ferocia fiscale ad accrescere il lucro della gabella: “Hanno (i Sovrani)… con loro Editti… imposte severissime pene a’ sfrosadori, etiandio sino alla pena di morte con la confisca de’ loro beni, ma tali pene, anche di morte, quantunque più d’una volta eseguite, non sono state bastevoli per frenare col lor esempio la malitia e temerità de’ trasgressori. Hanno obligato li accensatori a deputare gran numero de’ corridori per invigilare alla conservatione di detto dritto, ma neanche da questo mezo, per altro notabilmente dispendioso e cadente in diminutione degli accensamenti s’è ricavato alcun frutto, anzi… tra questi et i sfrodadori sono seguiti molti homicidii o tacite intelligenze a maggior danno dello smaltimento sudetto: si sono fatte e si fanno inquisitioni continue, son seguite e seguono frequenti condanne di più persone con l’esecutione delle pene: ordite molte calonnie et imposture contro innocenti, con la sequella di molti altri mali che ne derivano, senza però la cessatione, anzi più tosto col crescimento degl’abusi e dei sfrosi”. Dopo questo preambolo, Madama Reale annunciava di volere ricorrere per rimedio alla diminuzione del prezzo del sale: abolito l’obbligo della levata per le bestie, e conservato solo per gli uomini di età superiore ad anni cinque. Costoro doveano al solito comprare otto libbre di sale all’anno al prezzo di quattro soldi, pagando però due soldi al momento della compra e due alla fine del trimestre. Eccettuati dall’obbligo della levata i “miserabili” privi di terra e di bestie e non esercenti negozio, i quali fossero indicati con giuramento dei parroci e sindici delle comunità. Il sale, comprato fuor d’obbligo, e quindi tutto quello ad uso dei miserabili e delle bestie e l’eccedenza delle otto libbre per la comune degli uomini, doveasi vendere dalle gabelle a due soldi la libbra (D. XXIII. 1566).
Gli effetti non corrisposero subito a’ consigli umani de’ reggitori: tanta liberalità non parendo forse possibile a’ popoli, affrettaronsi parroci, sindici e subappaltatori conniventi a dichiarare per miserabili e mendicanti quasi che tutti, anche se proprietari di terre (“particolari”); ond’è che prima dovette intervenire la Camera de’ Conti con ordine dell’1 aprile 1661; e, non bastando le accortezze a sventare le frodi, Vittorio Amedeo II, ancor sotto la reggenza della madre, considerando che “come accade sovente anche negli affari maturamente esaminati e stimati prudentialmente riuscibili… l’effetto non è seguito conforme all’aspettatione che se n’haveva” aboliva con editto dei 20 agosto 1681 (D. XXIII. 1600) l’altro pubblicato poco più d’un anno prima dalla madre sua e ripristinava gli ordini antichi che sopra noi abbiamo descritti.
La mala riuscita della riforma del 1680 – cagionata forse dall’errore commesso fissando due prezzi diversi, di quattro e due soldi, per la stessa derrata, ciò che naturalmente dovea indurre tutti a preferire il prezzo minore, sottraendosi all’obbligo della levata – distolse per un pezzo i governanti dai pensare a novità nella gabella del sale. Durante la guerra nostra il sale non crebbe tuttavia di prezzo, se bene gli economi, allegando l’impossibilità di procacciarsi la quantità di sale prescritta dagli editti, ottenessero facoltà dalla Camera di spacciarne di qualità inferiori[23]. All’accrescimento del prezzo del sale non mancò chi pensasse come a mezzo di prepararsi alla guerra; ma la proposta non trovò benevola accoglienza, essendo risaputo che non potevasi nulla aggiungere ad un balzello già gravosissimo.
Piuttosto sembra che si pensasse di nuovo sul serio dal Duca e dal conte Groppello a tentare, sott’altra forma, la diminuzione del prezzo del sale, non riuscita sotto la reggenza di Giovanna Battista; poiché sappiamo essersi dato il carico ad un magistrato della Camera dei Conti di stendere una memoria sulla riforma della gabella del sale. Questa memoria ci rimane conservata negli Archivi di Stato; ed è intessuta di così accorte argomentazioni ed ha un così fresco sapore di realtà, che noi reputiamo opportuno riassumerla per sommi capi a compimento di questo nostro discorso sulla gabella del sale nei primi anni dei settecento, ed a dimostrazione delle tendenze riformatrici che, malgrado io strepito delle armi, si risvegliavano nel Piemonte e frutti copiosi dovevano dare in seguito[24].Sentasi il proemio della memoria dell’anonimo magistrato: “Ogni Gabella più che dal Dritto che impone è in rendita dal numero delle persone, da’ quali l’esige ed è evidente che il Prodotto di qualsiasi maggior Dritto sarà sempre poco pagato da pochi, come sarà sempre maggiore il Prodotto di un anche tenue Dritto pagato da molti. L’aggravare di nuove Gabelle il Paese è appunto l’Economia di certi inni, quali per crescere per alcuni anni i loro redditi, prima perdono i Massari, poi le stesse Cassine. Così sovente alla depressione de’ Stati, qualora s’aumentano altri imposti o maggior Dritto agli antichi, riesce in breve tempo di distrarne al Sovrano i Sudditi e colli Sudditi la principale sostanza alle Gabelle. Quel sovrapiù, che si prettende d’aumento, è tanto di detratto alli primieri Prodotti, e ben spesso per una maggior Imposizione, che si sostenga quando sia universale a tutti, sono in perdita le altre”.
La cattiva politica di crescere la gravezza de’ tributi nella speranza di trarne maggior provento – politica non disusata ai dì nostri – ha fatto abbandonare la coltivazione delle terre e fuggire le persone da territori prima popolati, come Mondovì, Ceva, Vercelli, Biella, le Langhe. Sicché non gioverebbe abolire i tributi nuovi aggiunti per causa della guerra agli antichi; ma è d’ uopo “per elezione diminuire anche gli antichi, non bastando per lo più a riavere la popolazione di condannare quei mezzi, quali l’hanno deviata, ma è forza talvolta di richiamarla e promuoverla con nuove franchigie e più generose esenzioni”. Pel sale una diminuzione dei prezzo è consigliata non pure dalla convenienza di non angustiare troppo i popoli, ma anche dall’opportunità di reprimere il contrabbando con mezzi più efficaci delle pene feroci comminate negli editti. L’aumento infatti del prezzo del sale da due soldi a tre nel 1639 ed a quattro nel 1644 “ha quasi messo il sale più in sfroso che in vendita et ha aggravato di tante avarie la Gabella, sicché poco manca abbino queste [le avarie o spese] consonto il profitto di due augumenti”. Per evitare il contrabbando, il prezzo del sale in ogni paese deve essere proporzionato al prezzo ne’ paesi confinanti, accostandosi ai prezzi del vicino che lo ha più tenue per impedire che il sale entri di là nello Stato, e tenendosi al disotto dei prezzi più elevati d’altri paesi di quanto basti per invitare il sale entrato di contrabbando ad uscirne di nuovo per andare ad angustiare altrui. A questo punto di vista nulla ha da temere lo Stato sabaudo dalla Francia, dove il sale è venduto al prezzo di 4 soldi, 8 denari e 3 grani la libbra, dove i contrabbandieri si sostengono con difficoltà grande e donde non hanno interesse a recarsi in Piemonte. Più pericoloso è lo Stato di Milano, non perché il sale vi si venda a poco prezzo dalla gabella, ma perché le leggi non vi sono osservate; e se gli Editti danno sempre molto alle gabelle, poco ne esigono”; tanti sono i differenti modi di vendere sale all’ingrosso e al minuto, le onoranze e le franchigie, che il consumo si riduce quasi a nulla, non praticandosi sovratutto la ferrea norma dell’obbligo della levata di una certa quantità di sale. Pericolosissimo è il Genovesato, dove il Governo, o in sollievo del popolo, o per rifarsi co’ guadagni del contrabbando in Piemonte del poco profitto ottenuto in paese o per impedire il profitto del più potente vicino, vende il sale à in soldo la libbra, sicché, allettato da tanta differenza di prezzo, e assistito dai Feudi imperiali privilegii, il sale di là non misuratamente bensì con “impeto ed irruzione” si riversa nel Piemonte.
Un rimedio si impone: s’è veduto che “le più gravi pene estese sino alla morte, non hanno valuto a contenere la libertà de’ sfrosadori si temerari a venire di pieno giorno armati e con insulto alli corridori”. Uopo è togliere la causa, ossia il grosso profitto che i contrabbandieri hanno, a comprare il sale a L. 1.5 il rubbo nel Genovesato, trasportarlo in cinque giorni nei luoghi di spaccio in Piemonte con una spesa di L. 0.12.6 e venderlo a 3 lire al rubbo, con notevole discapito delle gabelle che lo vendono a 5 lire; ma con guadagno proprio di L. 1.2.6 il rubbo. Occorre che il prezzo sia ridotto a 3 soldi per libbra dalle gabelle piemontesi, tanto nelle antiche provincie, quanto nelle provincie di nuovo acquisto, dove il sale si vende, nell’ Alessandrino, all’ingrosso a soldi 3.11.5. al minuto a 4.3.8.3, nella Lomellina all’ingrosso a soldi 3.6, al minuto a soldi 3.9.2.2, nel Monferrato di qua dal Tanaro a soldi 2.7.11.4, di là dal Tanaro a 2.6.11.8, nelle terre privilegiate a soldi 1.8, e nella Val di Sesia a soldi 1.6 2/11. Toltine questi ultimi, tutti gli altri paesi dello Stato s’avvantaggeranno da un pezzo uniforme di 3 soldi la libbra; e sarà tolto la spinta al contrabbando tra i paesi con termini col Monferrato e colla Valsesia. Scomparirà anche il contrabbando col Genovesato, perché i frodatori, a cui il sale costa nei luoghi di consumo L. 1.17.6 il rubbo si troveranno di fronte alle gabelle che invece di vendere il sale a 5 lire il rubbo lo venderanno a L. 3.15 il rubbo; e se essi prima per allettare i compratori aveano bisogno di un’esca di 9 lire per rubbo, appena sufficiente a far tacere il timore della pena, n’avranno pur bisogno in seguito; ma se vorranno ancora vendere a due lire meno il rubbo del prezzo di gabella, dovranno ridursi a 1 lira e 15 soldi, prezzo nemmeno sufficiente a pagare le spese. Diminuirà quindi il margine di guadagno per i contrabbaudieri; e mancando l’esca, la frode verrà da sé medesima a cessare. “Il naturale” dice il magistrato camerale, “che toltane la maggior parte del guadagno allo sfroso, divenga timido e più circospetto al rigor delle pene, e se del tutto non cessa, almeno si restringa” né si avanzi oltre ai paesi limitrofi al confine col Genovesato.
Era tutto un elegante problema di guadagno di monopolio che veniva posto nella relazione che stiamo esaminando: trovare quel prezzo che in rapporto alla quantità consumata, ai pericoli di svegliar l’uso dei surrogati (sale di contrabbando) valga a dare un massimo guadagno netto alla gabella monopolista. Il problema lo si era risolto quasi sempre aumentando empiricamente i prezzi. Il nostro scrittole vorrebbe che si facesse un tentativo nel senso inverso; ed a noi sembra che i suoi consigli avrebbero potuto essere attuati con successo. Il fiorire del contrabbando provava che il consumo poteva crescere ancora, e profittare al fisco invece che ai privati. Ma non si vollero rompere le consuetudini che stabilivano diversità di prezzo tra i diversi paesi dello Stato; e forse non si osò diminuire anche questo tributo in un momento in cui si aspettava la fine della guerra per togliere i tributi straordinari.
Insieme al contrabbando riducevano il reddito del sale le molteplici esenzioni da troppa gente pretese, massime per la poca chiarezza degli ordinamenti. Il meglio sarebbe stato l’obbligar tutti al pagamento della gabella, salvo a dare un abbuono a coloro, i quali dimostrassero davvero un diritto all’esenzione, come già si faceva per la gabella sulle carni e sui corami. La regola – soggiungeva l’anonimo magistrato – deve essere in generale quella della semplicità e della uniformità: una tariffa chiara e trasparente giova assai più all’interesse della finanza delle complicazioni e dei segreti invalsi dappertutto dove si vogliono favorire certuni a scapito dell’universale. Veggasi l’esempio della Spagna, dove le leggi gabellarie sono un segreto gelosamente conservato: “Ciò che ha perso prima alle Spagne gli uomini d’affari, poi alli suoi Monarca per anco le Gabelle è stato quel genio di mistero introdottosi da Ministri, li quali maneggiavano li Redditi Regi come sagramenti, li quali non soffrissero d’essere conferiti, né rivellati, e ciò per restare soli nella confidenza e senza censura gli arbitri di tutte le disposizioni del Regno, a segno tale sia succeduta una piena ignoranza ne’ sostituiti all’amministrazione, un’intiera ed universale inabilità negli ordini subalterni; in assistenza indi al maneggio per necessità associate le industrie de’ Genovesi, è a questi riuscito di trasportare nelle Spagne la povertà del Genovesato, e di cumulare in Genova li copiosi tesori delle Spagne”. Il segreto in materia di tributi è sinonimo di abusi e malversazioni: Oltre l’essere una vanità spagnuola di prettender segreto ciò, che è in evidenza palese, o sovente un’affettazione, di cui si vagliono (o per dire più modestamente) valer si possono le libertà del Maneggio a non potere essere redarguite negli abusi, nelle connivenze, frodi e malversazioni più difficili ad essere pratticate, quando sono più esposte; le soggezioni pubbliche e singolarmente quelle, le quali vengono imposte da magistrati provvisti di maggiori avvertenze e cognizioni, quanto sollevano il Sovrano di quelle minute applicazioni d’ogni minor suo interesse, altrettanto assicurano il Maneggio di quelle facilità le quali, egualmente per naturale o di nascosto con più di condiscendenza si danno alli parenti, alli Amici ed a quelle miunte passioni di Regalli, de’ quali taluni non ne sono spogliati”. Parole le quali dimostrano come già durante la guerra avessero fatto strada nelle coscienze dei più eletti Magistrati le idee che ebbero durante la pace loro effettuazione colle riforme contabili ed amministrative del 1717 e del 1730.
5. Andavano sotto il nome di “Tratta e Dugana” parecchi dritti che di comune aveano l’essere esatti sulle merci durante il trasporto che se ne faceva. Primo di tutti il dritto della dogana.
Variamente modificata dalla sua prima istituzione nel 1563 ed a grado a grado resa più severa, la dogana era oramai lungi dalla Primitiva semplicità di un dazio uniforme del 7, del 6 e poi del 3 per cento sul valore delle merci introdotte in paese. Specificate le voci doganali e soggette le merci ad un diritto commisurato a peso od a numero, le voci colpite da un dazio specifico erano aumentate a poco a poco e da 280 circa nella tariffa del 1633 erano cresciute sino a circa 600 nella tariffa stabilita coll’editto 8 maggio 1702, oltre a circa 35 per cui il dazio percepivasi nella misura del 6 e del 3% (D. – XXIV. 2009). Secondo quest’editto, che reggeva la materia dal 10 gennaio 1704, il dritto della dogana colpiva tutte le merci che s’introducevano per via di terra e di mare nei paesi di qua da monti e colli, ossia nelle 12 provincie piemontesi, tanto dall’estero quanto dagli altri paesi dello Stato, Savoia, Aosta, Nizza ed Oneglia. Lira questa una singolarità derivante dalle antiche consuetudini, dalla resistenza che opponevano alla nuova gravezza le regioni sino allora esenti e dalla maggiore facilità di reprimere il contrabbando sui confini del Piemonte proprio. Si aggiunga che in tempo di guerra Savoia e Nizza facilmente erano occupate dai Francesi; sicché l’essere già in pace la dogana esatta ai confini delle Alpi toglieva ogni questione sull’origine delle merci e sulle pretese immunità dei paesi appartenenti in diritto alla Corona, sebbene di fatto sottomessi a’ nemici. È vero che con ordine del 2 dicembre 1698 erasi stabilita la dogana in Savoia; ma colpiva le merci provenienti dall’estero e che si consumavano in quel paese, senza per nulla pregiudicare la dogana piemontese sulle merci che dalla Francia e dalla Savoia medesima venivano a noi attraverso le Alpi. In quei primi anni il reddito si manteneva modestissimo, prevedendosi nei conti del tesoriere di Savoia un’entrata di appena 12 mila lire.
Al principio che la dogana dovesse colpire tutte indistintamente le merci introdotte nel Piemonte facevansi alcune eccezioni. A non voler dire dell’esenzione dei cuoi, sottoposti invece al dritto dei corami, eranvi esenzioni volute dai riguardi verso i consumatori, come quelle per le granaglie, i marsaschi, i carboni ed i legnami non indicati espressamente in tariffa. Non pagavano neppure le vesti, le tappezzerie, le gioie ed i mobili introdotti senz’abuso dagli ambasciatori dei Principi stranieri e da altri gentiluomini che venissero ad abitare negli Stati del Duca per uso proprio e delle loro famiglie. Ma ad evitare abusi facili, assolvevano, salvo rimborso, i dritti comuni le merci introdotte per uso delle corti del Duca e dei Principi del sangue. Per ragioni militari erano esenti i cavalli, le armi, bagagli, i vestiti, le stoffe ed altre cose destinate al servizio degli ufficiali dell’esercito e della soldatesca; e così pure le munizioni da guerra, le polveri ed i piombi, i solfi ed i salnitri destinati ad uso di guerra. Una concessione alle idee economiche dei tempi può considerarsi l’esenzione data alle monete d’oro e d’argento introdotte anche a scopo di commercio, ed alle verghe di metalli preziosi destinate alla zecca. Per favorire l’agricoltura e la pastorizia montanina non pagavano dazio i buoi, le pecore e le capre; e per promuovere le manifatture si concedeva la franchigia alle sete, alle lane, ai cotoni, ed alle pelli crude e secche introdotte da coloro che, possedendo “tellari et ingegno” volessero a queste materie prime mutar forma nel paese. Per special privilegio l’università delle arti di Chieri avea diritto di introdurre 1200 balle di cotone in franchigia ogni anno, salvo alla Camera dei Conti di conceder l’introduzione libera di una maggior quantità, quando ciò fosse richiesto dai bisogni dell’industria.
Del dritto di dogana faceva parte il diritto detto dell’”entranea grassina” a cui dovevano essere unicamente soggette le materie grasse; ma la tariffa comprendeva in queste, oltre il burro, il formaggio, l’olio, le olive, il lardo, il sapone, anche i pesci, le frutta, i fiori, i maccaroni, i tartufi, la maiolica fine ed i vetri lavorati.
La tariffa doganale accrescevasi a quando a quando di voci che prima erano soggette a privativa dello Stato, privativa che giudicavasi poco conveniente di continuare. Così nel periodo studiato la privativa dell’osso di balena, istituita nel Piemonte con ordine del 23 agosto 1664 (D. XXIV. 382), era abolita, come appare dal capitolo 15 della tariffa del 1709, il quale ne dichiara liberi l’introduzione ed il commercio, sostituendo il monopolio con un dazio d’entrata di una lira per libbra (D. XXIV. 2012). Il monopolio del sapone, istituito con memoriale a capi del 5 dicembre 1649 in tutti gli Stati di qua e di là da monti e colli, escluso soltanto il Ducato d’Aosta (D. XXIV. 317) aveva dato luogo a lagnanze vivissime da parte dei commercianti e degli industriali. Pessima la qualità del sapone venduto dai concessionari della privativa, impossibile digrassare a sufficienza le stoffe e manifatture di seta, sicché non riuscivano atte a ricevere i colori pia fini. Di qui l’editto 17 dicembre 1700 il quale dichiarava libera la introduzione del sapone, e liberi i mercanti, tintori, ecc., di usare sapone di qualsivoglia qualità, purché entrando negli Stati di qua da monti e colli il sapone assolvesse il dritto doganale compenetrato con quello della grassina di 2 lire per rubbo (D. XXIV. 335). La Camera dei Conti di Piemonte, a cui l’ordine fa presentato per l’interinazione, fece suoi calcoli sull’ammontare del reddito del monopolio abolito (L. 8.500 all’anno) e sull’altezza del dritto doganale che vi si sostituiva; e trovato questo eccessivo, lo ridusse a L. 1 e 10 soldi per rubbo. Ad evitare però danni all’erario volle che il nuovo regolamento durasse solo per tre anni dal 1701 al 1703, passati i quali la Camera avrebbe provveduto continuando nel nuovo sistema o ritornando all’antico[25]. Lo sperimento sembra abbia dato buoni risultati perciò nell’istromento d’appalto ad Olivero e gamba deI 28 marzo 1703 il dritto del sapone rimane incorporato nella dogana.
A dare un giudizio della gravezza della tariffa doganale del 1702 sarebbe d’uopo sapere di tutte le merci esposte in tariffa il prezzo corrente a quei tempi; notizia non agevole ad acquistarsi data la mancanza di statistiche dei prezzi e la non necessaria rispondenza delle voci. Basti qui il notare che l’intento della dogana doveva essere essenzialmente fiscale se per le merci non elencate nella tariffa, e per cui non si trovasse in altre merci simiglianza di qualità e di prezzi, il dazio era del 3%, trattandosi di materie greggie e del 6%, se di manufatti, sul valore di stima diminuito del 13%. Dell’indole della tariffa, fanno fede i dazi per capo di L. 14.8.5 (L. it. 18.03) sui cavalli di Regno berberi e spagnuoli, di L. 13.19.1 (L. it. 17,45) sui cavalli di Germania, d’Ungheria e d’Italia, di L. 3.8.10 (L. it 4,30) sui cavalli e cavalle del Delfinato, oltremontani e circonvicini, di L. 7.5 (L. it. 9,35) sui muli e le mule, e di L. 1.4.2 (L. it. 1,51) sugli asini. L’aumento maggiore colla tariffa del 1702 erasi dato alle sete lavorate e ai lavori in seta per dare impulso alle manifatture paesane. Non sempre alle intenzioni protettive rispondeva l’iniziativa dei produttori; onde nel 1708 si parla di ridurre i dazi sui lustrini di seta, dei quali malgrado che in paese non se ne fabbrichi alcuno, e le notizie doganali sembrino indicare un’entrata nulla dall’estero, “se ne vede per altro un gran uso” con prova chiarissima che il dazio eccessivo favoriva il contrabbando[26]. Ma per quanto forse non gravissima, la dogana era fastidiosa ai commercianti per le noie a cui li sottoponeva, le gravi pene comminate ai contravvenenti: perdita delle robe, multa del doppio valore di esse, perdita delle bestie e dei carriaggi; e nel caso di forestieri e nullatenenti, quando le robe sequestrate concedessero il valore di L. 181.5 (venticinque scudi d’oro) “due tratti di corda da darsegli in pubblico, havuto riguardo alla qualità delle persone e circostanze de casi”.
Il dritto di tratta colpiva le merci gregge e manufatte, che uscivano dalle provincie piemontesi per andare all’estero o nelle provincie transalpine o transapenniniche, e le colpiva anche se fossero merci straniere introdotte prima in paese per esservi manufatte e riesportate. Dovevano pagare la tratta, sebbene in minori proporzioni, anche lo merci di Nizza e d’Oneglia che venivano esportate all’estero; e così pure le merci esportate dallo scalo di Nizza, malgrado i privilegi del porto franco. Risulta tuttavia dai conti dei tesorieri e dei gabellieri che il diritto della tratta foranea era stato condonato ai Nizzardi e facevasi per tal ragione un abbuono di 25 mila lire all’anno ai gabellieri generali. Restituivasi il dritto di tratta a coloro che conducevano mercanzie e bestiami a fiere e mercati forestieri, per ciò che non riuscivano a vendere; e così pure a coloro che mandavano all’estero materie greggie da conciare o in altro modo lavorare, quando i manufatti rientrassero in paese. Le granaglie che avrebbero dovuto pagare 4 soldi per emina per il grano, 3 soldi per la segala, 2 soldi per i marzaschi, in realtà da più di 40 anni nulla pagavano, perciò s’era lasciato cadere il dritto in dissuetudine; acciocché i proprietari delle pianure piemontesi potessero esportare il grano negli anni di abbondanza, in cui il prezzo interno bassissimo non avrebbe dato loro modo di paga il tributi. Il grano, insieme col bestiame e colla seta, era uno dei principali generi di esportazione; ed il gravarlo di un dazio d’uscita troppo ne avrebbe fatto rinvilire i prezzi. Quando i prezzi crescevano, per la fallanza dei raccolti, subito si vietava la tratta, come si fece nel 1709, 1710 e 1711. Il grano inoltre forniva un carico di ritorno per i conducenti che portavano in Piemonte i sali del Genovesato, riducendone con il costo di trasporto[27].
Gli abusi nella tratta erano grandi specialmente per il bestiame e le seta[28]. L’abitudine di portare il bestiame a pascolare durante la state sulle Alpi dava facilità al contrabbando che si esercitava attraverso il Mondovì verso il Genovesato. Stabilivano bensì gli editti che i pastori forestieri portando buoi, mucche, pecore, capre, montoni, ecc. a pascolare nelle Alpi nostre ed a svernare nelle pianure piemontesi, dovessero dichiarare alla prima posta (luogo di dogana) il numero e la qualità del gregge, salvo a pagare al ritorno la tratta sull’accrescimento in vitelli, agnelli, burro, formaggio, ecc. Potevano gli appaltatori obbligare i proprietari di buoi grassi a farne ogni anno la consegna, ed a pagare subito sette lire a testa, salvo a versare a’ doganieri il rimanente del dritto di tratta se non provavano che già era stato pagato dal compratore forestiero, o che il dritto non era dovuto per essere i buoi stati consumati sul luogo o ivi morti per disgrazia. Ma queste ed altrettanti disposizioni stabilite per il commercio con i paesi posti entro cinque o dodici miglia dal confine vessavano i contribuenti più che non fruttassero al fisco.
Per le sete, a causa del loro piccolo volume, i guai erano maggiori. Non era raro il caso che si portassero di nascosto nel Monferrato nuovo (Casale ed Acqui), perché essendo questo considerato, anche quando divenne soggetto a Savoia, paese forestiero, le sete che di là passavano in Piemonte dirette oltr’alpi non assolvevano il dritto di tratta, sebbene un altro dritto, il dacito di Susa, assai più leggero. Di qui norme minuziose per obbligare tutti gli agricoltori alla consegna del seme messo in incubazione, dei bozzoli ottenuti e delle sete filate, e per obbligarli al pagamento della tratta quando non dimostrassero la vendita od il consumo in paese. Erano fissate le strade che bozzoli e sete doveano percorrere per recarsi all’estero, punito il traffico con i luoghi di confine, imposto il giuramento solenne mercanti del Monferrato di non trasportare sete provenienti con frode dal Piemonte.
Qualche esenzione era concessa alle cose condotte o ricavate da Nizza, Oneglia, Barcellona, Monaco, Cocconato, ed altri luoghi privilegiati; ed erano codesti favori causa continua di querimonie, poiché l’esenzione limitavasi al consumo ed alla produzione locale, mentre gli abitanti se ne volevan servire per commerci frodolenti.
Si applicava la tratta ad un numero di voci minore di quello contenuto nella tariffa doganale, ma per queste avea carattere più rigidamente proibitio, avendosi di mira, secondo i concetti del tempo, di impedire l’estrazione delle materie prime che potevano essere lavorate in paese o del bestiame e vettovaglie necessarie al consumo del paese. La seta cruda pagava infatti L. 1.9 per libbra, quando la seta lavorata pagava soltanto L. 0.14.6 e il damasco, il velluto ed altri panni di seta pagavano L. 0.7. I buoi, esenti, come vedemmo, dalla dogana, pagavano invece per la tratta L. 16.8.8 per capo se valevano più di 40 lire, L. 13.8.3 se valevano da 30 a 40 lire e L. 13.1 se il valore n’era inferiore a 30 lire. Le mucche pagavano L. 6.0.3 se il valore n’era superiore a 20 lire, L. 4.7.7 se da 12 a 20 lire, L. n. 15.5 se da 6 a 12 e IL. 2.4.9 se valevano meno di sei lire per capo. Dazi non esigui, ragguagliati a circa il terzo del prezzo corrente. I cavalli pagavano meno, non essendo forse considerati necessari per l’agricoltura: quelli di valore maggiore di 25 scudi d’oro d’Italia d. 181.25) pagavano L. 7.6.10, ossia dal 3 al 4 per cento del valore: se di minor prezzo L. 3.2.10. Non pare che le tariffe fossero esattamente osservate se nei congressi tenutisi nel 1708 per la riforma delle gabelle si osservò che il dazio dei buoi di valore superiore a 40 lire non s’era mai pagato nella sua integrità; e concludevasi colla proposta di tassarli in L. 12 se di valore superiore a doppie 8 (lire 126), L. 10 se d’un valore da doppie 5 ad 8 (L. 78.15 a 126) e L. 8 se d’un valore inferiore a doppie 5 (L. 78.15). Necessariamente i buoi d’un valore minore doveano pagare ancora meno[29].
Oltre alla tratta, le canape greggie e lavorate pagavano il dritto della decima; e le tele, fili e cordaggi il dritto della vigesima. In realtà ambedue i dritti erano regolati secondo apposita tariffa. Una soma di lino che di tratta pagava L. 6.8, pagava di vigesima L. 17.8; una soma di canapa pettinata oltre alle L. 4.3.5 di tratta pagava L. 11.11.5 di decima. Se i dritti specifici erano veramente del decimo o del ventesimo del valore, chiaro come i dritti della tratta usavano contenersi in proporzioni minori.
Affine alla tratta era pure il dritto di un per cento che pagavano gli ori ed argenti greggi e lavorati, le pietre preziose, le gioie, le perle, ecc., che uscivano dallo Stato o per esso transitavano provenendo da Stati esteri. È dubbio se questo dritto rendesse assai al fisco, perché le esenzioni erano numerose: esente ogni viaggiatore sino all’ammontare di 50 scudi se a cavallo, di 30 scudi se a piedi; esenti in tutto i nobili ed i gentiluomini dello Stato che uscissero dal paese e poi vi facessero ritorno; ed anche i gentiluomini d’altri Stati che facessero passaggio da noi per tutto ciò che “secondo il grado e la condizione loro ne sogliono e possono portare per ornamento et honore delle loro persone”; esenti i denari inviati agli ambasciatori e agenti del Duca all’estero o mandati fuori Stato per servizio pubblico delle finanze, zecca e gabelle; esenti i denari inviati da Francia, Spagna e Svizzera per conto del Re Cristianissimo, di S. M. Cattolica, e dei collegati Svizzeri e Vallesani; esenti Nizza ed Oneglia, ecc., ecc. I pericoli di frodi a causa di tutte queste esenzioni erano tali che il dritto dell’1 per cento di fatto negli anni nostri si riduceva per tolleranza ai due terzi; ed anzi per gli ori ecc. di transito si percepiva soltanto in ragione d’un quarto del dritto legale[30].
Non contento di colpire le merci che entravano od uscivano dallo Stato, voleva il fisco trarre vantaggio dal commercio di transito, imponendo diritti sulle merci estere che toccavano qualche punto del territorio dello Stato. Quattro erano i diritti principali che imponevansi per tal rispetto: il dritto del transito di tratta, il dacito di Susa, il dritto di portofranco di Nizza ed il dritto di Villafranca.
Al transito di tratta erano soggette tutte le merci che toccavano gli Stati di qua da monti e colli per andare da uno Stato estero ad un altro, senza però passare i monti ed i colli. La tarifia era poco specificata, e si teneva alquanto pia bassa di quella della tratta. Le voci non elencate pagavano il 3 per cento del valore.
Il dacito di Susa, antichissima fra le entrate doganali nostre, colpiva le merci le quali venendo d’oltremonti andavano in Italia, o venendo d’Italia andavano oltremonti. Noto sin dal secolo XIV, questo tributo fruttava assai in un tempo in cui la scarsezza delle strade e gli ordinamenti economici dei sovrani di Francia imponevano a tutte le merci provenienti dall’ Italia di transitare per Susa; onde nel 1563 era stato appaltato per 28 mila scudi d’oro all’anno. Ma le lotte tra i Re di Francia ed i Duchi di Savoia, la rivalità degli Svizzeri, il desiderio dei Milanesi, dei Genovesi e dei Veneziani di emanciparsi dal forzato passaggio per il Piemonte, aveano fatto ai nostri tempi scadere assai il reddito del dacito di Susa. Altre strade: di Collonges per il Chiablese ed il Sempione, di Collonges per il paese di Vaud, e di Dortan, facevano una concorrenza spesso vittoriosa al passaggio di Susa, il quale avea a suo favore il vantaggio della maggior brevità del tragitto da Lione a Milano e Genova. Il colpo di grazia fu dato coll’ordinanza 25 novembre 1696 del Consiglio di Stato del Re di Francia, la quale permise ai mercanti di Lione di transitare, andando e venendo le merci d’ Italia in Francia, per le strade di Dortan e del Sempione senza toccare gli Stati di Savoia (D. XIV. 1653). Alte strida levarono i Duchi di Savoia pretendendo che l’art. 6 del trattato di pace di Torino del 29 agosto 1696 obbligasse i Re di Francia a mantenere al valico di Susa il monopolio del transito d’Italia in Francia e viceversa, come prima della guerra del 1690; mentre i francesi replicavano d’essere obbligati soltanto a ristabilire la libertà del commercio interrotta dalla guerra, senza perciò impedire altrui di trafficare per altre vie[31]. La contesa durava ancora quando scoppiò la guerra di successione spagnuola; né fu composta mai[32]. Negli anni nostri perciò il fisco dovea rimborsare agli appaltatori somme cospicue per la mancanza quasi che intiera d’ogni reddito del dacito di Susa. S’era pensato a mettere un ufficio alla Novalesa, più comodo ai conducenti obbligati a passare a Susa per levare le bollette dei pagamento del dacito; s’era raccomandato di usare larghezze ai Genovesi per incitarli ad abbandonare la via del mare ed a preferire il valico di Susa; ma poco frutto da siffatti accorgimenti si ritrasse. Sempre allo scopo d’evitar le frodi si faceva pagare il dacito di Susa anche ai ferri, acciai, risi, canapa e carta, prodotti nel Piemonte ed esportati oltremonti; ma ne nasceva l’effetto che queste merci gravate anche dalla tratta non potevano con profitto esportarsi e doveano essere vendute in paese.
Non più fruttifero era il terzo dei dazi di transito, e cioè il dritto del portofranco di Nizza. Da lungo tempo i reggitori piemontesi cercavano di promuovere i traffici del portofranco di Nizza; ed uno dei mezzi più efficaci fu sempre la diminuzione dei dazi di transito. Perciò le robe e mercanzie di Germania, d’Italia e d’altri Stati esteri, destinate alla Francia, Spagna, ecc., e quelle francesi, spagnuole e d’altri Stati esteri dirette a Germania e Stati italiani e stranieri, quando transitassero pel Piemonte, facendo scalo a Nizza, pagavano il diritto del portofranco di Nizza, che era ragguagliato in generale ad un terzo del dacito di Susa. Anzi le consuetudini volevano che le importazioni in Piemonte, se fatte pel Nizzardo, godessero d’un abbuono del quarto sulla dogana; e le esportazioni piemontesi all’estero d’un terzo sulla tratta, sempre se avvenute per loscalo di Nizza. La tariffa del 1702 abolì questi ultimi favori; ma è da presumersi che di fatto continuassero.
Ultimo dei dazi di transito che si potrebbero chiamare internazionali era il dritto di Villafranca. Colpiva le merci che passavano dalla rivieri di ponente a quella di levante e viceversa, tanto per mare che per terra, qualunque fossero le nazioni a cui i bastimenti appartenevano. Il limite geografico era dato dalle isole di St. Pierre, situate fra la Corsica e la Sardegna; sicché tutte le navi che passavano al di qua erano soggette al diritto. Pel commercio della riviera il dritto di Villafranca sostituiva il transito di tratta, il dacito di Susa e il dritto del portofranco; ma era più tenue, ragguagliandosi al 2 per cento del valore delle merci. La maggiore facilità di sottrarvisi aveva consigliata siffatta mitezza di tariffe; ma non era bastata, poiché i finanzieri nostri di continuo si lamentavano che i francesi non volessero sottostarvi se non quando le loro navi facessero effettivamente scalo a Villafranca od a Nizza, mentre i nostri pretendevano che il fatto solo di passare in faccia alla costa nizzarda obbligasse le navi a venire al porto di Villafranca a sottomettersi alla visita. Ed ancor più si lamentavano che l’oltrepotenza francese avesse incoraggiato i sudditi del Re di Spagna (spagnuoli, napoletani, siciliani, quei di Finale) a far altrettanto, gli abitanti di Monaco a sottrarsi anch’essi al dritto di Villafranca, pur facendo pagare il dritto di Monaco a’ nizzardi ed onegliesi; e, quel che peggio, avesse inorgoglito per modo i genovesi – che erano sempre stati i più forti pagatori di tal dritto, sia per la loro vicinanza, sia pel gran traffico mantenuto con la Spagna, la Francia ed il Portogallo – per modo da indurli a far passare loro barche più grosse al largo, sotto bandiera e con padroni francesi[33].
Il dritto, che ai suoi bei tempi avea reso più di 100 mila lire l’anno, ora s’era ridotto talvolta a meno del terzo e minacciava di scendere ancor più. Durante tutta la guerra le cose andarono di male in peggio, essendosi l’esazione ristretta al solo approdo di Oneglia. Colla pace di Utrecht, essendosi stipulato che le navi francesi dovessero pagare il dritto senza alcuna opposizione, tornò il dritto di Villafranca a rifiorire. Che le contese non cessarono, sinché la Camera di Commercio di Marsiglia non s’obbligò nel 1726 a pagare un canone di 40 mila lire all’anno al Re sardo, ottenendo in cambio l’esenzione dal dritto di Villafranca per le navi battenti bandiera francese (D. XXX. II, 511).
Rientravano talvolta nella categoria della “tratta e dogana” anche alcuni dazi locali d’introduzione in certe città di transito attraverso peculiari distretti, che si veggono spesso nei bilanci generali e nei conti dei tesorieri, indicati sotto il nome di gabellette, che vuol dire gabelle minute non date in esercizio agli appaltatori generali, ma a piccoli appaltatori locali o ad economi per conto delle Finanze. Vi accenniamo qui, benché si tratti di redditi non compresi sempre nella categoria delle gabelle generali, per l’evidente connessione della materia; e per dimostrarne l’indole, diciamo di alcuni di essi.
Il dacito di Vercelli (D. XXIV. 2074) esigevasi su tutte le robe, mercanzie, bestiami, grano, riso e vino che dall’estero o dall’interno si introducessero nel distretto e Diocesi di Vercelli; e sulle merci che di qui si esportassero all’interno od all’estero. N’erano colpite anche le merci nazionali ed estere transitanti pel territorio vercellese, e quelle che, navigando sul Po, passassero sotto Verrua. Andavano esenti dal pagamento di questo balzello nobili e gentiluomini di diverse terre e casate, abitanti di luoghi privilegiati, per i consumi personali; quei di Biella e d’Andorno per il transito. Non era grave il diritto di transito di L. 3 per i cavalli e i muli, soldi 15 per gli asini, 3 soldi e denari per i maiali grossi, 2 soldi e 6 denari per buoi, manzi, mucche, ecc., 11 denari per i vitelli; 2 denari per i montoni, pecore e capre, 1 denaro per gli agnelli e capretti, 2 denari per ogni emina di castagne, , denari per un’emina di frumento e riso. I diritti di importazione e di esportazione: d. 2 per emina di castagne, d. 2 1/2, per emina di frumento e riso, d. 2 per ogni rubbo di burro, lire 3 per i cavalli e muli, soldi 15 per asino, soldi 3 d. 9 per i maiali grossi, soldi 2 d. 7 per i buoi di valore maggiore di L. 72.10, soldi 1 d. 7 per i buoi del valore da L. 36.5 a L. 72.10.
Il dacito di Trino (D. XXIV. 2007) colpiva tutte le robe, mercanzie e bestiami che transitavano per Trino ed altre località vicine del Monferrato, venendo dal Piemonte o da Francia e dirette in Italia o viceversa, come pure n’erano colpite le merci che si esportavano da quei luoghi pel Piemonte o l’estero, o che di qui vi si introducevano. Eranvi certe strade su cui nessuna merce poteva circolare senza aver pagato il dacito di Trino, a meno che provassero d’essere invece soggette al dacito di Susa e d’averlo pagato. Anche qui si trattava di diritto stabilito con tariffa poco elevata[34].
Il pedaggio di Carmagnola, appaltato sino al 1703 per L. 2060 all’anno e dopo per L. 1400, esigevasi sulle robe, mercanzie e bestiami transitanti sul territorio carmagnolese. La tariffa fissata nel 1688 e confermata nel 1704 (D. XXIV. 1307) era tenue: 10 denari sui buoi grassi, cavalli e muli, 5 denari sui vitelli, 1 soldo ed denari ogni trenta pecore o capre, ecc., ecc.
Il pedaggio di Ivrea, appaltato in L. 2000 fino al 1706, L. 3900 dal 1707 al 1709 e 3150 dopo il 1710, era esatto sulla base di una tariffa del 1648 (D. XXIV. 1372), anch’essa moderata.
Il pedaggio di Vico, appaltato negli anni nostri da 115 a 180 lire all’anno, difficilmente avrebbe potuto render di più, se si pensa che ogni bue pagava 10 denari, i cavalli, muli ed asini 6 denari; ogni carro di vino 10 denari (circa 1 centesimo di lira italiana d’adesso per ogni ettolitro) e le altra voci, 21 fra tutte, a proporzione (D. XXIV. 1347).
Non era dunque la gravezza dei dazi locali che recava fastidio ai commercianti ed ai produttori; sibbene la loro molteplicità. Ai dazi e pedaggi che abbiamo sopra brevemente dichiarati, se ne aggiungevano invero infiniti altri, esatti dalle città o comunità, dai feudatari o da privati a cui erano stati venduti dal fisco. La città di Cuneo esigeva, ad esempio, una gabella delle mercanzie così minutamente elaborata che il testo della tariffa del 1716, diminuita su quelle precedenti per favorire il traffico coi porti di Nizza e di Villafranca, occupa ben 22 pagine in folio dell’edizione del Duboin (D. XXIV. 1323). Questo era il difetto, maggiore del sistema daziario di quei tempi: la sopravvivenza di tutti i pedaggi sorti nell’epoca dello sminuzzamento feudale della sovranità. Le riduzioni monetarie avevano bensì a poco a poco corroso il valore dei diritti signorili, e l’apertura di nuove vie, le immunità concesse a certi trafficanti internazionali, la connivenza dei pedaggieri aveano ridotto l’importanza dei dazi locali, i quali oramai fruttavano assai poca cosa in confronto delle gabelle spettanti al Principe. Ma il fastidio delle visite frequenti, delle vessazioni minuziose dei piccoli appaltatori era vivamente sentito da coloro che dovevano subirle. Il nostro non era però tempo da riforme daziarie. La guerra, che ostacolava i traffici, impediva pur anco le esazioni e faceva fiorire il contrabbando.
Contuttociò, ancor prima fosse tornata la pace, il Principe, spinto dal Groppello, fastidito dagli impacci recati al commercio dalla oscurità delle tariffe, dalla molteplicità dai dazi e pedaggi locali, mosso anche dal desiderio di unificare al Piemonte le provincie monferrine e lombarde recentemente acquistate (cfr. sotto paragrafo 91), nominava, con R.B. dell’8 marzo 1709, una commissione composta del conte presidente Garagno, del mastro auditore Comotto e del patrimoniale provinciale Audifredi per studiare la riforma del regime daziario: “Riflettendo noi”, recita il R. B. a quei spedienti che suogliono influire al sollievo de nostri popoli, vediamo esser di non puoco riglievo quelli che puonno contribuire all’introduttione ed ampliattione del Comercio, col quale hanno non pocco rellatione il buon stabilimento delle manufatture, ed il fissare con ogni equità ed agiustatezza i dritti delle gabelle e pedaggi”. Dopo il qual proemio e dopo aver discorso della necessità di togliere impedimenti al commercio tra il Piemonte antico e le provincie di nuovo acquisto (cfr. il citato paragrafo 91), il Principe prosegue, con linguaggio che potrebbe anche oggi riprodursi in un trattato moderno sulla tecnica delle tari doganali: “Si formino nuovi Capitoli e Tariffe per l’esattione de’ Dritti delle Gabelle; riducendole in moneta hora corrente con togliere ogni oscurità od ambiguità, separando i capi, ne’ quali sono descritte diverse qualità di robbe, specifficando chiaramente ogni genere d’esse sottoposte a detti dritti, massime di quelle che non sono in dette tariffe nominate, e che solo si spiegano con la parola consimili o diverse, con l’espressione del giusto loro debito, in modo che non habbino d’hor in avvenire l’Accensatori o luoro Comessi alcun arbitrio, agiongendo indi quel di più, che si stimarà a proposito per ridurre ogni cosa in chiarezza tale, che possa essere a prima intelligenza d’ogn’uno”. Non accettabili al lume dei principii economici, ma rispondenti alla pratica universale di quei tempi, e prova che fino a quei giorni le tariffe daziarie aveano avuto intenti prevalentemente fiscali, sono le altre istruzioni che seguono, nelle quali si ordina ai commissari di studiare il modo come proteggere le industrie nazionali: Che si prendi un’intiera cognitione di tutte le manufatture stabilite nel Paese e si diano tutte quelle facoltà che si stimeranno più adeguate per mantenerle e ben stabilirle, sgravandole il più che sarà possibile di Dritti sin qui pratticati; dando un peso maggiore alle robbe che si faranno uscire da’ nostri Stati per farle manifatturare altrove; ed accrescendo i solliti dritti a quelle provenienti da Stati stranieri, che colla loro introdutione in questi per essere simili a quelle che qui si manufatturano ne rendono difficile lo smaltimento. Di non minore vantaggio saràil prendere un’esatta notitia di tutte le qualità delle cose che nascono né nostri Stati e l’accertar mezzi per darle esito ne’ Paesi stranieri col diminuire i dritti dell’uscita ed accrescere il peso a quelle di simile nattura che da’ Stati forastieri si vorranno introdurre in questi, sgravando poi viceversa il più che sarà conveniente i dritti di quelle rovine da quali questo Paese n’è privo e non ne abbonda per renderne agevole l’introduttione”. Rivolgeva poi il sovrano il suo pensiero al danno che i commercianti sentivano per la molteplicità dei balzelli locali e signorili e raccomandava alla commissione; “che si prendi per ultimo con ogni accuratezza quella maggior cognitione che si potrà della natura e qualità de Daciti e pedaggi che si esigono ne nostri Stati, tanto sopra le strade che sopra i fiumi, se in denaro o in natura ed a quali qualità di rovine o vettovaglie l’estendino, distinguendo quelli che appartengono al nostro patrimonio, da quelli che sono posseduti da’ vassalli o da’ terzi, e se da questi si godono abusivamente o con qualche fondamento di raggione, sovra quali tariffe sono in uso d’esiggersi i dritti d’essi, se questi non sono eccessivi, o pure non segue vessattione od estorsione in esigerli, affinché sovra tali nottitie si prattichino indi quei spedienti che saranno più proprii per abolire gl’abusi, sollevare i popoli e render più aggevole il traffico[35].
Unificare, nella misura del possibile, il territorio doganale dello Stato; perfezionare tecnicamente le tariffe doganali; togliere le asprezze eccessive e gli abusi dei pedaggi locali; concedere una maggior protezione alle industrie nazionali. Ecco gli intenti del programma riformatore piemontese in materia daziaria durante la guerra, quali risultano dal regio biglietto che sopra abbiamo riassunto; dei quali intenti, i primi tre sono da lodarsi senza restrizioni, rispondendo a necessità evidenti di sviluppo economico; e sull’ultimo non è agevole dare un giudizio, difettando per ora troppi elementi del calcolo economico, sociale e politico che dovrebbe istituirsi. Ai propositi di rinnovamento non risposero – almeno finché la guerra durò i fatti, da troppe altre necessità essendo premuto in quel tomo lo Stato; talché il giudizio, che sarebbe stato non facile sui fatti, diventa inutile rispetto alle intenzioni.
6. – Carni, corami e foglietta, era il titolo di un tributo sui consumi che stava di mezzo tra le imposte che oggi si chiamano di fabbricazione, e i dazi interni di consumo e di circolazione sulla carne, sui cuoi (“corami”) e sui vini (“foglietta”). Batteva il suo prodotto nel 1700 sulle 336.810 lire per il fisco, se non si tien conto del ricavo dei macelli di Torino, alienati alla città per un reddito di 80 mila lire l’anno per ottenerne un prestito nella passata guerra, e delle 55 mila lire di reddito delle due gabelle piccole pure alienate; nel 1710, malgrado che la guerra nuova avesse costretto il fisco ad alienare alla città di Torino la foglietta e l’imbottato esatti nella capitale per un reddito di lire 102.169.9.6 l’anno, il prodotto era cresciuto a 359.220 a norma degli ultimi subappalti: confortevole segno che dava indizio di non sminuita capacità di consumo, alle 360 mila lire circa incassate dal fisco regio, dovevansi così aggiungere 80 mila lire di prodotto presunto de’ macelli, 45 mila della foglietta, 57 mila circa dell’imbottato, e 55 mila lire delle due gabelle piccole dei soldi 2 per emina di grano e denari 2 per libbra di carne, tutte entrate alienate alla città di Torino, in pagamento di somme mutuate alle finanze, cosicché le carni ed il vino si può dire rendessero, verso la fine della guerra nostra, circa 600 mila lire all’anno[36]; prodotto tanto più ragguardevole, in quanto, fin d’allora, pure in mezzo ai tumulti della guerra, dava a differenza del sale e della dogana, di quella meravigliosa elasticità che lo doveva rendere in seguito vie più pregiato ai governanti. Il solo Piemonte vi era soggetto ai tempi di cui discorriamo; poiché Savoia, Aosta, Nizza, Oneglia per uno o per altro motivo, avean saputo sottrarvisi.
La gabella dalle carni importava 4 denari per libbra per le carini di qualunque specie venduta nei macelli; ma a Torino era assai più grave, essendosi con biglietto sovrano dei 20 ottobre 1634 permesso alla città di esigere una gabella addizionale di 2 denari per libbra di carne. Intorno a questa gabella detta piccola di denari per libbra, durò lunga controversia se spettasse al Principe od alla Città, e vi ritorneremo sopra discorrendo dei debiti contratti per causa della guerra, essendo stata tal gabella mezzo per ottenere dalla città una somma di ben mezzo milione di lire[37]. Pagavano ancora a Torino le bestie piccole, introdotte nella città per esservi macellate, un diritto di 6 soldi caduno gli agnelli se per uso dei macellai, di 6 denari se per uso dei privati: di 3 soldi a 10 denari i capretti per macellai, e denari i capretti per uso particolare. La testa di bestiame bovino assolvevano ancora un diritto di 6 denari caduna, e quella di maiale di denari 3 2/3.
Minuziose norme regolavano la materia per impedire che si traesse partito dalla esenzione o minore tassazione della bestie ammazzate per uso privato. Proibito ai macellai di ammazzare bestie senza averne prima fatta la consegna agli appaltatori a pagato il dritto. Teneva l’appaltatore le chiavi di ogni macello, per impedire che vi si introducessero e spacciassero carni in frode alla gabella. Obbligate le comunità civilmente, e i sindaci e consiglieri in proprio, a mantenere uno o parecchi macellai per la vendita delle carni necessarie in ogni luogo; e, in difetto, poteva l’appaltatore mettere su macello, a rischio della comunità. Della quale prescrizione giovavansi gli appaltatori talvolta per angariare la comunità e costringerla a pagare un canone d’abbonamento al dritto della carni, anche se era vano sperare di vendere carne ne’ macelli fatti aprire per forza alle comunità[38]. Ogni famiglia poteva uccidere per uso proprio, senza pagare il dritto delle carni, un maiale ed una vacca, oppure quattro pecore od anche quattro capre. Permesso a due famiglie dividersi tra loro un maiale ed una vacca, ma non più. Se per infermità o disgrazia occorresse ammazzare qualche bestia grossa o piccola, era consentito farla salare per uso privato, pagando soltanto il dritto dei corami; ma dovevansi riportare le opportune attestazioni.
La gabella dai cuoi o de’ corami, essa pure gradatamente cresciuta collo svilimento della moneta, era di 32 soldi per rubbo, ad era pagata dai maccellai e dai privati all’atto dall’ammazzamento della bestia, reputandosi per tal modo più efficace la sorveglianza. Era proibito agli “affaitori” (conciatori) di comprare pelli dai macellai o dai privati, i quali non consegnassero le bolle attestanti il pagamento del dritto de’ corami. Gli acconciatori non potevano togliere i cuoi dai fossi recipienti ove subivano la concia, senza averne ottenuto licenza dagli appaltatori e de’ consoli dell’arte o periti, nominati ex officio. A favorire l’industria delle concie, oltre queste diligenze, erasi proibita l’estrazione delle pelli e dei cuoi acconci, della “galla” e “crusca”, materie concianti. Era stato questo infatti il pretesto per imporre con l’ordine 4 febbraio 1585 il dritto dei corami: diminuirne il prezzo e migliorarne la qualità peggiorata dalla “malitia e stoltità che gli affaitori per l’ingordigia del guadagno usano nell’acconciare o vendere i corami… in gravissimo danno de’ nostri ben amati popoli” (D. XXIV, 1124). Proibita l’esportazione dei cuoi o delle pelli all’estero, ora giocoforza, si diceva, che i cuoi svilissero nell’interno; organizzata le maestranze degli acconciatori con opportuna vigilanza pubblica, la qualità sarebbe migliorata, sicché era ben giusto che i compratori pagassero un lieve balzello al fisco per indennizzarlo delle spese sostenute per impedire il contrabbando e sorvegliare la fabbricazione dei cuoi. Buone parole alle quali non avevano risposto i fatti, talché nel primo settecento di tutto ciò rimaneva solo il balzello: di 32 soldi per rubbo di “corami verdi” e 64 soldi per rubbo di “corami secchi”, sia provenienti da macelli pubblici o da privati, sia introdotti dall’estero o da Savoia, o da altre parti dello Stato nel Piemonte. Il dritto era raddoppiato per i cuoi secchi sia per il loro maggior lavoro, sia per favorire la lavorazione interna dei cuoi freschi. Le pelli verdi di vitello, pesanti meno di 8 libbre, pagavano s. 1 d. 8; le pelli secche s. 3 d. 4; le pelli di cavallo, muli, asini e porci s. 5 d. 4; lo pelli di montone e pecora lavorate nello Stato, se indigene, s. 1 d. 6, se forestiere s. 2 d. 6; le pelli di caproni e capre s. 5 d. 4; le pelli d’agnello d. 6, di capretto d. 2[39].
Abusi nell’esazione della gabella si erano introdotti, massime a causa dei macelli privilegiati di Torino. Erano cinque: quello del nunzio, il quale avea il diritto di ammazzare all’anno per 1080 rubbi di carne, dell’ambasciatore di Francia per rubbi 1440, dell’Albergo di Virtù per rubbi 1940, della guardia svizzera per rubbi 1440, della cittadella per rubbi 1080. Vi erano poi altri immuni, come il Gran Cancelliere e gli ecclesiastici. Il guaio grosso non era nelle esenzioni, perché queste erano state calcolato ed alla fin d’anno l’appaltatore restituiva ai privilegiati ed immuni le somme che essi avevano dovuto pagare durante l’anno: nei 12 mesi dall-1 ottobre 1699 al 30 ottobre 1700 erano state restituite L. 12.593.15.7, di cui 9600 agli ecclesiastici, i quali non avevano macelli propri e non potevano frodare. Ma stava nell’impossibilità di sorvegliare i macelli privilegiati, pretendendo il nunzio, l’ambasciatore francese, l’Albergo, ecc., di non voler soldati ne invigilatori ne’ propri edifizi; onde i macellai facevano un grande spaccio frodolento di carni a privati senza pagar la gabella, con un danno pel fisco di almeno 15 mila lire l’anno. Accadeva anche elio al contrabbando prestassero mano soldati della guardia e della fanteria, i quali maltrattavano gli invigilatori, obbligandoli a rilasciar bolle gratuite d’introduzione di bestie che si dicevano destinate a privati, ed invece pubblicamente spacciavansi, sovratutto d’inverno e durante il carnevale. Le minaccie di licenziamento dal servizio regio di tratti di corda a’ soldati ed a’ contravventori tutti a poco giovavano, sicché più e più volte si era proposto di abolire tutti i macelli privilegiati, mediante equa indennità[40].
La gabella de’ cuoi per un altro verso non poteva tutta esigersi, riuscendo per la sua gravezza nociva all’industria a cui impediva di procacciarsi la materia prima dall’estero mentre la rincarava all’interno, ed ai consumatori che spesso non potevano nell’interno procurarsi cuoi adatti a certi usi, perché non vi erano lavorati. Quindi i cuoi secchi, i quali dovevano pagare 3 lire e 4 soldi per rubbo, in realtà finivano di pagare soltanto 2 lire per rubbo se già acconci. Per i non conciati, allo scopo di far rifiorire l’industria e il commercio in quel di Mondovì, che erano stati quasi distrutti dall’alta gabella, erasi questa ridotta prima a 25 soldi per rubbo, e poi a 20, e finalmente a 16 soldi; e così si opinava potesse seguitarsi in un congresso convocato nel 1708 per avvisare ai mezzi di promuovere il gettito delle gabelle. Quanto ai cuoi portati per la concia in altre città, siccome da un lato i cuoi erano migliori e dall’altro la concia non era così perfetta e costosa come nel Mondovì, così si credeva si potesse seguitare ad esigere la metà della tariffa, conforme alla pratica invalsa[41].
Contuttociò la gabella delle carni e corami fruttava assai, favorita dal consumo non piccolo che in quei tempi si faceva di carni. Da alcune tabelle del provento dei dazi sulle carni e corami dall’1 ottobre 1699 al 30 settembre 1700, smaltite nella città di Torino e finaggio[42], si ricava che il consumo delle carni daziate a peso[43] era di rubbi 151.853.21 di carne di bestie bovine, rubbi 11.023.5 di carne di maiale, libbre 22.147.6 di carne introdotta in città già spezzata, libbre 16.775 di sanati, libbre 20.736.6 di carne di montone, libbre 10.301 di carne spezzata di maiale, e libbre 6.390.6 di carne salata di maiale, in tutto kg. 1.530.000 oltre a 13.106 agnelli ed a 12.892 capretti, tassati in ragione dei capi. Se si calcolano gli abitanti della città di Torino, suoi borghi e finaggio a 44.000 circa[44], si ha un consumo medio annuo individuale di kg. 31.77 di carne macellata e di 6 6/10, circa di capo per gli agnelli e capretti. Nel 1905 le carni macellate in Torino giungevano a kg. 12.642.156, e quelle salate e preparate che ivi si consumavano a kg. 108.940; in tutto kg. 12.751.096. Per una popolazione calcolata al 30 giugno 1905 di abitanti 358.684, il consumo individuale risulta di kg. 35.54[45], cosicché nei due secoli trascorsi dal 1700 il consumo della carne non appare aumentato. Il paragone, per più motivi, non è esattissimo, non conoscendo noi in qual misura il consumo delle carni propriamente detto fosse allora aumentato dal consumo della selvaggina, dei pollame, del burro, dei grassi e formaggi, dei pesci freschi o preparati, che oggi ammonta a Kg. 5.834.369, ossia a kg. 16.26 a testa. Per alcuni di questi alimenti di origine animale non si ha motivo di supporre una diminuzione nel consumo. Notisi che le frodi erano allora assai più frequenti d’adesso per la esistenza dei macelli privilegiati, presso cui si macellava un buon decimo della carne consumata nella città, e che, se l’usanza della villeggiatura estiva non era tanto diffusa come adesso, osservavasi d’altro canto con maggior rigore la quaresima (nel secondo trimestre dell’anno 1699/1700 il consumo della carne scemò di un buon terzo). A spiegare la stazionarietà del consumo della carne, si può addurre il fatto che è variato assai il prezzo, il quale per la carne di vitello aggiravasi sui 3 soldi e 3 denari per libbra (circa 65 centesimi, dei quali un settimo era gabella, al chilogrammo), e pareva invitare per la sua mitezza al consumo. Erano però i redditi altresì più sottili che oggi non siano e le abitudini di vita differenti, sicché un raffronto, il quale non si limiti ai pesi elemento di calcolo sicuro – rischia di essere fallace.
Anche la gabella della foglietta o del vino spacciato al minuto era regolata diversamente nelle provincie piemontesi ed in Torino. Nelle provincie gli osti, tavernieri ed altri tenitori di “publiche donzene, camere, locande”, e in genere tutti coloro che vendevano vino al minuto, i fondichieri per le malvasie e taggie, ecc., dovevano farne consegna e pagare il diritto di 30 soldi per caduna brenta (essendo la brenta uguale a circa mezzo ettolitro, la gabella ragguagliavasi a L. it. 3,75 per ettolitro). Esente dalla gabella la famiglia dell’oste per una quantità di 10 brente a testa per i maggiori d’anni 1 e di 5 brente per i minori, eccetto gli infanti; con facoltà gabellieri di esigere il dazio su tutto il vino tenuto dagli osti, quando riducessero la tariffa ai due terzi del saggio normale. Segno che già allora le taverne abbondavano in confronto alla popolazione che beveva, se il consumo famigliare dell’oste era ritenuto eguale ad un terzo del consumo totale del suo spaccio! Esenti erano pure quelli che tenevano collegi convitti, allora detti “donzene o camerate a scuolari et ad ogni altro per imparare arti o virtù”; i tavernieri dei castelli e presidii per il consumo della soldatesca; gli svizzeri della guardia. Avevano il diritto i gabellieri di bollare le botti e di visitare ad ogni momento le cantine; e pei contravventori vi era la confisca del vino, delle botti, la multa di 25 scudi per gli abbienti ed i due soliti tratti di corda per i nullatenenti.
A Torino il dritto rilevava a soldi 51 e denari 11 per brenta (circa L. 6,50 all’ettolitro), composti di soldi 36, per la foglietta, soldi 9 e d. 8 per la gabella grossa, e soldi sei e denari 3 per la gabella dei cinque ottavi di ducatone, dazi diversi che si erano sovrapposti coll’andar dei tempo sul vino. Se il vino veniva fatto colle uve raccolte nelle vigne degli osti situate nel territorio della città, il dritto della gabella grossa si riduceva a soldi 1, denari per brenta, ed il dritto complessivo a soldi 43, denari 10 (circa lire 5.48 per ettolitro). L’esenzione per il consumo proprio della famiglia degli osti era limitata a 6 brente per persona. Ad evitare frodi, coloro che tenevano dozzinanti si presumeva li avessero in casa almeno per tre mesi, anche se di fatto vi dimoravano minor tempo; ed erano tenuti a pagare in ragione di L. 24 per uomo all’anno. Erano eccettuati al solito gli istituti d’educazione e d’istruzione con annessa pensione, i maestri che alloggiassero apprendisti, i soldati, gli svizzeri della guardia, ecc., ecc.
Oltre al dritto della foglietta, il fisco in Torino esigeva ancora l’imbottato, che dovea pagarsi da chiunque introducesse vino nella città, in borgo Po, al Ballone ed alla Maddalena, nella misura di soldi 44 per carra di 10 brente di vino (L. 0.55 per ettolitro circa di vino). L’imbottato corrispondeva al moderno dazio di consumo esatto al passaggio della corriera cittadina, mentre la foglietta direbbesi ora dazio di minuta vendita[46].
Qui, a voler far un confronto tra la Torino del 1700 e quella del 1900, si ottengono risultati che paiono strabilianti. Nel sessennio 1698-1703 il provento medio lordo dell’imbottato in Torino fu di L. 66.500, il che da 44 soldi per carra di vino, ossia di 300 mila brente, corrispondenti a 150 mila ettolitri d’adesso. Nel 1902-1904, la quantità di vino introdotta in media nella città fu di 424.927 ettolitri, ai quali si debbono aggiungere 118.256 quintali di uva (da cui si possono ottenere in media forse un 85 mila ettolitri di vino), ossia in tutto 510 mila ettolitri[47]. Eppure essendo, a mezzo del 1903, la popolazione quasi 8 volte superiore a quella del 1709-703 (343.481 abitanti contro 44 mila), il consumo del vino avrebbe dovuto essere di 1 milione e 200 mila ettolitri! La differenza, è vero, è in parte colata dalle falsificazioni forse più usitate adesso, dai più larghi consumi di alcoolici e di birra[48]; ma anche allora si faceva vino con uve introdotte dai dintorni e non soggette all’imbottato, e stragrande era il numero dei privilegiati e degli ecclesiastici immuni.
Cosicché non rimarrebbe che da constatare il fatto della discesa del consumo medio annuo del vino, da 341 a 145 litri a testa di indice di libazioni più abbondanti e di ubbriachezza più diffusa un due secoli fa, o di beveraggi più fatturati oggigiorno. Giovano senza dubbio alla più larga consuetudine del bere la tassazione assai più tenue per i vini destinati a consumo privato (L. 0.55 invece di 10.80) ed il più basso prezzo dei vino che aggiravasi a Torino sulle 6 lire per brenta (Lit. it. 15 per ettolitro) ma sarebbe ardua impresa voler misurare la portata di questi incoraggiamenti.
7. – Segue pure un cammino ascendente il prodotto delle gabelle del “tabacco e dell’acquavite” delle quali qui si ragiona congiuntamente, trattandosi di consumi di lusso, soggetti l’uno alla privativa e l’altro alla licenza dei fisco. Nel 1700 il prodotto lordo era calcolato in L. 402 mila, da cui detraendo 106 mila lire di spesa per l’acquisto della materia prima, e 61 mila lire per la gestione della privativa, residuava un guadagno netto per il fisco di 24 mila lire. Nel 1710/1712 il prodotto lordo in media fu di L. 567 mila lire, l’acquisto dei generi gabellari costò 160 mila lire, le altre spese ammontarono a 70 mila lire, diguisaché il reddito netto fu di 335 mila lire, un 50 per cento più di prima la guerra. E si noti che, se abbiamo escluso nel 1700 il prodotto del tabacco nella Savoia per facilitare il paragone col periodo 1710/12 quando la Savoia era perduta per noi, non potemmo impedire che nel 1700 il provento fosse cresciuto della gabella nizzarda, perduta in seguito al dominio piemontese.
La privativa del tabacco limitata in origine al Piemonte erasi estesa alla Savoia nel 1688, ed a Nizza, Oneglia e terre di là dai colli, con ordine del 22 aprile 1702 (D. XX1V. 2 e 71), sicché ne rimaneva esente soltanto il Ducato d’Aosta. Riusciti a male i primi tentativi di coltivazione indigena delle piante del tabacco, altri non se ne dovevano intraprendere se non tre lustri circa dopo finita la guerra, sicché tutto il tabacco veniva dal di fuori. Proibita l’importazione e lo spaccio salvo per conto della gabella. Le ordinanze fissavano il massimo dei prezzi di vendita per il tabacco sodo in corda in soldi trenta per libbra, per il brasile in corda in lire 3 e soldi 12, per il puro di mezza grana senza ingredienti né odori a soldi 45, con ingredienti d’odor gelsomino e cedro a lire 3 e soldi 12, per il muschiato a lire 4 e 16 soldi, e per il tabacco di frangipane con ambra e muschio a lire 6 la libbra. Ma era concesso agli appaltatori di vendere il tabacco a minor prezzo (D. XXIV. 34 e 95); e di questa facoltà valevansi essi largamente per impedire il contrabbando che altrimenti sarebbe fiorito oltremisura. Da ogni dove veniva il tabacco di sfroso: dal Monferrato e dalle provincie lombarde, aggregate dopo la guerra a’ dominii piemontesi; veri “magazzini della frode” esclamava malinconicamente nel 1708 un aspirante all’appalto della gabella del tabacco e dell’acquavite[49], da dove veniva in Piemonte tabacco buono e si a buon mercato da fare concorrenza vittoriosa a quello della regia. Migliore e più a buon mercato era il tabacco d’Oneglia; dove nel 1702 erasi bensì esteso il tributo regio, ma, perché gli Onegliesi, separati del resto dagli altri paesi dello Stato, potessero conservare i guadagni derivanti dal traffico antico con i vicini Genovesi, Feudi imperiali e Lombardia, erasi limitato al dritto fisso di nove soldi per ogni libbra di tabacco che si introduceva nel Principato, liberi gli abitanti di approvigionarsi a loro talento e di fare spaccio delle preziose foglie aromatiche. Poco grati dei favori del fisco gli Onegliesi ne approfittavano per farsi contrabbandieri nello stesso Piemonte, e la loro audacia giungeva a tanto da vendere in Torino il tabacco mezza grana in polvere nera a 12 e 15 soldi la libbra, muovendo concorrenza formidabile alla gabella, la cui tariffa era di 45 soldi. Nell’interno dello stato i conventi, forti delle loro immunità, facevano traffico illecito di tabacco estero, se si può credere a quel Christofor sopra citato, il quale prevede che, se non si fanno stare a segno “plusieurs Couvents de l’Êtat, qui sont les magasins generaux de l’entreprise, cette ferme ira toujours de pis en pis”, onde ai gabellieri non rimaneva altro scampo fuorché di vendere il tabacco a prezzi assai più bassi di quelli segnati nella tariffa. Da un conto, che qui sotto riassumiamo, del prodotto della gabella del tabacco nel periodo 1698-1702, apparirebbe che il tabacco di tutte le qualità, da fiuto e da fumo, veniva venduto ad un prezzo medio di 18 soldi e 10 denari la libbra. Forse questo prezzo è quello di vendita all’ingrosso dalla gabella ai rivenditori al minuto; ma se anche lo aumentiamo di un cinquanta per cento, come alcuni indizi ci autorizzano a fare, il prezzo al minuto veniva ad essere non più di un ventisette o ventotto soldi per libbra in media fra tutte le qualità. A questo prezzo, corrispondente a circa L. it. 4,80 per chilogramma, la gabella smerciava 104 mila chilogrammi circa di tabacco nel Piemonte, cosicché il consumo legale aggiravasi forse sui 125 grammi per abitante.
Il consumo non doveva essere scarso per quei tempi, se era cagione, malgrado le querimonie che sopra si riferirono, di legittima compiacenza ai finanzieri piemontesi. Nel 1708, nel più volte mentovato congresso per crescere i redditi delle gabelle, per il tabacco e l’acquavite dicevasi: “Questa gabella pare sia ben regolata, se ben rispetto ai consumi del tabacco per le differenti manipolazioni le quali portano che debbano passare per più mani, e stante la diversita d’essi tabacchi chi più o meno umidi, la qualità de’ tempi, in quali si manipulano, non si può accertare; tuttavia il prodotto è di L.. 280 mila eccedente il prodotto dell’ultimo accensamento almeno di L. 80 mila l’anno”[50]. Attraverso la grammatica zoppicante e i desiderii del meglio si vede la compiacenza dei risultati ottenuti, compiacenza spiegabile se si rifletta che mezzo secolo innanzi, all’epoca della sua prima instituzione, la gabella del tabacco rendeva a mala pena 10 mila lire l’anno; e sia pure 16 mila se si tien conto del variato peso e titolo della lira.
Fatta ragione alla lunghezza del tempo trascorso, il progresso compiuto nel consumo del tabacco dal 1650 al 1700, appare non minore di quello che si ebbe dal 1700 al 1900. Nel 1700 a L. it. 4,80 per chilogramma, smerciavasi da 120 a 130 grammi di tabacco per abitante. Oggi (1904/905) con un prezzo medio di vendita di L. it. 13,44 per chilogramma, il consumo legale è di 489 grammi per abitante; ed è nelle provincie di Torino e Cuneo, le quali abbracciano la miglior parte del Piemonte antico, di 567 e 420 grammi rispettivamente per abitante. Il consumo è dunque aumentato assai, malgrado il prezzo più alto, nei due secoli trascorsi dal 1700, ed a mala pena si potrebbero indicare le provincie di Trapani (grammi 245), Sondrio (245), Reggio Calabria (237), Catanzaro (224), Ascoli/Piceno (223), Benevento (21G), Avellino (211), e Potenza (20G) in cui il consumo medio annuo individuale possa essere entro certi limiti Paragonato al consumo del Piemonte d’allora[51].
Il consumo rivolgevasi a tabacchi diversi di quelli attuali; sicché non parci senza interesse una tabella che abbiamo compilata sulla quantità ed i prezzi dei varii generi di tabacchi consumati in media nel Piemonte dal 1698 al 1702[52].
I prezzi medi assai più elevati non hanno impedito l’accrescimento del consumo, il quale preferisce inoltre, benché più cari, i sigari ai trinciati e sovratutto al tabacco da fiuto. Quest’ultimo, che in Piemonte nel 1700 dava il 76% del consumo (78.862 Kg. su 103.659) ora è scaduto nelle provincie di Torino e di Cuneo rispettivamente al 13.54 ed al 13.56%; mentre i trinciati (tabacco in corda) da quasi il 24% sono saliti al 31.03 ed il 29.97% ed i sigari e le spagnolette, una volta sconosciuti, contribuiscono pel 55.43 ed il 56.47% al consumo totale. Il consumo individuale del tabacco da finto è diminuito da 95 grammi nell’antico Piemonte a 77 e 57 grammi nelle odierne provincie di Torino e Cuneo; ed in compenso il consumo dei trinciati è aumentato da 30 a 176 e 126 grammi; ai quali vanno aggiunti adesso 314 e 237 grammi di sigari e sigarette. In ambedue le epoche non è misurabile l’influenza del contrabbando a variare le risultanze statistiche del consumo legale.
Alla gabella del tabacco andava unita la privativa della vendita della pipa, che da nessun altro potevano essere vendute fuorché dal gabelliere, e nemmeno potevano semplicemente transitare attraverso lo Stato, senza la costui licenza ed il pagamento d’un balzello di dieci soldi per dozzina. Eravi unito altresì l’esercizio per il solo Piemonte della gabella dell’acquavite. Perché al tabacco andasse unita la gabella dall’acquavite non è ben chiaro, se non si rammenti l’essere state amendue le gabelle in origine istituite a favore dell’Ospedale maggiore dalla Sacra Religione dai Santi Maurizio e Lazzaro “a beneficio dei poveri ed a maggior gloria di Dio” (D. XIV. 663).
Per l’acquavite era proibita l’introduzione, la fabbricazione e la vendita a chi non avesse ottenuto licenza dal gabelliere. Proibito il transito dell’acquavite per la città di Torino a chi non pagasse soldi 10 per libbra; obbligati i possessori di vini guasti a vandarli al gabelliere dietro pagamento del prezzo basato da periti. Determinato il massimo del prezzo dell’acquavite in Torino in soldi 25 per libbra per il rosolio, soldi 20 per l’acquavite fina, e soldi 16 per l’acquavite ordinaria. Malgrado che tali prezzi non eccedessero L. it. 4.25, 3.36 e 2.71 rispettivamente al chilogrammo, il prodotto della gabella dell’acquavite aggiravasi appena intorno alle 60-70 mila lire pel Piemonte, non essendo estesa agli altri paesi dello Stato. Pure tal prodotto sembrava rilevante nel 1700, quando non erano trascorsi 35 anni dal giorno che non si riusciva a cavare dalla gabella dall’acquavite più di 10 mila lire all’anno. Molte dovevano essere le frodi, se gli editti minaccian confische e tratti di corda e fustigazioni a’ distillatori di contrabbando, i quali, per la piccolezza delle loro fabbriche, docilmente venivano scoperti.
Sale, tabacco ed acquavite erano le privative sui consumi che allora più fruttavano allo Stato, come oggi il sale ed li tabacco; ed è interessante notare come fosse allora più caro d’adesso il costo d’esercizio della privativa. Per la privativa del sale il confronto risulta evidente dalla tabella seguente:
| Piemonte | Italia | |||
| 1700 | 1710-712 | 1903-904 | 1904-905 | |
| Spesa di compra o di fabbricazione del sale | 6.52 | 10.48 | 1.96
| 2.10 |
| Altre spese del monopolio | 19.03 | 18.56 | 12.64 | 13.22 |
| Spesa totale | 25.55
| 29.04 | 14.80 | 15.32 |
| Utile per cento | 74.45 | 70.96 | 85.20
| 84.68 |
| 100.- | 100.- | 100.- | 100.- | |
L’elevata spesa per la compra del sale nel 1710-712 può essere spiegata con la difficoltà che le navi corsare francesi e l’interruzione perduranti del commercio frapponevano all’acquisto del sale.
Per i tabacchi il confronto non è omogeneo perché nel 700 la privativa era unita con quella dell’acquavite; ma predominando di gran lunga il tabacco, non è senza significazione:
| Tabacco ed acquavite | Piemonte | Tabacco Italia | ||
| 1700 | 1710-712 | 1903-904 | 1904-905 | |
| Spese | 41.74 | 40.75 | 22.94 | 22.58 |
| Utile | 58.26 | 59.25 | 77.06 | 77.42 |
| 100. – | 100. – | 100. – | 100. – | |
Rammentisi, anche il paragone tanto pel sale quanto pel tabacco riesca istruttivo, che oggi il prezzo del sale e di 40, invece di 68 cent. al kg.; ed invece il prezzo del tabacco fu per Kg. di L. it. 13,25 nel 1903/904 e di L. it. 13,44 nel 1904/905 invece di L. it. 3,21 nel 1700/712. Oggi il monopolio lucra in proporzione assai di più sul sale, malgrado il prezzo scemato; mentre se vuol profittare maggiormente sul tabacco, gli conviene quadruplicare i prezzi.
8. – Reddito di gran lunga minore davano le altre gabelle, delle quali ci resta da parlare.
La privativa della fabbricazione e della vendita delle candele era stata assunta dallo Stato nel 1695 senza pere che fosse mai estesa oltre i confini del Piemonte propriamente detto (D. XXIV, 337). Vendevansi dal fisco le candele di cevo (sego) a 10 soldi la libbra; proibita la esportazione dei cevi all’estero e la vendita ai conciatori, calzolai ed altri industriali; proibito il traffico tra provincia e provincia delle candele senza licenza speciale della gabella; proibita l’importazione dall’estero delle candele, salvo licenza e pagamento dell’intiero prezzo di privativa diminuito delle pure spese di fabbricazione. Ma, nonostante tutti questi divieti, la gabella poco profitto dava al fisco, mentre i contribuenti ne erano oltremisura affitti. Le lagnanze doveano essere forti se in seduta del 13 febbraio 1703 la Camera dei Conti lungamente discorse del “grave danno che il pubblico sente per la mala qualità delle candelle bollate di cevo spacciate dai gabellieri e incaricò il conservatore generale delle gabelle Frichignono di parlarne al Duca ed al patrimoniale generale David di discorrerne col Groppello, affinché vedessero di far cessare lo sconcio[53]. In un parere del 13 settembre la Camera dei Conti volle che il Principe riflettesse sulla convenienza di ridurre il prezzo delle candele, divenuto eccessivo in confronto del costo del cevo. Essere il prezzo di 10 soldi per libbra stato stabilito durante la guerra passata, quando il prezzo dei cevi era assai più elevato; in guisa che la finanza veniva a lucrare una gabella di lire 2 e mezza per rubbo. Adesso che il prezzo della materia prima e ribassato, gli appaltatori – ai quali il canone non fu cresciuto – lucrano sino a lire 5 per rubbo. Ove il prezzo fosse diminuito, il consumo sarebbe certamente maggiore[54]. – Ma il male era forse inevitabile poiché – solo col peggiorare la qualità delle candele e col tenere i prezzi alti poteva la privativa sostenersi durante la nuova guerra sopraggiunta nel 1703. A differenza delle privative del sale e del tabacco, in cui la miglior parte del prezzo era data dal tributo, qui la differenza fra i costi di produzione ed i prezzi era assai tenue. Nel 1700, secondo la tabella più volte citata, il prodotto lordo della privativa delle candele era stato di L. 99.388, le spese erano salite a L. 73.340.11.5, cosicché il reddito netto si riduceva a L. 26.047.8.7. Il congresso del 1708 lamentava che la privativa obbligasse a tenere un capitale impegnato di 70/80 mila lire, con utile meschinissimo e si raccomandava perciò di abolire il monopolio, lasciando libero ognuno di fabbricare e vendere candele, a patto di farle bollare pagando un diritto di L. 2 per rubbo. Il fisco, si sperava, avrebbe introitato non meno ed avrebbe avuto meno cure[55].
I saggi consigli non furono subito seguiti, sperandosi forse che le cose avessero a migliorare in tempi più tranquilli. Ma la media del 1710-712 diede i seguenti risultati: L. 107.145 di prodotto lordo, L. 77.616 di spese e L. 29.528 di reddito netto pel fisco. L’esperimento era fallito in modo definitivo. Un ordine 26 settembre 1712 (D. XXIV. 353), motivato al solito dal desiderio di far cosa più utile al popolo che alle finanze, le quali, a sentire gli estensori dell’ordine, assai profitto aveano ricavato dal monopolio, lo aboliva del tutto, lasciando liberi la fabbricazione, l’importazione e lo spaccio delle candele, salvo il pagamento di un diritto di bollo di 45 soldi per rubbo. I risultati diedero ragione ai riformatori. Nel 1713 il diritto di bollo sulle candele frutta L. 26.028.16.2 Einaudi, B. e C. T. 1700-1713, Tabella VI), poco meno che nei tre anni precedenti, con vantaggio non piccolo dell’industria e dei consumatori.
La gabella del ghiaccio e della neve, sorta in principio del 1600 sotto forma di privilegio concesso ad un privato della fornitura remunerata delle Case Reali e degli ambasciatori, continuata, coll’aumentare del consumo, coll’obbligo della fornitura gratuita alle Case Reali in compenso del monopolio del consumo privato nella città di Torino, avea oramai assunto la importanza di una vera privativa (D. XXIV. 396 e segg.). Ai tempi nostri la gabella, ristretta sempre alla città di Torino, fruttava un canone di L. 8000 sino al 1702, di L. 6000 dal 1703 al 1709, di L. 8050 nel 1710 e 1711, di L. 6800 nel 1712 e di L. 5800 nel 1713 (Einaudi, B. e C. T. Tabelle I, II, III).
L’appaltatore avea il diritto di valersi delle ghiacciaie fiscali poste nei fossi della città a Porta Palazzo, poteva multare chiunque fabbricasse ghiaccio in casa, e dovea spacciare il ghiaccio a non più di un soldo per libbra (L. it. 0,17 al kg.).
La gabella delle strazze colpiva gli stracci, che allora erano l’unica materia prima adatta alla fabbricazione della carta. Proibita l’esportazione degli stracci all’estero, per cavare qualche vantaggio dall’industria dei battitori da carta appartavasi di tre in tre anni il diritto esclusivo di comprare stracci in Piemonte, Aosta, Nizza ed Oneglia a chi pagasse più alto canone al fisco. Veramente il diritto non era esclusivo, che allora tutti i battitori di carta sarebbero stati alla mercé dell’appaltatore. Ma questi avea il diritto di farsi pagare dai battitori 25 scudi effettivi d’Italia per ogni tino da carta in esercizio; e di comprare al prezzo fissato della Camera dei Conti gli stracci che a’ fabbricanti sovravanzassero. Per il triennio 1701/703 la gabella fu appaltata per L. 2816 l’anno che salirono a 3552 a partire dal 1706[56].
Noi non sappiamo però se la legge che imponeva ai padroni dei battitori da carta di pagare 25 scudi per tina all’appaltatore e di vendere a lui gli stracci sovrabbondanti fosse osservata. I Padroni di battitori nel 1700 erano 25 e possedevano 32 tine ed un quarto, cosicché a 25 scudi d’oro d’Italia di L. 7.5 l’uno avrebbero dovuto pagare L. 5.545.6.3. Se il canone era ridotto a L. 2516 era segno che l’appaltatore non riusciva a farsi pagare dai padroni dei battitori tutto il canone dovuto. Un avviso della Camera dei Conti del 7 settembre 1700 ci insegna infatti che il canone era stato dal 1690 ridotto a 12 scudi per tina, sovratutto a causa della concorrenza delle cartiere dei Cenovesato. Questa concorrenza aveva fatto rincarare gli stracci, che di nascosto erano condotti nel Genovesato, ed aveva fatto diminuire il valore della carta dei paese, la quale “ha puochissimo esito”. L’imposta della carta bollata aveva ridotto notevolmente il consumo della carta; per modo che, volendo esigere dai battitori tutti i 25 scudi, la maggior parte avrebbe dovuto essere chiusa[57]. L’appaltatore traccheggiava bensì di continuo gli esportatori di stracci; ma con poco frutto, malgrado le frequenti ordinanze camerali[58].
L’accensa dei vetri compare nei bilanci dal 1707-705 al 1711 con un canone annuo di L. 5000; e nei due bilanci del 1712 al 1713 con L. 20.000, ricavo presunto dalla vendita del fondo in vetri della fabbrica di Torino (Einaudi, B. C. e T. 1700/713, Tabelle I, II). Il Duca possedeva infatti a Torino da parecchio tempo una fabbrica di vetri, il cui esercizio veniva appaltato per quella somma annua, e chi l’appaltava avea il monopolio della produzione e della vendita in tutto il Piemonte (D. XIX. 342). La fabbrica era però mal vista dai Torinesi, che l’accusavano di consumare troppa legna e di farne aumentare a dismisura il prezzo, cresciuto da 12 fino a 20 lire e più per carra dal 1690 al 1701, ed ogni tanto riuscivano ad ottenerne la chiusura[59].
La privativa della raccolta del salnitro e della fabbricazione e vendita delle polveri e dei piombi era voluta sovratutto da ragioni di indole militare, le quali, essendo per loro indole estese a tutte le parti dello Stato, aveano fatto sì che si superasse lo scoglio dei privilegi dei singoli paesi, cosicché il monopolio comprendeva, oltreché il Piemonte, la Savoia, Nizza, Oneglia e persino Aosta. Grandi privilegi erano concessi all’appaltatore ed ai salnitreri, come esenzione dai tributi personali, alloggi militari, servitù di guerra, ecc. ecc.; privilegi che erano fonte di abusi e di lagnanze delle comunità contro chi pretendeva sottrarsi al pagamento dei carichi pubblici, prestando breve servizio al soldo dell’appaltatore del salnitro. Il fisco da quest’appalto ricavava un canone in natura che era nel contratto dal 1701 al 1706 di mille rubbi di polvere ed altrettanto di piombo. Verso la fine del nostro periodo vi si aggiunge un canone in denaro di L. 26.000 annue (D. XXIV. 177, 253/74 ed Einaudi, B. e C. T. 1700/713, Tabelle III, VI, XIV).
9. – Delle “Poste” diciamo ora perché i documenti del tempo ne trattano sempre congiuntamente alle gabelle, trattandosi di diritti simili a quelli esatti per il tabacco ed il sale. Le poste erano esercitate in regia, per tutti i paesi dello Stato, sin dall’epoca di Emanuele Filiberto, il quale avea creato la carica di Mastro generale delle poste affidandogli il carico del trasporto delle lettere a tutto suo rischio e vantaggio, salvo un lieve canone da Pagarsi al fisco. Ma, Poco innanzi al periodo nostro, con editto del 31 marzo 1697, vittorio Amedeo II riscattava dal marchese Filippo Giacinto Gonteri di Cavaglià, ultimo generale delle poste ed ammiraglio del Po, il privilegio da lui posseduto, conservandogli il titolo onorifico insieme ad una pensione di 12 mila lire, titolo riversibile in un suo figliuolo maschio insieme con una pensione di 3000 lire (D. XXV. 617 e 680). Fu saggio consiglio quello del Duca, poiché ben presto il reddito lordo delle Poste si innalzava ad 80 mila lire e il netto a circa 40 mila. Secondo la tabella pubblicata sopra al paragrafo 3, il reddito netto delle poste era stato nel 1700 di 46.300 lire; e nel 1710.12 fu in media di 80.840 lire al lordo, dalle quali detraendo L. 37.426 lire di spese rimane un guadagno di L. 43.413. Secondo ancora altri dati inserti nella raccolta del Duboin il provento medio degli anni 1708/10 era stato il seguente:
| 1. Ufficio di Torino: | Distributione lettere | L. 38.746.7. 8 |
| Lettere affranchite | 4.868.3. 8 | |
| Pachetti di Genova e Berna | 3.943.4. 4 | |
| Sublocationi delle poste d’Asti ed Oneglia | 620 | |
| Dritto del 10 per cento sovra le corse | 7.637.6. 3 | |
| Porte dovuto dalli uffici d’Asti, Casale et Alessandria | 1.414.10. | |
| Dritto honorario che pagano li mastri di posta | 145 | |
| L. 57.373.11.11 | ||
| 2. Altri uffici | ||
| (Vercelli, Casale, Alessandria, Mondovì, Cuneo, Villafaletto, Possano, Savigliano, Saluzzo, Racconiggi, Carmagnola, Pinerolo, Susa, Aosta, Ivrea) | 19.690.10.4 | |
| L. 77.064.2.3 |
E la spesa:
| 2. Ufficio di Torino: | Stipendio alli impiegati nell’ufficio | L. 5.000 | |
| Stipendio al signor Santi stabilito in Milano | 1.440 | ||
| Stipendio al signor Verney in campagna per la cibaria | 540 | ||
| Porte dovuto all’ufficio di Milano per le lettere di Germania, Spagna, Roma et Italia | 1.621.5. 8 | ||
| Porto e riporto della mala di Genova per Aosta | 3.435 | ||
| Med. per la mila di Genova in Alessandria | 1.300 | ||
| Med. per la mala di Milano | 884 | ||
| A riportare L. | 14.220.5. 8 |
| |
| Riporto | L. 14.220. 5. 8 |
| |
| Med. per la mala di Susa | 754 | ||
| Med. per la mala di Pinerolo | 468 | ||
| Al pedone di Cuneo e strada | 520 | ||
| Al pedone di Cuneo per Saorgio | 260 | ||
| Porto e riporto della mala del campo | 362.14. 8 | ||
| Spese minute all’ufficio diTorino | 458. 2. 8 | ||
| Porto dovuto all’ufficio di Cenovaper le lettere di Toscana et altre | 1.415.10. 2 | ||
| Porto dovuto all’ufficio diBerna per le lettere d’Hollanda,Inghilterra et Helvetia | 12.103. 4. 8 | ||
| Lettere che si danno gratis | 189.15 | ||
| L. 30.749.12.10 |
| ||
| Lettere di rifiuto, gratuite eprovvisioni nei 15 uffici fuori di Torino | 4.113. 2. 3 | ||
| Spese per Casale, Alessandria ed Acqui | 3.025. 4. 6 | ||
| L. 37.887.19. 7 | L. 37.887.19.7 | ||
| Sicché, deducendole dalle entrate, si otteneva il reddito netto in | L. 39.176. 2.8 | ||
La perdita della Savoia e di Nizza non avea intuito troppo sfavorevolmente sui redditi postali, ingrossati dagli acquisti del Monferrato e dell’Alessandrino: e nemmeno le circostanze di guerra aveano interrotto gran che le comunicazioni. Le quali però erano vive quasi soltanto a Torino e sulle linee internazionali. Nelle provincie, a causa dello scarsissimo numero degli uffici, appena 15 fuori della capitale, il numero delle lettere trasmesse dalla gabella era scarsissimo, onde sembra legittimo conchiuderne che continuasse l’industria dei corrieri privati, malgrado le proibizioni e le multe comminate dall’editto dell’1 settembre 1698 (D. XXV 686). Il quale, mentre prima era libero il trasporto delle lettere e dei pacchi a chiunque, avea reso la posta una vera privativa di Stato, proibendo a privati il trasporto di più di 4 lettere per volta, sia da luogo a luogo entro lo Stato, sia per fuori Stato, e di pacchi di mercanzie (sete, filo, lana, oro ed argento) introdotti dall’estero separatamente dai carichi dei conducenti e pesanti meno di due rubbi. Era appena consentito ad ognuno, che non facesse il mestiere del vetturino, messaggiere, carrettiere o barcaiuolo, di recare con sé piccoli pacchi di mercanzie per uso di viaggio; ai carrettieri di portare aperte le lettere di vettura relative alle merci da loro trasportate; e per facilitare il traffico fra il Piemonte, il Monferrato e lo Stato di Milano si lasciava libero il trasporto dei ballotti di seta e di bozzoli tra quei paesi. Invano la Camera dei Conti di Torino avea fatto rilevare i danni di introdurre il monopolio della posta innanzi che il servizio postale dello Stato fosse esteso a sufficienza: la cessazione del trasporto delle lettere nei moltissimi luoghi di provincia, dove non esistevano uffici postali; danni alla giustizia per la impossibilità di inviare da quei luoghi lettere ai Tribunali di Torino; danni al commercio ed angustie alle persone per dovere aspettare la partenza settimanale del corriere pubblico, anche se si trattava di lettere d’urgenza; angherie a viandanti, che ad ogni tratto potranno essere frugati da gabellieri per veder se indosso abbiano più di quattro lettere; aumento del costo dei trasporto dei piccoli pacchi di meno di 2 rubbi provenienti dall’estero o inviati oltremonti, che dovranno d’or innanzi affidarsi ai corrieri pubblici, i quali da Torino a Lione si facevano pagare 30 soldi per libbra, laddove i mulattieri trasportavano per due soldi, ecc. Il Duca avea garbatamente ringraziata la Camera delle sue osservazioni; ma “per cause non men giuste che necessarie e prudenti alla nostra notizia unicamente riservate” avea tenuto fermo il suo divisamento, concedendo soltanto quelle poche esenzioni che sopra abbiamo enumerato[60].
A maggiore notizia del lettore, riferiamo qui sotto la tariffa delle lettere per l’ufficio di Torino. Il destinatario dovea a Torino pagare:
| Per le lettere semplici | Per quelle pesanti un’oncia (30 grammi circa) | Provenienti da |
| Soldi 1 | 5 | Susa, Pinerolo, Cuneo, Mondovì,Asti, Vercelli e loro provinciee luoghi di strada. |
| 3 | 12 | Annessy, Moutiers, Conflanse consimili luoghi. |
| 4 | 16 | Geneva, Chiablese. |
| 2 | 6 | Nizza e Contado. |
| 2 | 10 | Lione, Milano, Venezia, Roma,Genova e tutta Italia. |
| 2 | 8 | Chambery, Mommiliano, Aosta,provincia e rotta. |
| 4 | 20 | Fiandra ed Alemagna per lavia di Milano. |
| – | 75 | Spagna. |
| 1 | 6 | Casale. |
Ed inoltre per ogni bolla L. 5, per ogni indulgenza L. 1.10 e per ogni altro breve L. 2.5. Per le lettere spedite da Torino, la tassa si pagava dal destinatario nel luogo di ricevimento, eccetto per le lettere che passavano per Milano e Genova e quelle a destinazione di Roma e Firenze per Genova, per cui si dovea pagare l’affranchimento in ragione di 2 soldi se lettere semplici e 10 soldi se pesanti l’oncia; e quelle per Susa, le quali pagavano 1 soldo se semplici e 5 se dell’oncia (D. XXV. 687).
Erano esenti dal pagamento delle tasse postali il Gran Cancelliere, il Ministro Segretario di Stato, il Segretario di Guerra, il Generale di Finanza, e le lettere e i pieghi indirizzati ai Governatori delle provincie e piazze ed agli Intendenti di giustizia ed azienda, purché controsignate da un ministro sulla sovrascritta. Pare però che di fatto anche altri godessero dell’esenzione della tassa: le Case Reali, eccetto per le lettere provenienti dall’ufficio di Berna, l’Avvocato generale, gli Economi delle gabelle generali, i corrieri del Duca, l’Archivio di Corte, l’Abbate di Lauriano, i Padri Mendicanti[61].
10. – Della carta bollata dobbiamo parlare pur qui, condiscendendo alle idee dei tempi, poiché se nei trattati moderni se ne discorre trattando delle tasse e delle imposte sugli atti, allora era considerata come una gabella e appaltata insieme con le altre gabelle. Di recente istituzione, rimontando per il Piemonte all’editto 22 novembre 1694 e per la Savoia all’editto novembre 1696 (Nizza, Oneglia ed Aosta ne andavano esenti), la gabella della carta bollata avea già esercitato la sottigliezza dei contravventori e l’indegno de’ finanzieri interessati a crescerne il reddito.
Il prezzo della carta bollata era stato fissato nella cifra di un soldo per ogni foglio di carta e di pergamena, comprendendo nel soldo il costo della carta ma non quello della pergamena. Erano soggetti all’uso della carta bollata gli strumenti notarili, tanto per gli originali alle parti come per le copie del minutario, protocollo ed ufficio di insinuazione e gli estratti. Così pure le scritture dei contratti, capitolazioni, quinternetti d’esattori, libri d’ordinati municipali, visite, esami, misure, obbligazioni, promesse o polizze, quietanze, fedi, procure, attestazioni ed ogni altro atto che potesse far fede in giudizio. Nessun magistrato, ministro, ufficiale, delegato od altro giusdicente poteva ammettere in giudizio scritture non bollate, né dar loro alcuna fede, sotto pena di nullità delle sentenze, decreti, ecc.; e neppure fra le parti potevano quelle scritture indurre obbligazione o liberazione di sorta.
Esenti dal bollo erano gli ordini generali del Sovrano e dei Supremi Magistrati, le costituzioni d’ufficio, gli ordini emanati per servizio militare e le quitanze rilasciate dai tesorieri pubblici, le bolle e quitanze dei gabellieri generali. Per favorire il commercio e la salute pubblica si esentavano anche le lettere di cambio dei banchieri, mercanti e negozianti, come pure le ricette dei medici per i farmacisti. Ove però banchieri e negozianti eleggessero di far bollare i loro libri di commercio, si dava a questi forza esecutoria contro i debitori entro l’anno dalla remissione delle merci, purché la somma non superasse gli scudi 50 d’oro (D. XXIV. 422 – 33).
Ben presto nascevano abusi e i contravventori prendevano animo a violare la legge con diversi pretesti; onde un ordine 10 agosto 1695 stabiliva dovesse ogni foglio essere bollato con due bolli, detto l’uno intrinseco e l’altro estrinseco, diverso questo per ogni provincia, con proibizione di servirsi di carta di altra provincia. Esteso espressamente, ad evitare dubbi, l’obbligo del bollo alle cedole e ai libri di tutori e curatori, agli ordini del Vicario e Giudice di Torino ed ai tiletti (avvisi) che si affiggevano in pubblico nell’interesse delle comunità, università e pupilli. Puniti i falsificatori con dieci anni di galera, gli spacciatori e consumatori di carte col bollo falso con pena corporale ad arbitrio del conservatore delle gabelle, non minore però della fustigazione o d’un tratte di corda. Non necessaria la scoperta del corpo del delitto per pronunciare, se non la pena corporale, almeno quella pecuniaria sino a 100 scudi d’oro, quando vi fosse la testimonianza di due persone corroborata da qualche “adminicolo, come sarebbe di diffamazione od altro all’arbitrio del Conservatore” (D. XXIV. 433). Nonostante queste minacce, e nonostante si fossero introdotti, a scemare l’avversione del pubblico, con ordine del 26 gennaio 1695, i mezzi fogli da denari 6 ed i quarti di foglio da denari 4 per le scritture non richiedenti sottoscrizione di notaio o contratti, né superiori al valore di 50 lire, seguitavano i contribuenti a raddoppiare d’astuzia nel frodare il fisco, adoperando fogli di carta insolitamente grande e scrivendo sì fittamente da impiegare una pagina sola dove prima ne occorrevano cinque o sei. Onde nuove proibizioni e minacce con ordine del 9 agosto 1698 (D. XXIV. 453). Altri ordini consentivano a’ gabellieri di aggiungere al bollo della carta, la parafrazione o firma d’un funzionario dichiarante che il bollo non era falsificato e davano molte minutissime norme ad impedire le frodi moltiplicantisi (D. XXIV. da pag. 457 a 463).
Quali risultati si ottenessero da tutte queste proibizioni noi non sappiamo di preciso. La gabella, che nel 1700 rendeva al lordo L. 56.462, nella media del 1710-12 ne rese L. 64.365, da cui togliendo L. 5.921 per la compra della carta e L. 7.332 per le spese varie, il reddito netto residuava in L. 51.111. Ma non pare che questo fosse il massimo reddito che si sarebbe potuto ottenere, poiché, per evitare inquisizioni eccessive, quasi sempre le gabelle facevano una specie d’abbonamento coi notai e con le comunità, anziché obbligarli a protocollare e insinuare tutti gli atti a norma delle leggi vigenti. Ciò lava qualche scapito al fisco, e si meditava porvi riparo. I più sarebbero stati contenti che la gabella fosse stata abolita; e la Camera dei Conti nel 1700, quando la carta bollata era d’istituzione ancor recente, l’accusava di essere perniciosa al servizio della giustizia et in conseguenza a quello dell’A. S. R.”, perché “il più delle volte si trascurano dalli Giudici le giustificazioni dei delitti et de’ delinquenti per lo più miserabili e nullatenenti per evader le spese della carta bollata che devono impiegarvi et anticipare del loro proprio denaro per la validità de’ loro atti[62]. La nuova guerra tolse ogni velleità alla Camera di insistere per l’abolizione del tributo; sicché questo fu continuato ed anzi a poco poco cresciuto, non però nel nostro periodo.
11. – Pure sulle 50 mila lire all’anno batteva il reddito della privativa delle carte e tarocchi e della gabella dei giuochi. Istituita pel solo Piemonte nel 1579 la privativa della fabbricazione e della vendita delle carte e dei tarocchi, richiedeva continua vigilanza perché il reddito non ne sminuisse. Obbligavansi perciò i possessori di carte a farle bollare di volta in volta dai nuovi gabellieri: ed i contravventori erano puniti con 100 scudi d’oro di multa, di cui un terzo al fisco, un terzo agli appaltatori, un terzo al denunciaute, anche se egli fosse tra i contravventori. Ai nullatenenti il fisco appagavasi di dare un tratto di corda in pubblico.
Quanto ai giuochi, era proibito tenere in casa ridotti, accademie, luoghi di conversazione allo scopo di giuoco, anche se fossero istituiti con altri pretesti, senza aver ottenuto il permesso dagli appaltatori, sotto pena di una multa di 200 scudi d’oro e la perdita delle carte e delle poste. Fra i giuochi riservati si citavano la bassetta, il faraone, il pour et contre, i dadi, l’oca, tanto con le palle ed il sacco quanto con le palle e i numeri sull’albero, e qualunque nuovo gioco si inventasse. Con regole particolari era statuito sui giuochi della bianca, dei truchi, dei taglietti e del viretto, i quali concedevansi in appalto separato da quello generale delle gabelle (D XXIV. 501-3 e 526-46).
Separatamente pure dalle gabelle generali, era amministrata la privativa del giuoco del lotto, o del Seminario come allora veniva chiamato. Istituito un secolo prima (memoriale 21 dicembre 1590 in D. XXIV. 594) il giuoco del seminario, che rendeva in origine 100 scudi d’oro l’anno, dopo varie vicende di soppressione e nuova istituzione, era stato, malgrado le proteste della Camera de’ Conti[63] con lettere patenti del 1699, in seguito a contratto del 25 marzo 1699, concesso per 12 anni, e cioè fino a tutto il 1710 ad un Camillo Broggio, milanese, e compagni, per un canone annuo di L. 20 mila. Il Broggio poteva fare due estrazioni l’anno in Torino di 5 nomi su 90; e poteva anche ricevere giuocate sulle due estrazioni del giuoco del seminario che si facevano in Genova, con obbligo di pagare le vincite in Torino (D. XXIV. 611).
La tariffa delle giuocate era la seguente:
| Ambi | Terni | ||
| Tassa | Vincite | Tassa | Vincite |
| L. 2.12 | L. 600 | L. 2.2 | L. 6000 |
| 1.6 | 300 | 1.1 | 3000 |
| 0.8.8 | 100 | 0.7 | 1000 |
| 0.4.4 | 50 | 0.3.6 | 500 |
| 0.2.2 | 25 | ||
| Primo estratto | Estratto semplice
| ||
| Tassa | Vincita | Tassa | Vincita |
| L. 1.10 | L. 100 | L. 7.12 | L. 100. |
La privativa si estendeva a tutti gli Stati; ma essendo state occupate la Savoia, Nizza ed altre contrade dello Stato durante la guerra, e non essendosi potuto fare nel 1705 più di una estrazione e nel 1706 nessuna, si convenne il 2 gennaio 1707 di ridurre il canone a 5 mila lire per 1705, condonarlo del tutto pel 1706 e ridurlo in seguito sino alla fine della guerra a L. 12.500 l’anno[64]. Ritornata la calma in Piemonte, sembra crescesse la smania del giuoco, onde non era neppur finito l’appalto del Broggio che già si appaltava nuovamente il giuoco del seminario, con contratto 26 novembre e R. B. del 18 ottobre 1710, confermato da lettere patenti 28 febbraio 1711, per tre anni dall’1 luglio 1710 al 30 giugno 1713 per un canone di L. 55.278.14 nel primo anno, e 50.693.19.8 negli altri due, con la clausola di un aumento di L. 6500 negli ultimi due anni, conchiudendosi la pace nel triennio. Non tutto era guadagno netto delle finanze, poiché queste doveano indennizzare il Broggio per una estrazione perduta e pagare L. 18 mila a diversi che intervenendo agli incanti aveano fatto aumentare il canone. Ma se lieti erano i pronostici intorno al reddito del lotto, corrucciavansi gravemente i moralisti per l’immoralità di vedere il Principe farsi banditor di vizi; onde con l’editto di generale indulto del 31 luglio 1713, emanato in ringraziamento della pace riconquistata e della corona ampliata, anche il giuoco del seminario veniva, insieme con molti altri tributi, abolito. Né dovea risorgere se non trascorso quasi un terzo di secolo, con altro Principe e per fornire i mezzi ad altra guerra.
[1]Vedasi il contratto 31 ottobre 1697 riportato per disteso in D. XXIII, 1613.
[2]A. S. F. I a.Gabelle generali, M. I, n. 4. Vedi in fine del mazzo.
[3]A. S. M. E. Gabelle generali, M. 1, n. 31. Lettere di Cadenet al Duca del 21 marzo 1701.
[4]A. S. F. 1 a. M.1, n. 4, Gabelle generali. Lettere di Cadener al Duca dell’8 gennaio, 26 e 28 febbraio 1703 ed allegato.
[5]Vedasi in A. 9. F. IIa. Capo 9, n. 101, Memorie dei Redditi finanze, le motivazioni del minor prodotto o dell’inesigibilità di parecchie piccole gabelle. A pag. 2 (1710): L. 90 non esatte dal Pedaggio di Rard per minor prodotto, sendosi maneggiato ad Economia per difetto d’accensatori; Id.: L. 40 non esatte dalla segreteria del Giudice di Torino, perché “con quante diligenze usate non s’è potuto accensare”; a pag. 5 (1711): L. 82.10 non esatte per Diritto interinazioni per “minor prodotto sendo maneggiato in Economia”. Che le gabelle tenute in economia poco o nulla fruttassero era opinione generale; che non gioverebbe ora criticare con diatribe sulla ingordigia degli appaltatori. Veggasi poi la Repubblica di Venezia l’istessa opinione espressa dai Deputati ed aggiunti alla provision del denaro nei nostri Studi di Economia e di finanza, pag. 153. Cfr. Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, Serie II. vol. II, pag. 40, 182 – 189. 437. E dovea essere opinione fondata sul vero se era esposta come principio assiomatico dai preposti alla pubblica finanza in scritture segrete compilate per uso dei sovrani o dei corpi deliberanti supremi.
[6]Veggasi ciò che a questo proposito detto in EINAUDI, B. e C. T. 1700-1713, Capo III, paragrafo 1, n. 13, e si legge ivi nella TabelIa VII.
[7]Vedi l’istrumento di accensamento del 25 marzo 1703, accennato soltanto in D. XXIII, 1615, in un fascicoletto a stampa per G. B. Zappata, libraro di S.A. R., in Torino, MDCCIII in A. S. M. E. Gabella generali, M. II, n. 1.
[8]Giovanni Battista Groppello, di modesti natali ed umile fortuna era stato dal piccolo ufficio esercitato nelle gabelle sollevato i primi gradi da Vittorio Amedeo II, che l’aveva saggiato per valente, come dico DOMENICO CARUTTI (Il primo Re di Casa Savoia, Torino, Clausen, 1897, pag. 182). Referendario ed Intendente di Susa nel 1692, Mastro Auditore alla Camera dei Conti nel 169a, era stato nominato Presidente o Generale delle Finanze per Lettere Patenti del 5 marzo 1697. Nel 1699, con lettere patenti del 29 aprile, il feudo di Borgone, che egli aveva comprato nel 1696 dal vassallo Giovenale Chiaberti, eretto in contrado per il Groppello. Generale, oggi si direbbe ministro delle Finanze, durante tutta la guerra di successione spagnuola, il Groppello è indubbiamente la figura più notevole della storia finanziaria del tempo ed il suo nome ricorre perciò di frequente nel nostro racconto, come dell’ispiratore di quasi tutti i provvedimenti più importanti di Vittorio Amedeo II in siffatta materia. Il suo Ministero, durato più di vent’anni, in tempi difficilissimi, ha fine il 16 febbraio 1717, quando, per l’età avanzata, promosso al grado onorifico e creato apposta per lui di Primo Presidente Patrimoniale alla Camera dei Conti, carica nella quale durò sino alla morte, avvenuta il 25 agosto 1722.
[9]Cfr. la transazione 21 dicembre 1703 approvata con R. B. del 23 ed interinata dalla Camera il 29, in A. S. F. II a. Capo 40, n. 6, fol. 17.
[10]A. S. F. IIa. Capo 54, Registro Lettere Piemonte, n. 23. Lettera del 30 luglio 1704 di Groppello a S. A. R.
[11]Cfr. la scrittura 13 marzo 1708 approvata con R. B. del 13 ed interinata il 20 dalla Camera in A. S. F. II a. Capo 40, n. 6, fol. 149.
[12]Altre proposte aveano fatto il Conte Picone della Perosa, dimorante a Parigi, quel faccendiere Cadenet, pure di Parigi, che già conosciamo, un signor Jullien di Lione, e certi signori Orceau des Arennes, Chambelain e De Haute Rive.
[13]A. S. F. IIa. Capo 57. Lettere diverse, 1712 e 1713, n. 664. Memoria annessa a lettera del chevalier Desmarets al Groppello, da Parigi, in data 22 maggio 1713.
[14]Veggansi esposte tutte queste trattative in A. S. F. I a. Gabelle generali, M. I, n. 4, e M. II, n. 2, 3, 4.
[15]A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, n. 3. Stato del prodotto e spese delle Gabelle generali di S. A. R. per l’anno 1700; e n. 4. Estats des Gabelles generales de S. A. R. des années 1710, 1711 et 1712.
[16]Veggasi pel nostro periodo l’editto 20 maggio 1700 con le istruzioni 5 luglio 1700 simili a tante altre emanate in siffatta materia, in D. XXIII. 1629.
[17]I dati sulla popolazione dagli Stati dei Duca di Savoia furono ricavati dalla monografia dei Dr. G. PRATO: Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII, inserta nel fascicolo di maggio -agosto 1906 della Rivista italiana di Sociologia, pag. 337-340 ed in estratto a parte, pag. 36-39.
[18]Precisamente di kg. 6.483, di un valore di L. it. 2,58 nell’esercizio 1904-905. Il consumo medio individuale nelle provincie di Torino e di Cuneo è stato nell’istesso anno di Kg. 6.920 o di Kg. 7.628 con un contributo medio di L. it. 2,76 e di L. it. 2,99. Le provincie italiane in cui il consunto od il contributo nel 1904-905 furono minimi sono quelle di Teramo con Kg. 5.046 (L. it. 1,94), Ascoli Piceno con kg. 4.937 (L. it. 1,93), Ravenna con Kg. 4.880 (L. it. 1,89), Belluno con Kg. 4.662 (L. it. 1,50). (Cfr. la Relazione e Bilancio industriale dell’azienda dei Sali per l’esercizio dall’1 luglio 1904 al 30 giugno 1905. Direzione generale delle Privativa, Ministero dello finanze, Roma, 1906, pag. 14-15 e 43-45). Nel 1708 il confronto medio per abitante risultava di L. it. 2,85 in Piemonte e di L. it. 3 in Aosta; e quindi all’incirca eguale a quello pagato dagli abitanti delle odierne provincie di Torino e di Cuneo, benché il consumo sia ivi cresciuto all’incirca da kg. 4.20 a Kg. 7.28 per abitante in media, ossia di più dei 70 per cento. È interessante notare come in talune provincie italiane, malgrado il prezzo di tanto minore ed il scemato valore della moneta, il consumo oggi non sia gran fatto superiore a quello del Piemonte di due secoli or sono.
[19]A. S. F. IIa. Capo 57. Lettere diverse, n. 663, dove è contenuto un questionario sulla gabella dei sale, con risposte.
[20]A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, n. 2. Risultato de Congressi tenuti sovra le Gabelle generali.
[21]A. S. F. Ia. Gabelle, Utensiglij e Servizi di Nizza ed Oneglia, M. I, n. 3. Progetti per augumentare il prodotto delle Gabelle et altri redditi di S. M. nel Contado di Nizza.
[22]A. S. F. I. Gabelle generali, M. II. Risultato dei Congressi tenuti sovra le Gabelle Generali.
[23]In data 7 aprile 1704 la Camera dei Conti dà facoltà ad Oliviero e Gamba di vendere in Nizza ed Oneglia sali di Cagliari o Hieres, benché non di ottima qualità; ed il 23 agosto dello stesso anno il conte Oliviero chiedo, e la Camera accorda, il permesso di vendere sali di Portoferraio, benché “abbino la loro imperfezione” non essendo possibile procurarsene dei migliori “a causa delle continue corse che fanno nei mari di Nizza li bastimenti francesi nemici, quali hanno a tal effetto arrestato alcune barche che venivano a detta città di Nizza cariche di sali et intimoriscono le altre che non aderiscono più cimentarsi alli pericoli suddetti”. Cfr. A. S. C. Sessioni Camerali, volume del 1703-1705 alle date sovra indicate.
[24]La memoria a cui accenniamo compresa col titolo Sentimento d’un Ministro Camerale sovra la Gabella del Sale 1711 in un volume contenente diverse scritture sul sale in A. S. M. E. Gabella Sale Piemonte, M. I d’addiziono, n. 5.
[25]A. S. C. Sessioni Camerali, Registro 1700 in 1702, sotto la data del 20 e del 23 dicembre 1700. rispondenza delle voci. Basti qui notare che l-intento della dogana doveva essere essenzialmente fiscale se per le merci non elenmcate nella tariffa, e per cui non si trovasse in altre merci simiglianza di qualità e di prezzi, il dazio era del 3 per cento, trattandosi di materie greggie e del 6 per cento, se di manuffatti, sul valore di stima diminuito (L. it. 18,03) sui cavalli di Regno barberi e spagnuoli, di L. 13.19.1 (L. it. 17,45) sui cavalli di Germania, d’Ungheria e d’Italia, di L. 3.8.10 (L. it. 4,30) sui cavalli e cavalle del Delfinato, oltremontani e circonvicini, di L. 7.5 (L. it. 9,35) sui muli e le mule, e di L. 1.4.2 (L. it. 1,51) sugli asini.
[26]A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, in. 2.
[27]A. S. F. IIa. Capo 48, n. 5, pag. 148.
[28]A. S. M. E. Dugana e tratta, M. I, n. 15. Dimostrazione degli abusi nella tratta delle sete e bovi grassi et de’ spedienti per il sostenimento di questa Gabella che si accensa con la Dugana.
[29]A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, n. 2.
[30]I congressi del 1708, pur riconoscendo l’abuso, raccomandarono di chiuder gli occhi, per non annullare il reddito della gabella. A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, n. 2.
[31]A. S. M. E. Dacito di Susa, M. IV, n. 15.
[32]Il trattato di pace dell’11 aprile 1713 fra Savoia e Francia recò bensì che il commercio ordinario d’Italia dovesse farsi tra Francia e Piemonte, come al tempo di Carlo Emanuele II, per la strada di Susa, la Savoia ed il ponte di Beauvoisin; ma le discussioni rinacquero subito più aspre di prima.
[33]A. S. F. Ia. in Dogana, Daciti, Pedaggi, Tratta foranea ed Ancoraggio, M. I, n. 10 e II a. Capo 57, Lettere diverse, n. 653. Lettere diverse di Mellerede al Groppello del 23 aprile, 5 novembre, 20 agosto 1701, e n. 654, lettera del 16 dicembre 1702.
[34]A. S. C. Inv. Gen. Art. 672, paragrafo 2, Pareri Camerali, n. 26, pag. 189.
[35]A. S. F. IIa. Capo 58, Registro Biglietti S. M. n. 169, 1708 in 1713.
[36]In realtà il prodotto era diverso, perché delle gabelle alienate alla città di Torino più non si teneva memoria nei registri delle Finanze e nei conti camerali. Cfr. A. S. M. E. Gabella carne, corame, foglietta ed imbottato, M. I, n. 11. Però i rischi ed i vantaggi di minori o maggiori proventi effettivi di quelli stipulati spettavano alla città di Torino, cosicché per il fisco l’entrata poteva presumersi fosse quella indicata nel testo.
[37]Cfr. sotto, Cap. IV, paragrafo 54.
[38]Cfr. in A. S. F. IIa. Capo 57. Lettere diverse, n. 662, una lettera del direttore Alessandri da Mondovì al Groppello, del 18 maggio 1710, in cui muovonsi aspre lagnanze contro l’accensatore Borgna, il quale pretendeva imporre canoni esagerati a diverse comunità del Mondovì, malgrado queste protestassero “che nelle Calamità presenti il Popolo chiamava del pane, non curandosi di carne”. L’Alessandri però non diede ascolto al Borgna, rinviandolo per farsi far ragione, se l’avesse avuta, alla Camera dei Conti; e contro alle querimonie del gabelliere, il quale si era lagnato a Torino presso il Groppello di non essere stato aiutato dal rappresentante locale del Governo in un affare di non piccola conseguenza fiscale, opponeva la seguente sentenza, degna di essere qui registrata, a testimonianza dell’indole della burocrazia sabauda nel primo settecento: “È ordinario ch’ognuno si dolga del Direttore quando non lo vol assistere nelle cose ingiuste”.
[39]Tariffe e condizioni sono ricavate dagli editti ed ordini del tempo, contenute nei titoli XXXVIII e XXXIX del D. XXIV.
[40]Cfr. su questi abusi D. XXIV, 1052; A. S. M. E. Dogana e tratta, M. I, n. 18 ed ivi Gabella carne, corame, foglietta ed imbottato, M. I, n. 11 e 15. “Ricavo delli abusi che seguono in Torino contro la Gabella generale delle carni e corami a causa de macelli privilegiati”
[41]A. S. F. Ia. Gabelle generali, M. II, a. 2.
[42]Son conservate in A. S. M. E. Gabella carne, corami, ecc., M. I, n. 11.
[43]Pare che le carni tassate dalla gabella fossero le carni macellate dedotta la pelle e le interiora; poiché i capitoli del 30 marzo 1699 al n. 9 prescrivono che le bestie bovine si dovessero pesare in quarti “con le loro lingue, grasse, li loro fegati, corade e teste sganazzate, levato il copetto, e con li piedi ancora, ove essi piedi si vendano per gionta, esclusi però li grassi e socii che saranno attaccati agli intieri”. Per i maiali, non potendosi utilizzare le pelli, era prescritto che dovessero pesarsi aperti, con le teste, piedi et interiora, detratte solamente le budella”. Probabilmente per interiora si intendono le parti interne dell’animale, e non quelle parti che ora diconsi interiora e che detraevansi, a quanto si può supporre, insieme con le budella. Cfr. D. XXIV, 1049.
[44]Precisamente 48.866 abitanti risultano pel 1702-1703 dalle anagrafi municipali riassunte dal Castiglioni. Cfr. G. Prato, Censimenti e popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII, in Rivista Italiana di Sociologia, anno X, 1906, pag. 355.
[45]Questi dati ricavansi da una pubblicazione sui Progressi igienici, sanitari e demografici della città di Torino, compilata a cura del medico capo dei servizi d’igiene e sanità, dott. F. Abba. Il dott. Abba, riferendosi pel 1905 ai dati citati nel testo e pel 1797 a notizie del Vernazza, nota un aumento nel consumo della carne bovina per individuo utilizzante (2/5 della popolazione effettiva, dedotto 1/7 per i bambini fino ad 8 anni, i malati, i poveri, ecc.), da Kg. 32.22 nel 1797 a Kg. 58,31 nel 1905, aumento che proverebbe le migliorate condizioni odierne della popolazione torinese. Noi non abbiamo modo di studiare criticamente il valore dei dati del Vernazza; ma certa cosa è che i dati nostri el 1699 – 1700 sono tratti da fonti ufficiali sicure, e peccanti, al più, in meno; cosicché, i dati del Vernazza, se esatti, dimostrerebbero un grande peggioramento nelle condizioni dell’alimentazione carnea dei torinesi, durante il secondo XVIII. Ma forse il 1797, come tutti quelli dal 1793 in poi, fino al rinfrescarsi del dominio francese, è un anno eccezionale, in cui per le miserie della guerra, il rialzo straordinario dei prezzi e la gravezza dei tributi, il consumo della carne ebbe a diminuire oltre misura, sicché il paragone con anni di pace non riesce agevole.
[46]Cfr. D. XXIV, 862 e segg., dove sono riprodotti i capitoli dell’editto 14 gennaio 1720, che però sono in tutto simili a quelli del manifesto camerale dell’8 maggio 1702, da’ quali era ai tempi nostri retta la materia in discorso.
[47]I dati sono ricavati dall’Annuario del Municipio di Torino per 1903-904 (p. 310) e pel 1904-1905 (pag. 130).
[48]Secondo le citate statistiche municipali nol 1902/904 si sarebbero introdotti in media dal di fuori 6026 ettolitri di spirito, circa litri 1.75 a testa, ed ettolitri 6107 di birra, uguali a litri 1.77 a testa.
[49]A. S. M. E. Gabelle del tabacco e dell’acquavita, M. I, n. 17. Progetti dati dal Chrostofor per un nuovo accensamento delle Gabelle del tabacco, carte, tarocchi et acquavita.
[50]A. S. F. I a. Gabelle generali, M. II, n. 2.
[51]Cfr. la Relazione e Bilancio industriale dell’azienda dei tabacchi per l’esercizio dall’1 luglio 1904 al 30 giugno 1905. Direzione generale delle privative. Ministero delle finanze, Roma, 1905, pag. IX, XIII, XIV.
[52]A. S. M. E. Gabelle del tabacco ed acquirente M. I, n. 17.
[53]A. S. C. Sessioni Camerali, Registro 1702-703, in dato 13 febbraio 1703.
[54]A. S. C. Pareri Camerali, n. 45, pag. 124.
[55]A. S. F. I a. Gabelle generali M. II, n. 2.
[56]A. S. C. Sessioni Camerali, Registra del 1700-702, sotto li 2, 15 e 23 dicembre 1700. Cfr. anche EINAUDI, B. e C. T. 1700-713. Tabelle I, II, III.
[57]A. S. C. Pareri Camerali, n. 26, pag. 109.
[58]A. S. C. Ordini Camerali n. 121, pag. 49 e segg.
[59]Cfr. in A. S. C. Pareri Camerali, n. 46, pag. 8, una curiosa filippica della Camera dei Conti contro i fabbricanti di vetri, segnati a dito come devastatori dei boschi piemontesi.
[60]Cfr. su questa controversia tra la Camera e il Duca, i documenti riportati in D. XXV, da pag. 681 a 689.
[61]Ciò nel 1708. Cfr. A. S. F. IaGabelle generali, M. II, n. 2.
[62]A. S. C. Pareri Camerali, n. 45, pag. 124.
[63]La quale, in avviso a S. A. R. del 27 agosto 1699, oltre ad arguire l- illegalità della concessione perché lesiva dei diritti acquisiti per contratto del 15 aprile 1696 da certo Carlo Amedeo Grattapaglia sulle giocate di Genova, così stigmatizzata l’introduzione del giuoco del seminario a Torino, dopo ché altrove (e specie nel Milanese) era stato proibito: “Il giuoco del Seminario è … riconosciuto molto pregiudiciale in riguardo massime che serve di incentivo a chi ha il denaro di divertirlo da buoni usi et a chi non l’ha di procacciarselo con mezzi illeciti e con grave discapito delle famiglie per poterlo applicare a detto giuoco, cosa che convenientemente non deve introdursi e molto meno automatizzarsi da noi magistrati”. Cfr. A. S. C. Pareri Camerali, n. 45, pag. 51.
[64]A. S. F. IIa, capo 40, n. 6, Registro Memorie e Contratti, dal 1703 al 1708, fol. 104 recto; ed A. S. C. Inv. Gen. art. 687, paragrafo Provisioni, n. 134 (1702/706), pag. 149.